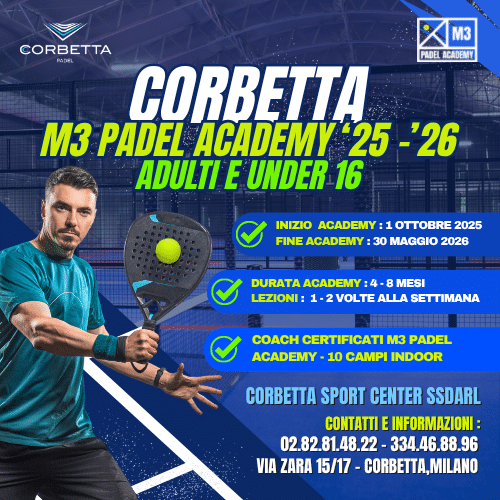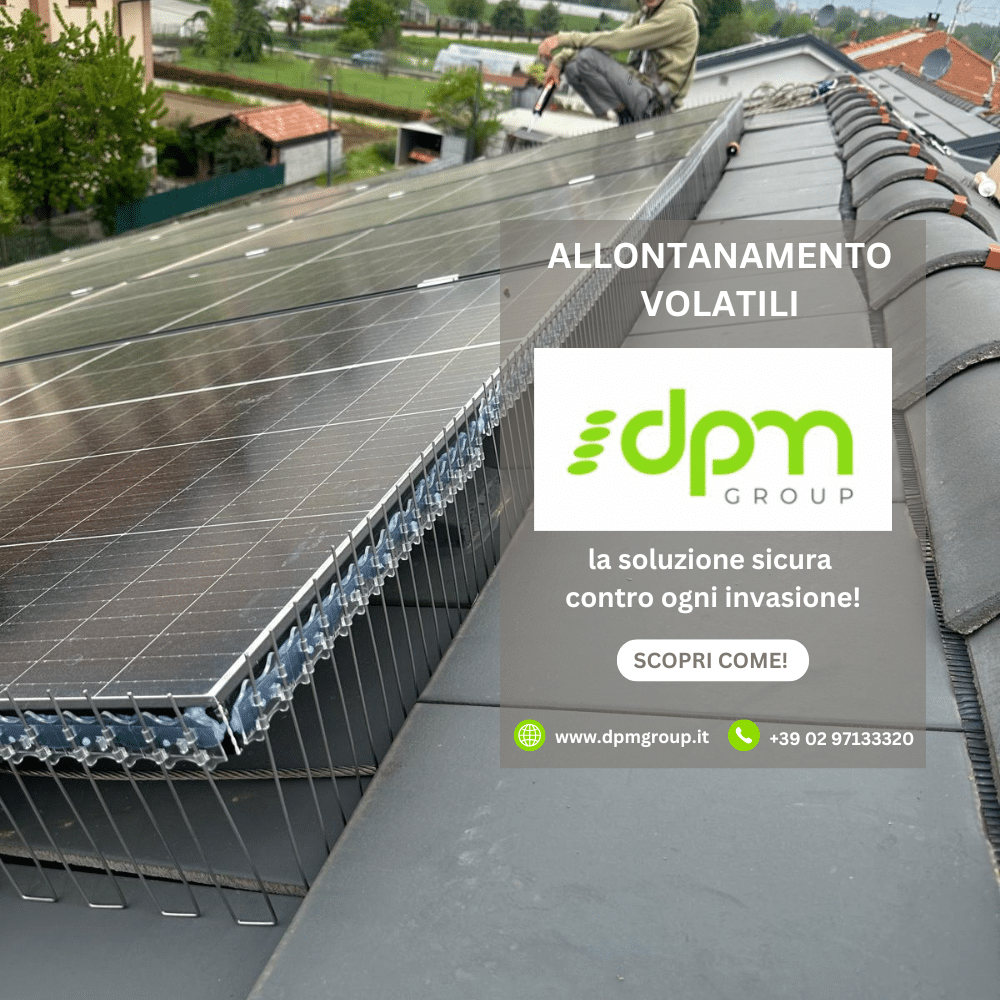Il talento, e nel suo caso ce n’è a dismisura, è ovviamente ingrediente fondamentale per raggiungere traguardi epocali nel professionismo più elitario, ma ad essere meno scontato è il fatto che ciò sia condizione necessaria ma niente affatto sufficiente allo scopo, al punto che il mondo dello sport è pieno di storie di enormi capacità tecniche rimaste inespresse. A far di Sofia Goggia una campionessa difficilmente eguagliabile, quindi, è la stessa cifra stilistica di coloro i quali di una disciplina, sebbene non l’abbiano inventata, hanno contribuito ad alzarne il livello, tanto che se solo l’Unesco avesse a cuore lo sci alpino la includerebbe nella lista dei patrimoni dell’umanità. Trattasi del rigetto feroce del concetto di sconfitta, atleti che nel vocabolario quotidiano non includono per genetica il contrario di vittoria. Quelli come Sofia, pertanto, o vincono o migliorano.
Ieri ha vinto – successo numero venticinque in Coppa del mondo a meno tre dai ventotto di Brignone, sempre a proposito di fenomeni – ma quello numerico non è l’aspetto più importante, del resto ci ha abituato bene. La pedagogia goggiana discende decisamente più dal ‘come’ che dal ‘quanto’ ed il ‘come’ racconta la favola di una campionessa già pluridecorata, con in bacheca tutto ciò che si possa ambire a vincere con gli sci ai piedi e di un’età non più giovanissima se contestualizza allo sport, che a valle dell’ennesimo grave infortunio decide che il tempo di lasciare gli onori alle altre colleghe non è ancora stato scritto. Fratture multiple ad una gamba è la sintesi efficace di un bollettino medico che dieci mesi fa l’ha forzata ai box e ad una riabilitazione lunga ed estenuante, di quelle che costringono la psiche ad un surplus di lavoro difficilmente quantificabile da chi non ci è mai passato. Insomma, per non mollare tutto, ancor di più se l’apice in passato è già stato esplorato e con la fame allmeno teoricamente in fase calante, serve una motivazione con la quale si sposterebbero financo le montagne.
Prendere l’impossibile e attribuirgli il significato speculare quando si è rimasti in pochi a crederlo, è ciò che fa di ottimi atleti i campioni di razza. Franco Baresi, per esempio, che si immagina di poter disputare da protagonista la finale del mondiale di soccer americano a due settimane da un’artroscopia al ginocchio e ci riesce, nonostante lo sfortunato epilogo. O Pirmin Zurbriggen che, dopo aver lasciato il ginocchio sulla mitica Streif di Kitzbuhel, venti giorni più tardi nei Mondiali di Bormio fa due ori e un argento domando la Stelvio, il posto meno accomodante al mondo per testare la tenuta delle proprie articolazioni. Due delle tante vicissitudini di ontologica testardaggine sportiva, di campioni, appunto, che disconoscono la possibilità di non essere gli unici artefici del proprio destino. Testa, cuore e gambe.
Il secondo posto di sabato, nel giorno del tanto agognato rientro alle gare, sebbene non lo ammetterà mai è stato per lei motivo di profondo incazzamento. I pochi centesimi che l’hanno separata dalla vincitrice, Cornelia Huetter, le hanno probabilmente dato parecchio fastidio perché giù dalla Birds of Pray di Beaver Creek, a trecentodiciotto giorni intercorsi dall’ultima esibizione, si immaginava di riprendere il filo del discorso proprio da dove l’aveva bruscamente interrotto. Il gradino più alto del podio di una disciplina, la discesa, che è il suo giardino di casa, un vestito che le sta cucito addosso quanto i prati di Wimbledon impreziosiscono il profilo di Roger Federer. Allora, che ventiquattro ore più tardi, questa volta al cancelletto del supergigante, l’occhio fosse, se possibile, ancora più felino non deve stupire, i fuoriclasse fanno così: migliorano, appunto. Alla sempre magnifica Lara Gut, perciò, è toccato cedere il passo ad una Sofia che ad ogni curva pareva scrollarsi di dosso, una per una, la centinaia di ore spese in palestra per riattaccare la spina. Uno spettacolo.
Bergamasca, terra di ciclisti e sciatori, figlia di Giuliana, professoressa, ed Enzo, ingegnere, ha iniziato a sciare giovanissima sulle nevi brembane di Foppolo, quella care ad Adriano Celentano e Mike Bongiorno, all’età di tre anni. Passione inesauribile e qualità cromosomiche da predestinata, Sofia ha fatto il suo esordio nel circuito FIS nel 2007, una vita fa, e la sua prima vittoria nel circuito mondiale, sempre in quanto a longevità, risale al 2017 quando a Pyeongchang-Jeongseon si è imposta sia in discesa che in supergigante in una stagione poi chiusa al terzo posto della classifica generale. Da lì, alle già citate vittorie e ad un numero inesausto di podi, Sofia può sommare quattro medaglie tra Olimpiadi e Mondiali e quattro Coppe del mondo in discesa libera. Numeri eccezionali che senza la malaugurata costante degli infortuni avrebbero potuto essere addirittura più abbondanti e ciò rende plasticamente l’idea della sua grandezza di sciatrice.
Cadere e rialzarsi più forti di prima, una delle banalità meno banali da rendere sostanza. Sofia, sempre per quel fuoco che non si spegne mai, si è dovuta rialzare tante volte con l’asticella posizionata in ogni circostanza un centimetro più in alto di prima. È la volontà di migliorarsi pur guardando già tutti dall’alto, quella di farsi trovare al cancelletto con una freccia nuova nella faretra, quella che fa dell’umiltà il vero ‘asso nella manica. In altre parole, essere campioni. Allora, bentornata Sofia. In un noto claim di qualche lustro fa, l’immenso e compianto Jonah Lomu scriveva sullo schermo con un pennarello ‘impossible is nothing’, lui che, noncurante di una malattia degenerativa ai reni per la quale i dottori pronosticavano una vita senza placcagi e sgroppate, ad ogni stop in ospedale ritornava in campo e la faceva vedere brutta a tutti quanti. Perché, appunto, niente è impossibile, nello sport e nella vita del quale è meraviglioso paradigma. Sofia Goggia in quest’ultimo weekend ce lo ha ricordato per l’ennesima volta. Ringraziarla è il minimo.