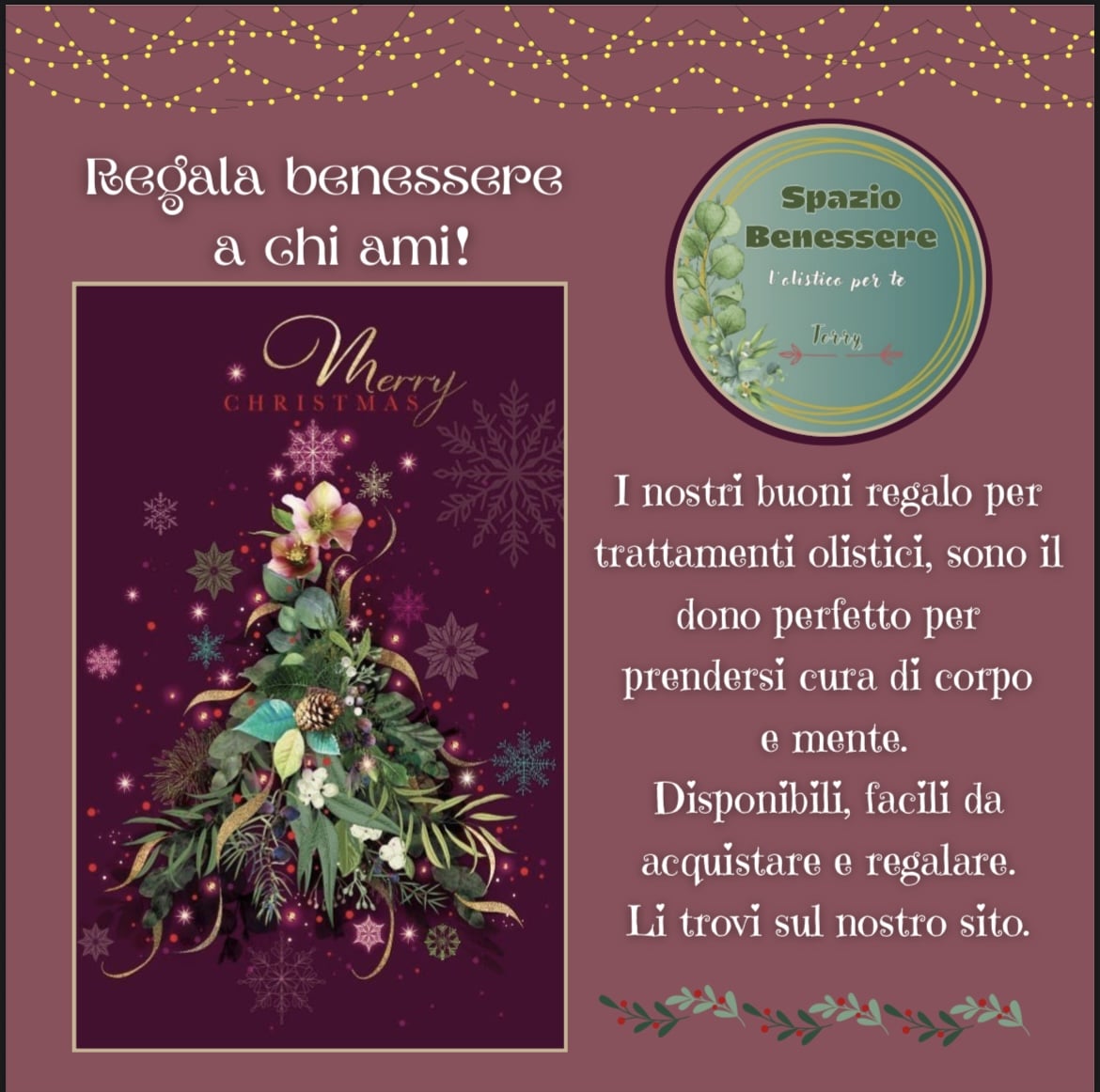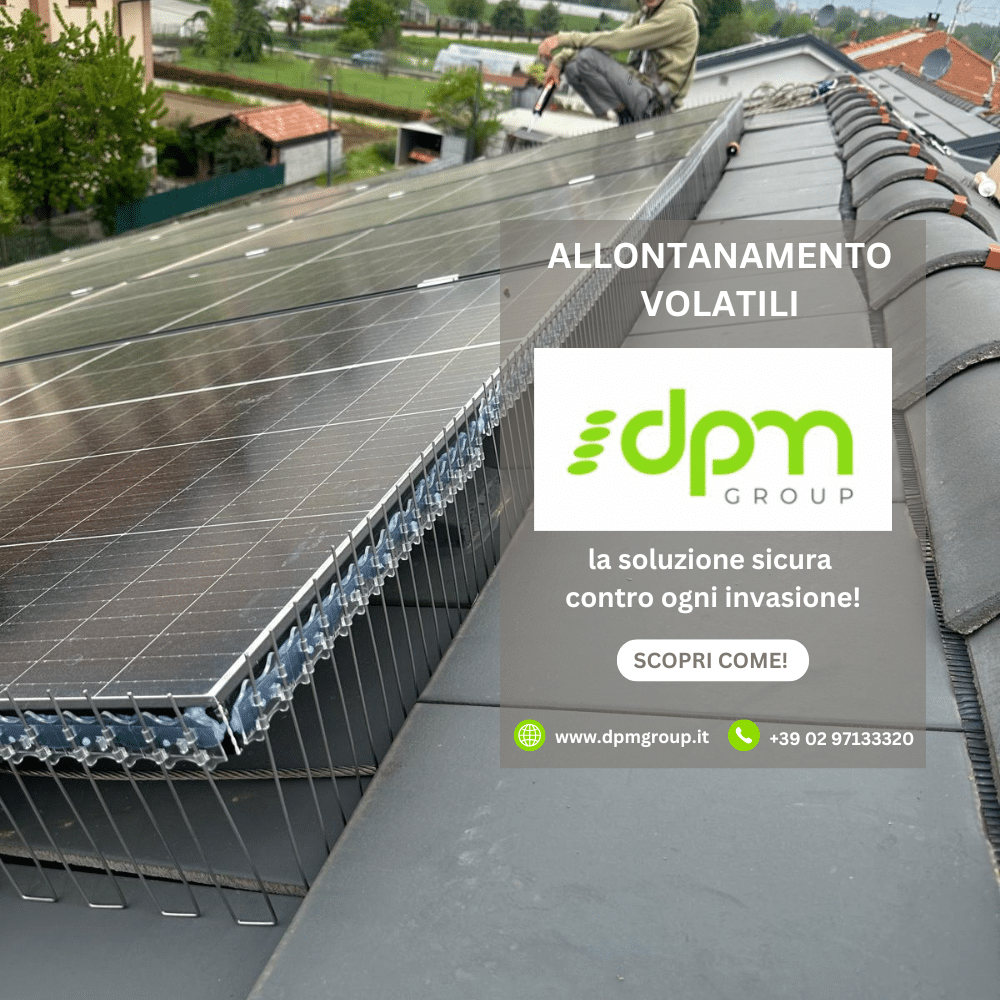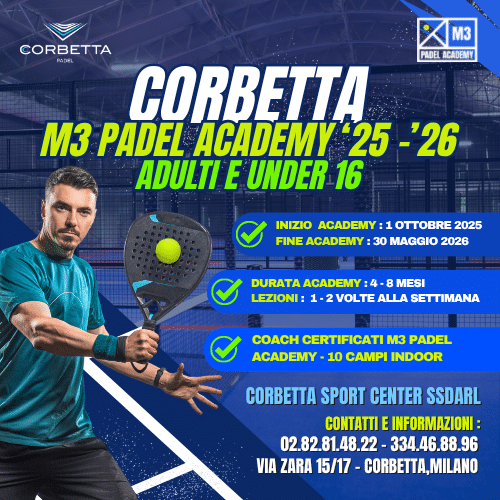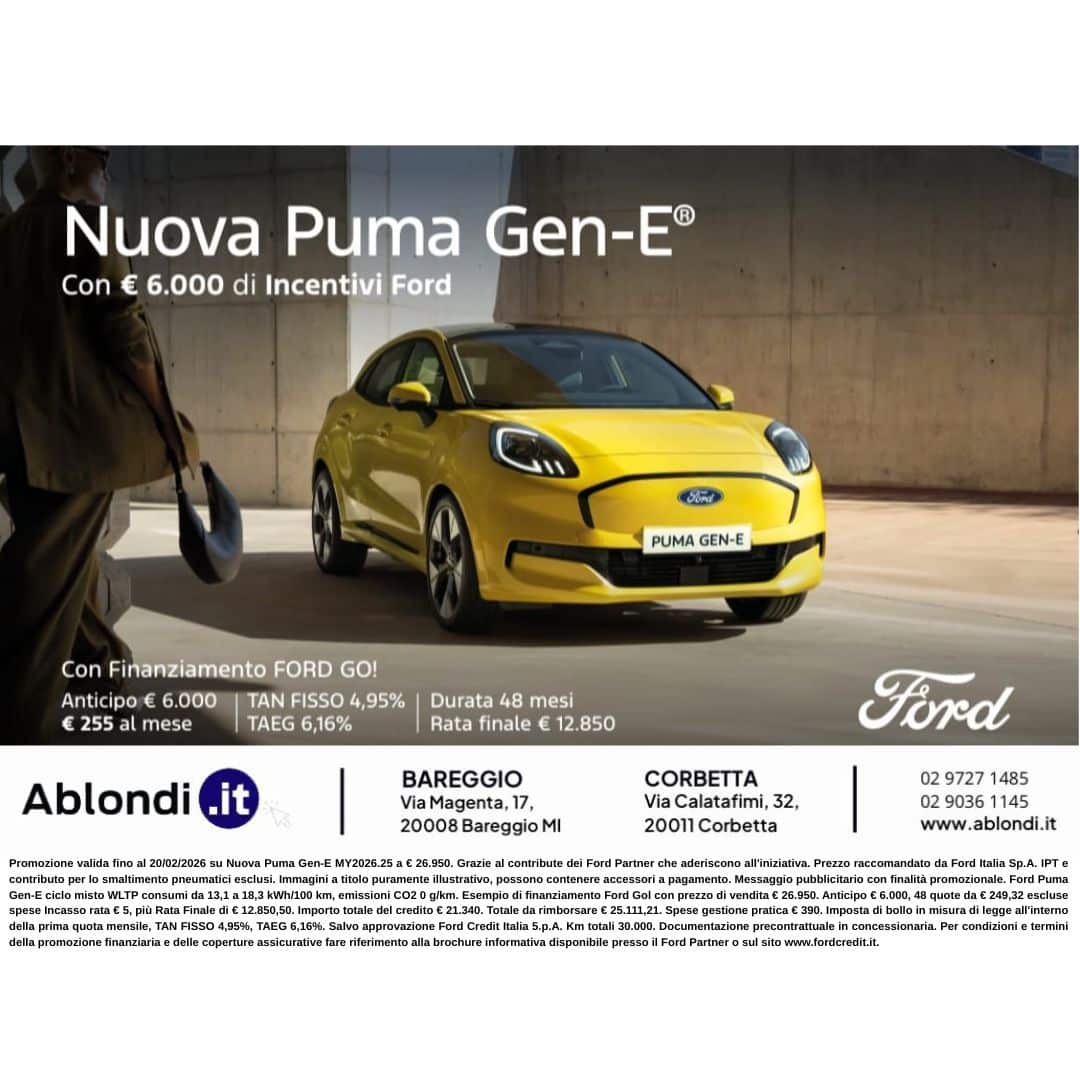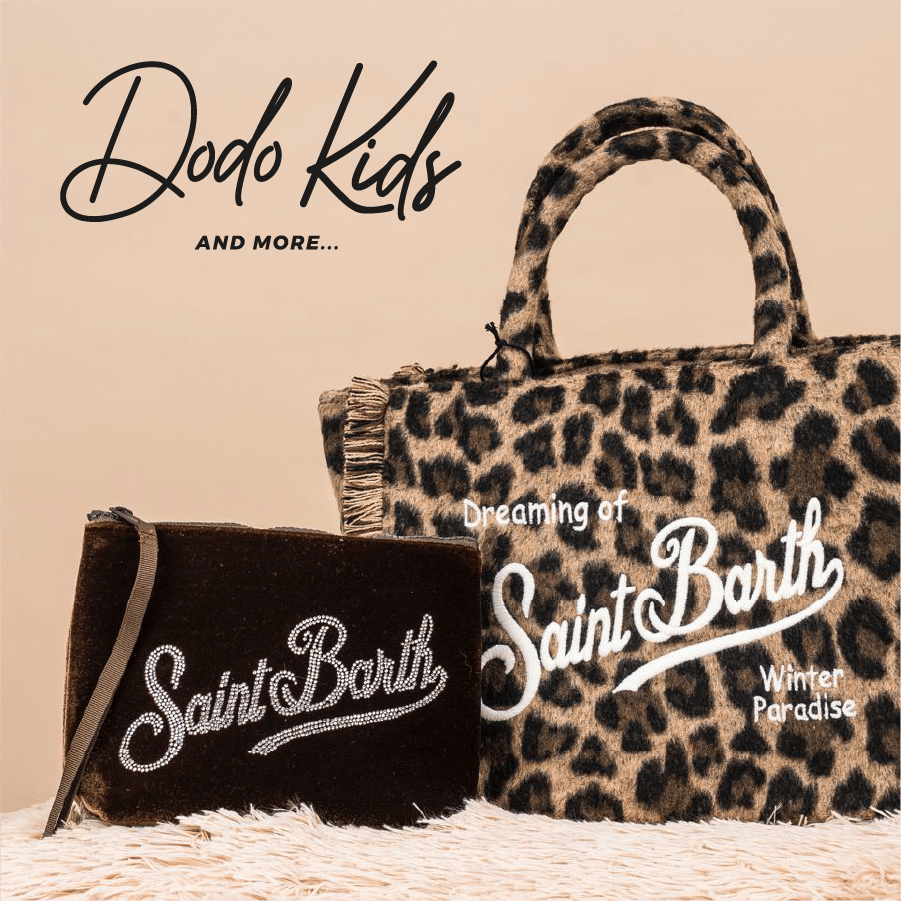Merita davvero una visita la mostra dedicata all’artista Leonora Carrington, ospitata al Palazzo reale di Milano sino all’11 gennaio 2026.
Pittrice, scultrice, scrittrice e illustratrice, la Carrington dipinse quadri frutto di un sincretismo che comprende gnosticismo, buddismo tibetano, spiritismo, cabala, magia, alchimia, tarocchi, cosmologia, mitologia; dipinti che incantano e rapiscono l’osservatore, facendolo entrare in un mondo misterioso ed arcano, frutto delle sue esperienze e di una vita turbinosa che nella prima parte la portò a spostarsi spesso. Ma vediamo di conoscerla un poco.
Nata nel 1917 nella contea del Lancashire, Leonora Carrington crebbe in un ambiente borghese che le offrì una solida istruzione familiare, nutrita anche dai racconti magici della tata e della madre irlandese che le narrava miti celtici, storie di spettri e leggende dell’isola come quelle del fetch, ovvero il nostro doppio che ci può apparire la mattina o la sera (e che ritroviamo nei dipinti); o come quelle del Sidhe ovvero il popolo fatato che dopo l’arrivo degli inglesi, che avevano idee politiche e religiose differenti, si nascose in un mondo sotterraneo per non scomparire, e lì dedicarsi alla magia e all’alchimia.
Leonora bambina, aiutata anche da autori quali Swift e Carroll, iniziò così a sognare questo mondo pieno di creature magiche che, nella prima parte della sua carriera, verranno rappresentate nella fiabesca serie di acquerelli Sisters of the moon che trova spazio nelle prime sale della mostra. Divenuta adolescente, poiché doveva avere un’educazione consona la suo ceto alto borghese, fu mandata in collegio e poi in vari istituti, dai quali sarà sempre espulsa per il suo carattere ribelle che non tollerava le regole, infatti, si chiedeva perché ai suoi tre fratelli erano permesse cose che a lei erano proibite.
Fu così che a quindici anni venne spedita a studiare arte a Firenze, dove si innamorò della pittura tardo gotica di Paolo Uccello e del Sassetta; tanto che, comprendendo essere l’arte il suo mondo, quando tornò in patria, si iscrisse alla Chelsea School of Art di Londra, e fu in quella città che si avvicinò al gruppo dei Surrealisti, grazie al quale conobbe Max Ernst che, sebbene avesse quarantasei anni, si innamorò di lei nemmeno ventenne, attratto dal fascino della donna bambina.
Forse per lei Max sostituiva la figura paterna che le era sempre stata ostile per via della sua irrequietezza; sta di fatto, che nell’estate del ’38 si trasferirono a Saint Martin d’Ardèche, un villaggio provenzale, e lì vissero il loro paradisiaco rapporto dipingendo e ricevendo gli amici surrealisti; ma lei non si definirà mai tale, perché preferiva essere indipendente e femminista, visto che i surrealisti, come ad esempio Breton, ritenevano le donne, tutt’al più muse, ma non artiste.
Scoppiato il secondo conflitto mondiale i francesi, in guerra coi tedeschi, arrestano Ernst e lo deportano in un campo di concentramento per stranieri. Ciò spaccherà la coppia e Leonora, consigliata da alcuni amici, sola e abbattuta, lasciò la Francia con un permesso di espatrio per raggiungere la Spagna, dove giunse coi nervi a pezzi e segni di squilibrio mentale, tanto che i suoi genitori diedero il permesso di farla internare in un manicomio di Santander dove la giudicarono pazza, e dove fu costretta a subire le terribili cure inflittele dal dottor Morales, uno psichiatra franchista.
Nel ’41 riuscì a sottrarsi a quelle torture solo con la fuga che la portò a Lisbona, dove rivide Ernst scoprendo che nel frattempo si era sposato con la collezionista Peggy Guggenheim. Il destino le permise però di conoscere il diplomatico messicano Renato Leduc che la sposò, procurandole in tal modo l’immunità diplomatica, e insieme raggiunsero New York, luogo in cui vissero diciotto mesi e dove ebbe la soddisfazione di vedere alcune sue opere esposte in un paio di mostre.
Nel 1942 la coppia si trasferì a Città del Messico, dove frequentò un gruppo di artisti, soprattutto surrealisti, e lì conobbe Frida Kahlo che, come lei, non si considerava veramente parte di quel movimento artistico. Quattro anni più tardi Leonora si innamorò di un fotografo ungherese amico di Robert Capa: Chiki Weisz e divorziò dal marito e si risposò con lui, da cui ebbe due figli, che furono ispirazione di suoi nuovi lavori. Vivrà in Messico il resto della sua esistenza, creando innumerevoli opere, spegnendosi nel 2011 alla veneranda età di novantaquattro anni.
Ma cosa emerge dalla visione delle sue opere che fanno pensare anche a Hieronymus Bosch per la presenza di personaggi bizzarri, talvolta metà umani e metà animali, di creature eteree come elfi e gnomi, di animali di fantasia, che popolano luoghi onirici, ctoni o in interni di case, mischiando così realtà e irrealtà?
Le tele più mature raccontano il suo sradicamento dall’Europa, il suo voler superare il trauma del manicomio; sono viaggi nell’anima alla ricerca di un nuovo sé, viaggi della disgregazione e della rinascita che la conducono alla nascita della sua identità artistica. Le sue tematiche riguardano il desiderio che l’androcentrismo venga superato e si arrivi all’unione degli opposti maschio e femmina, e questo emerge dalle sue figure androgine ed è simboleggiato ermeticamente anche da quei pavimenti a scacchi la cui ispirazione le venne da quelli dei dipinti italiani del XIV e XV secolo che tanto ammirò nel suo viaggio giovanile a Firenze.
I suoi soggetti ammiccano alla rivalutazione del matriarcato che vigeva millenni fa e questo lo si vede nelle tele con le riunioni di streghe; indicano inoltre che la Carrington sosteneva la trasmissione di una conoscenza e di un sapere matrilineare, ed emblematico è il suo dipinto Grandmother moorhead’s aromatic kitchen dove la cucina, sul cui tavolo stanno un peperone, agli, pannocchie e melanzane diventa un laboratorio alchemico tutto femminile. A tutto ciò dobbiamo aggiungere che alla si sentiva una sorta di Artemide in grado di comunicare con gli animali che, tanto quanto gli esseri umani, hanno il diritto di esistere su questa terra.
È una femminista che non ha remore nel mettere in discussione ogni certezza, nel dire che tutte le religioni descrivono la donna come un essere inferiore e stupido rispetto all’uomo, e quindi vuole rivalutare le donne creando una sorellanza universale che le veda unite non solo per una riconsiderazione sociale, ma anche come salvatrici della Terra, che il genere maschile sta conducendo alla distruzione totale; infatti, lei stessa disse: “Se tutte le donne del mondo decidessero di controllare la natalità, di respingere la guerra, di rifiutare la discriminazione di sesso o razza, e così costringessero gli uomini a permettere alla vita di sopravvivere sul nostro pianeta, questo sarebbe davvero un miracolo”.
https://www.palazzorealemilano.it/mostre/leonora-carrington
Leggete e regalate i miei romanzi storici per fare un viaggio nel tempo.
A cura di Luciana Benotto