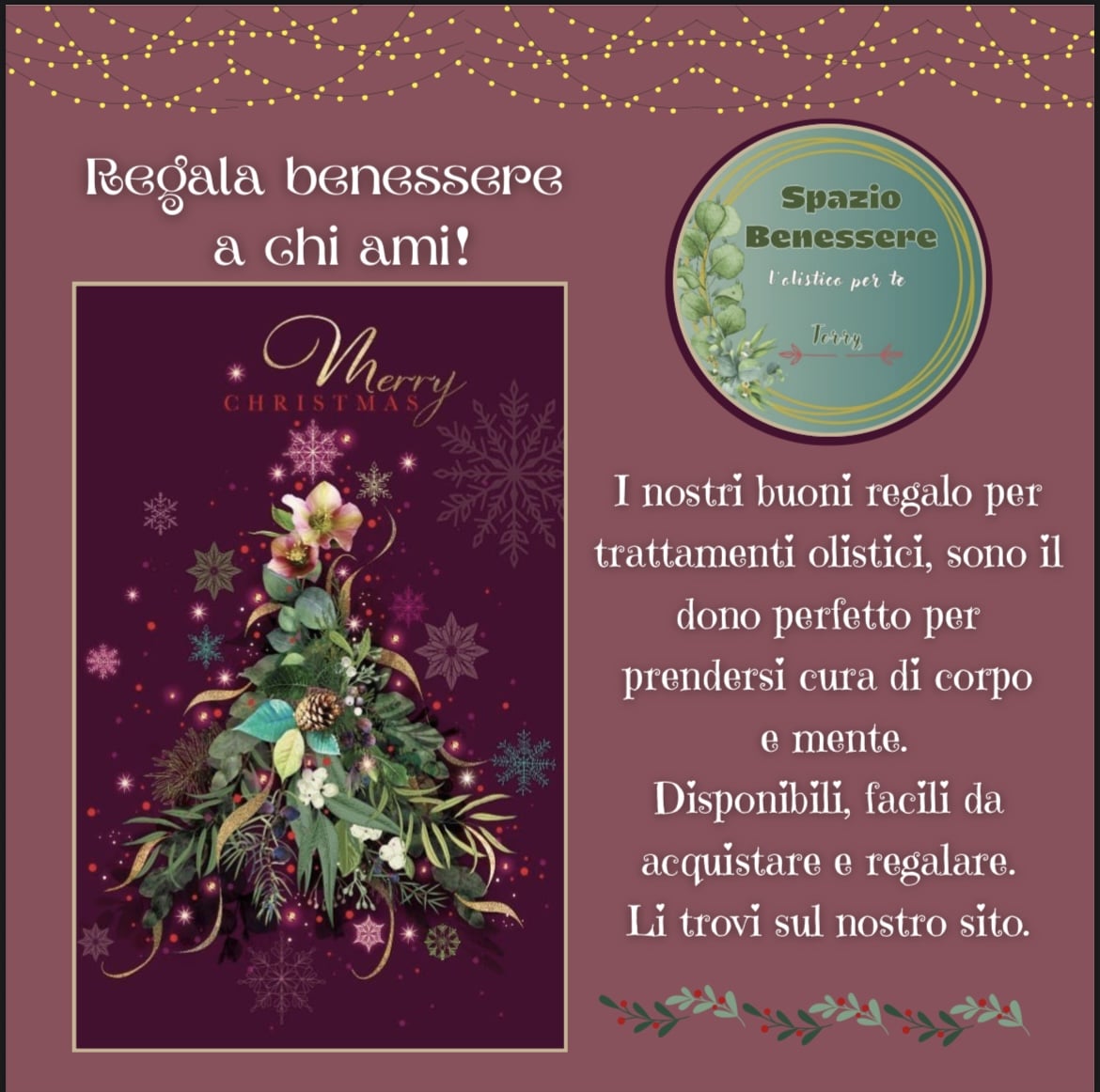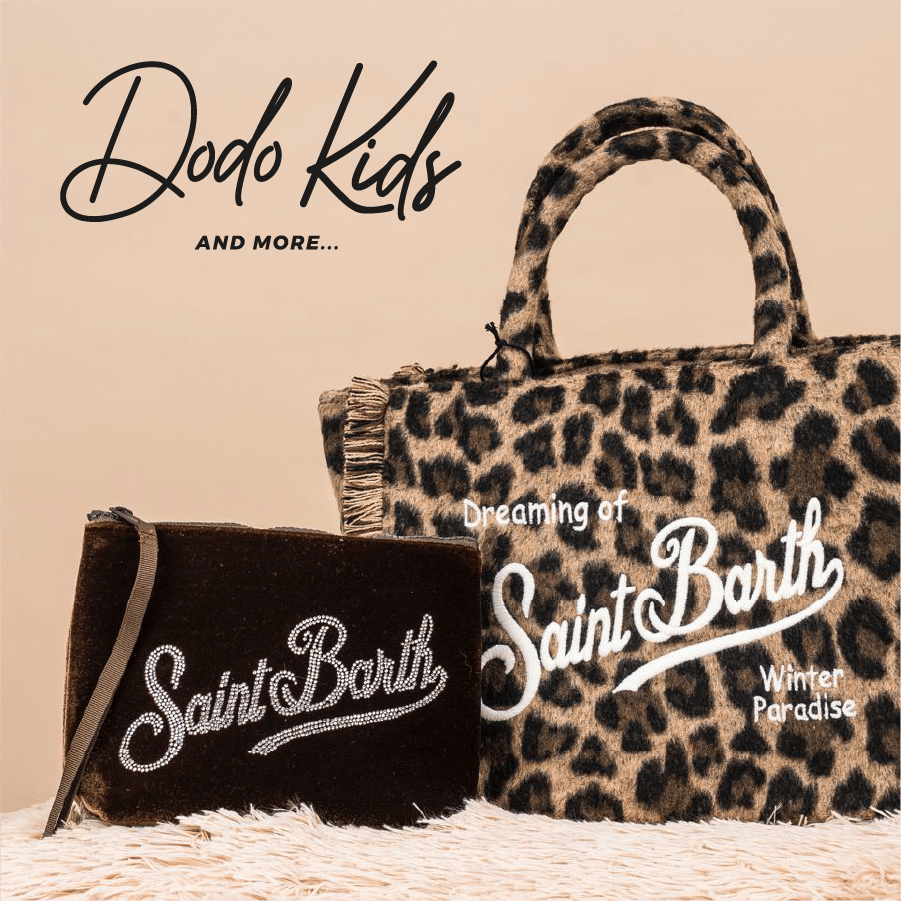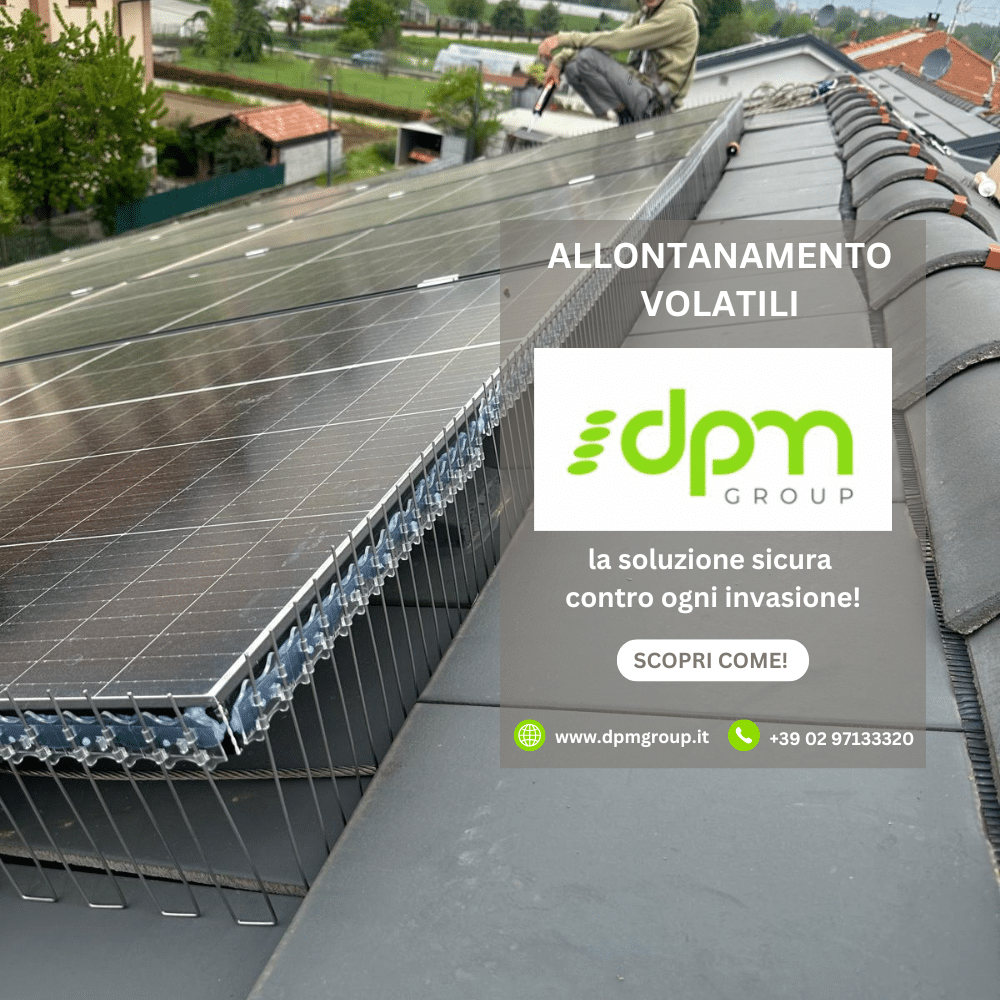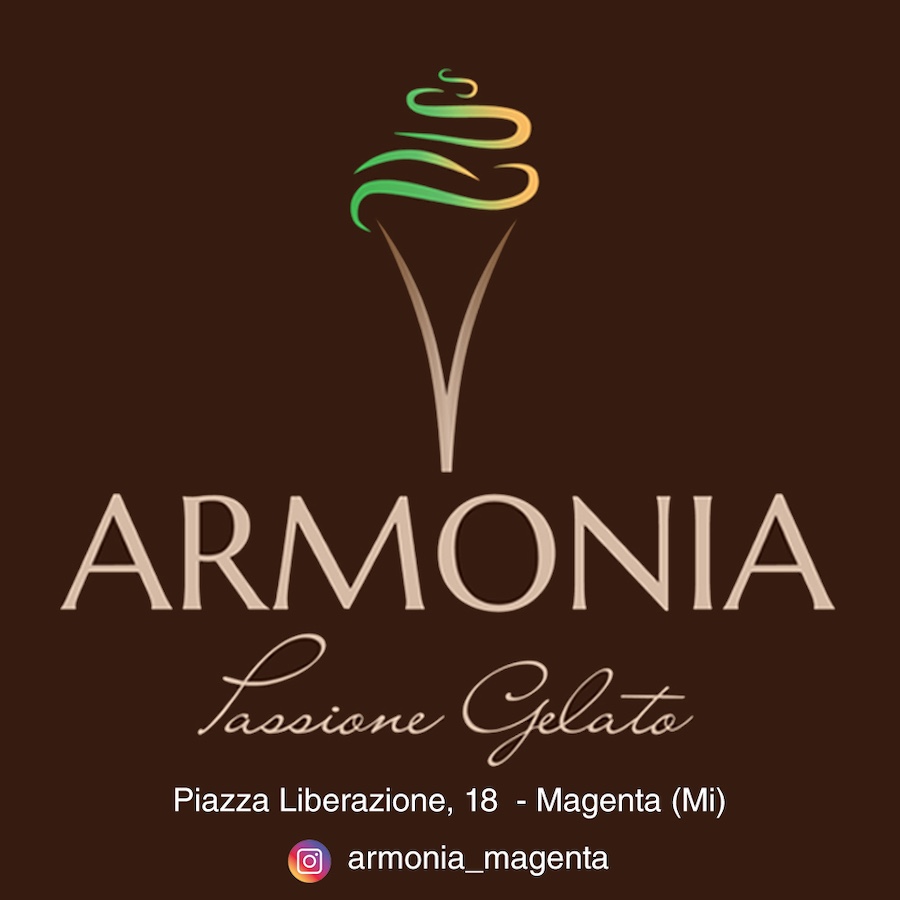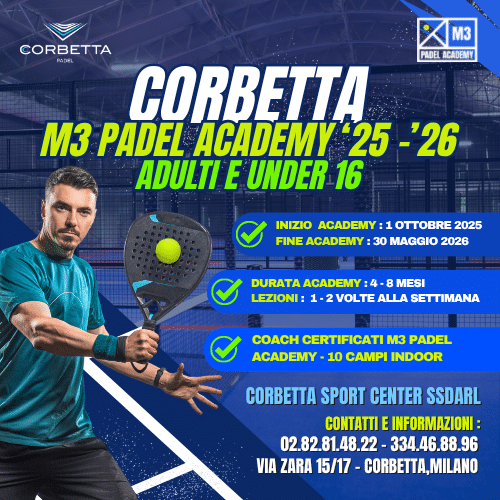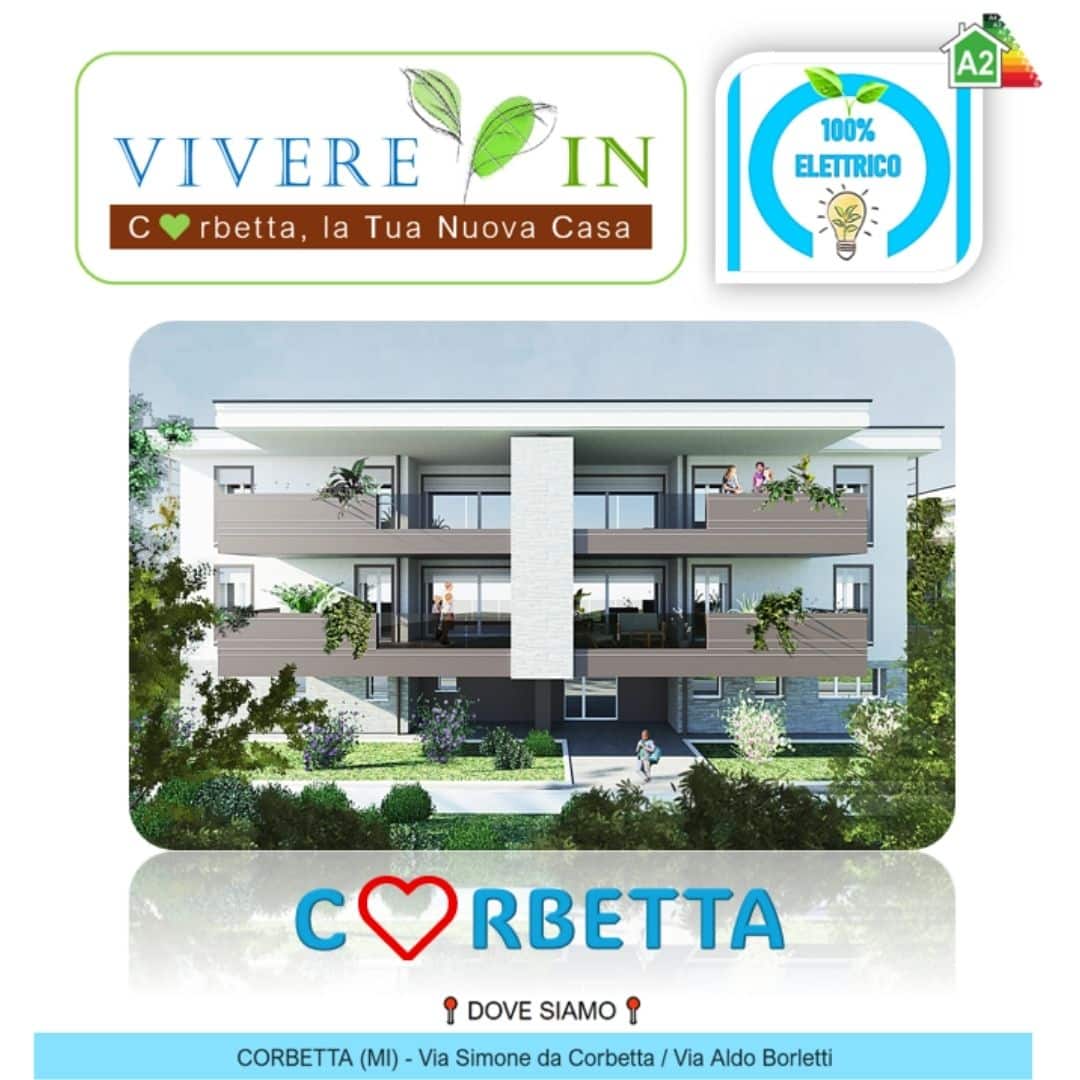Ci fu un tempo, per nulla lontano, mentre scrivo l’ho dinnanzi dispiegato in quella armonia orale e visiva di cui la memoria è prodigio, che al solo nome di ‘Giovanni Drogo’, espresso ad alta voce, subito di rimando, qualcuno all’interno dell’ambiente, andava esclamando a ferma risposta: ‘i tartari!’.
Milano, il 28 gennaio del 1972, moriva Dino Buzzati. Già il bigio al primo mattino e la pioviggine di quel livido tanto Milano dal cielo grigio che fa plumbea la Madonnina, di quella temperatura in caduta tra i quattro e cinque gradi, da cappotti con il bavero alzato e le spalle incassate; lungo le strade, i corsi, le vie, ruota la bava di vento che da Levante, l’aria prediletta da Re Salomone, apre al profondo settentrione, già al mezzodì nevica, quella neve fitta, a falde larghe che s’attacca, abbarbica e trasfigura il Duomo in gugliate di Dolomiti.
Moriva. Ed era l’autore di quell’incantesimo. Che poi, un allora quattordicenne sapesse appena dei tartari sarebbe parsa impresa, giustappunto l’approssimazione di tartari e mongoli e un nome: Gengis Khan, quel terribile, che nella paginata a colori pieni del ‘Conoscere’ (Fratelli Fabbri editori) era dipinto a mefistofelico ghigno di barba e baffi e ciuffo a lunga criniera, sull’impennata dell’imperiale cavallo bianco, in un tripudio di corazza dorata e sciabola e arco e frecce, circondato dalla sua turba, a lui eguale, lungo i contrafforti dei gran deserti d’oriente.
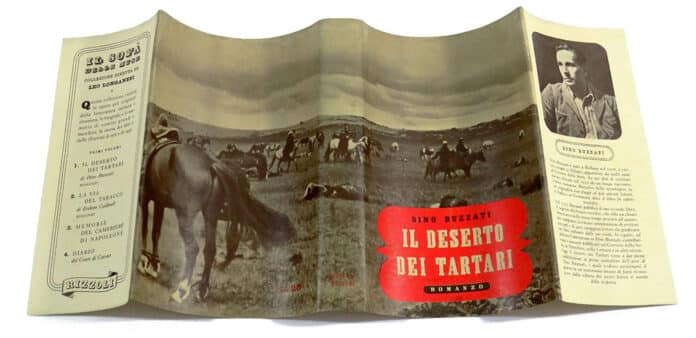
Figuriamoci nel 1940, anno in cui uscì “Il deserto dei Tartari” per la Rizzoli. Buzzati aveva trentotto anni, cronista al Corriere della Sera da sedici, ed il titolo che aveva in mente sarebbe stato “La fortezza”, ma, Leo Longanesi (1905 – 1957; geniale uomo di lettere, scopritore di talenti, di cucina tipo-lito-fotografica, la Longanesi editrice ancora vive, e della “fronda” che indirizza così: “Credi ma disubbidisci”) lo cambia innestandolo così in quell’universo parallelo che è l’immaginazione e quindi la coscienza. Chi è senza immaginazione non ha coscienza, si potrà ben scrivere. “Il deserto dei Tartari” in quel 1940 ebbe poca fortuna e punto gloria. Se si cerca sull’anno, in giro per il globo terrestre, c’è del buono: “Buio a mezzogiorno” di Arthur Koestler che vedrà la lingua italiana nel 1946; “Per chi suona la campana” di Ernest Hemingway, nel 1945; “Il potere e la gloria” di Graham Greene, nel 1945. Tra i titoli pubblicati in lingua nostra nell’anno si legge un buon Scerbanenco “Sei giorni di Preavviso”; Agatha Christie con l’azzimato “Poirot non si sbaglia”; Rex Stout con “Nero Wolfe e sua figlia”. Alla radio tengono frequenza il Trio Lescano e Alberto Rabagliati. Al Cinema i registi Carmine Gallone, Alessandro Blasetti, Roberto Rossellini, la diva Clara Calamai, tra gli attori Amedeo Nazzari, Vittorio De Sica che si fa le ossa per andare a guadagnarsi poi nel dopoguerra i suoi 4 Oscar da regista, roba da levarsi in piedi all’istante; Gino Cervi poi Peppone e Maigret. Presidente del Consiglio Benito Mussolini e l’Italia il Regno coronato da Vittorio Emanuele III.
Dunque, quando esce “Il deserto dei Tartari” per i tipi della Rizzoli, le truppe del millenario Reich entrano a Parigi e per leggerne le gesta, in riga letteraria, occorrerà attendere il 2005 quando viene pubblicato “Suite Francese” (Adelphi edizioni), strepitosa presa diretta, di Irene Nemirovsky scritto sul tamburo di quei giorni e, lei presto incenerita al campo polacco di Auschwitz, cristallizzato nella catacomba di una valigia da poco prezzo. Ma i morti risorgono, e infatti. Dunque, e ancora, il 18 giugno “l’appello alla nazione”, Italia in guerra. “Il deserto dei tartari” non esce dall’ombra. Farà capolino nel 1945, ripubblicato da Mondadori. Il 26 aprile dell’anno il ‘fondo’ del Corriere della Sera è suo: “Cronaca di ore memorabili”. E la trottata di Giovanni Drogo, il protagonista del “Deserto”, prende l’abbrivio sino ai giorni nostri e agli altri già in coda. L’avrà letto e riletto e squadernato Valerio Zurlini (1926 – 1982), regista, quando nel 1976 lo traduce nel film omonimo, cast magniloquente italo franco tedesco, musica di Ennio Morricone. È un successo, in Francia un grande, grande successo. Già, Dino Buzzati è amatissimo in Francia, tanto che i ‘cugini’ lo adottano, se lo naturalizzano stella della loro Pleiade. Monsieur le President Francois Mitterand (1916 – 1996), finissimo uomo di lettere (ah! la Francia, che smacco costante alle nostre plaghe) lo candida al Nobel per la letteratura. Non ne sortirà nulla, ma che importa, è comunque in buona compagnia, un nome per tutti? Jorge Luis Borges, e così sia. Dino Buzzati, costante, lavora al Corriere, nerista per passione, cronista privo di quello snobismo che fa tanto intellettuale da provincia. Lo scrittore è già sepolto da decenni quando, nel 1993, Ermanno Olmi traduce in omonimo film: “Il segreto del bosco vecchio”, suo secondo romanzo, Treves editore poi Mondadori.

E Mario Brenta, nel 1994, traduce il suo primo del 1933: “Bàrnabo delle montagne”, dapprima Treves editori poi Mondadori. È uno scrittore di successo. Il suo “Sessanta racconti”, si aggiudica ‘Lo Strega’ del 1958. E in “Un amore”, romanzo del 1963, Mondadori, anch’esso in traduzione cinematografica omonima per la regia di Gianni Vernuccio nel 1965, si legge il preludio dell’ondata orgiastica consumistica che spazza, per sempre, il vecchio mondo. Nel 2010 il suo corpo riesumato, cremato e le ceneri disperse sulla Croda da Lago delle Dolomiti. Un legato testamentario eseguito che sigilla il suo essere misterioso, silenzioso, solitario, parco di convivialità, tra i pochissimi amici il suo più caro Indro Montanelli. Era alla ‘Madonnina’, la clinica, quel 28 gennaio, ed alla mattina aveva chiesto alla giovane moglie di fargli la barba ché la morte lo trovasse in ordine e aggiunse all’amico in visita: “è strano, morirò entro sera, eppure se il direttore mi chiedesse un articolo glielo scriverei”. Se n’è andò sorridendo: “così alla Buzzati che alla Buzzati potrebbe anche tornare”, scrisse il giorno appresso il fucecchiese. Nei fatti è ritornato. Ieri pomeriggio, quando ho scritto di getto l’impalcatura di questa nota, stavo spendendo due parole con il libraio lì in via Canonica, al fondo della stessa, angolo via Cagnola, all’ultimo piano di un palazzone da cinque piani, l’appartamento dove il Buzzati visse un decennio. Lo visitai, tempo addietro, complice la generosa accoglienza del proprietario, inalterato quel cantuccio del terrazzo dove osservava i tetti e la vita dalle finestre della Milano prendendo qualche nota che poi si trasfigura. Beh, stavo giusto sulla porta quando al “permesso” mi scosto lasciando pertugio ad una signora in milanesissimo visone a tra quarti d’antan, che, dall’affabilità al gestore si dimostra habitué. Che ha il nipote quattordicenne colto da una influenza di quelle “spesse, da starsene a letto bello e tranquillo” e lei ha in animo di portagli via il telefonino e “tutte le baggianate del tictoc”. E domanda, se per caso lo tiene in “cascina”, che nel milanese sta per magazzino. Il libraio le risponde che nei suoi scaffali, finché lui vive, “Il deserto dei Tartari” è testo d’obbligo. “Poca spesa tanta resa”, dirà la signora infilandolo nella borsa, un coccodrillo dalle placche prossime al secolo, aggiungendo “piuttosto che niente glielo leggo io ad alta voce”. Ed è andata così. Io mi sono trovato catapultato in quel crinale di gennaio del 1972, anch’io febbricitante, a letto. Con la compagnia di Giovanni Drogo del “Deserto dei Tartari”, che mi aveva acquistato il mio buon vecchio padre a viatico. Mai un’influenza fu tanto meravigliosa.
Emanuele Torreggiani