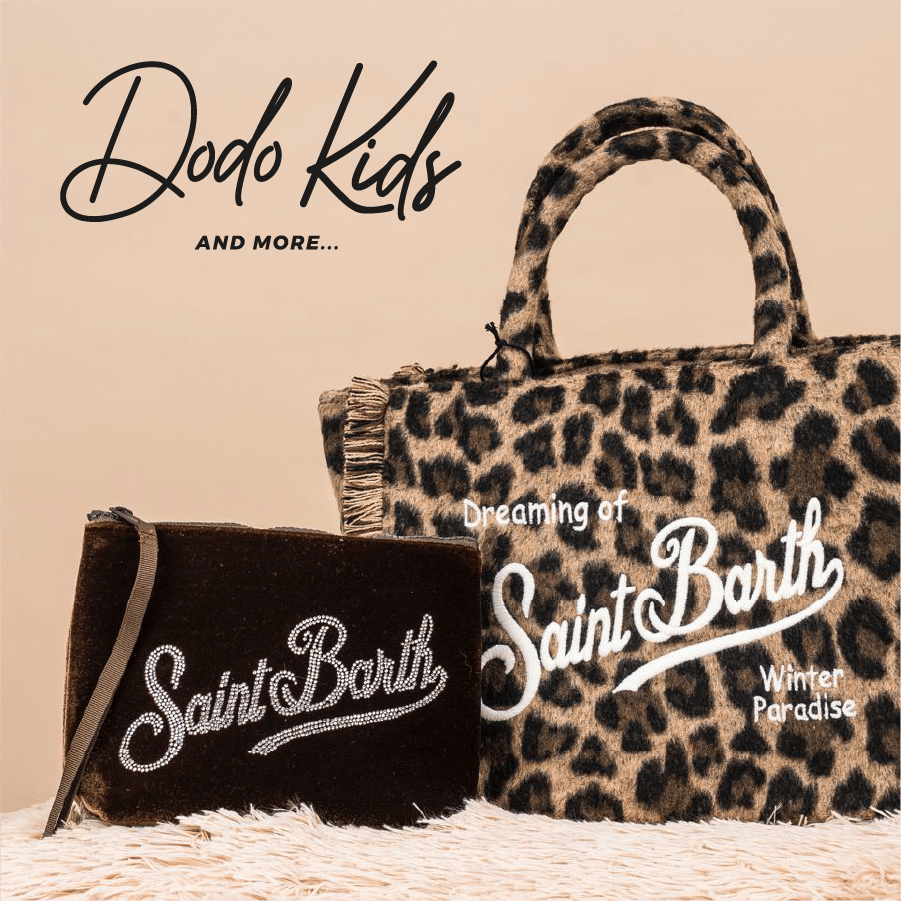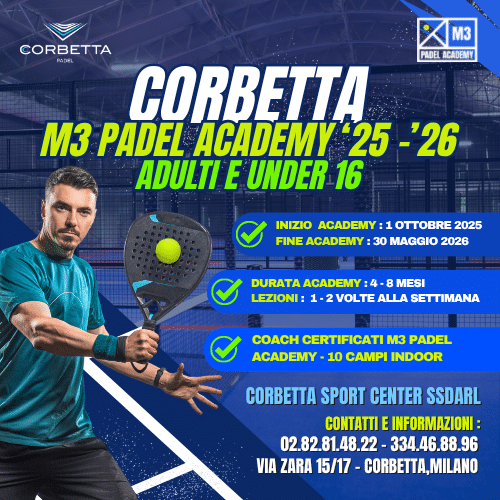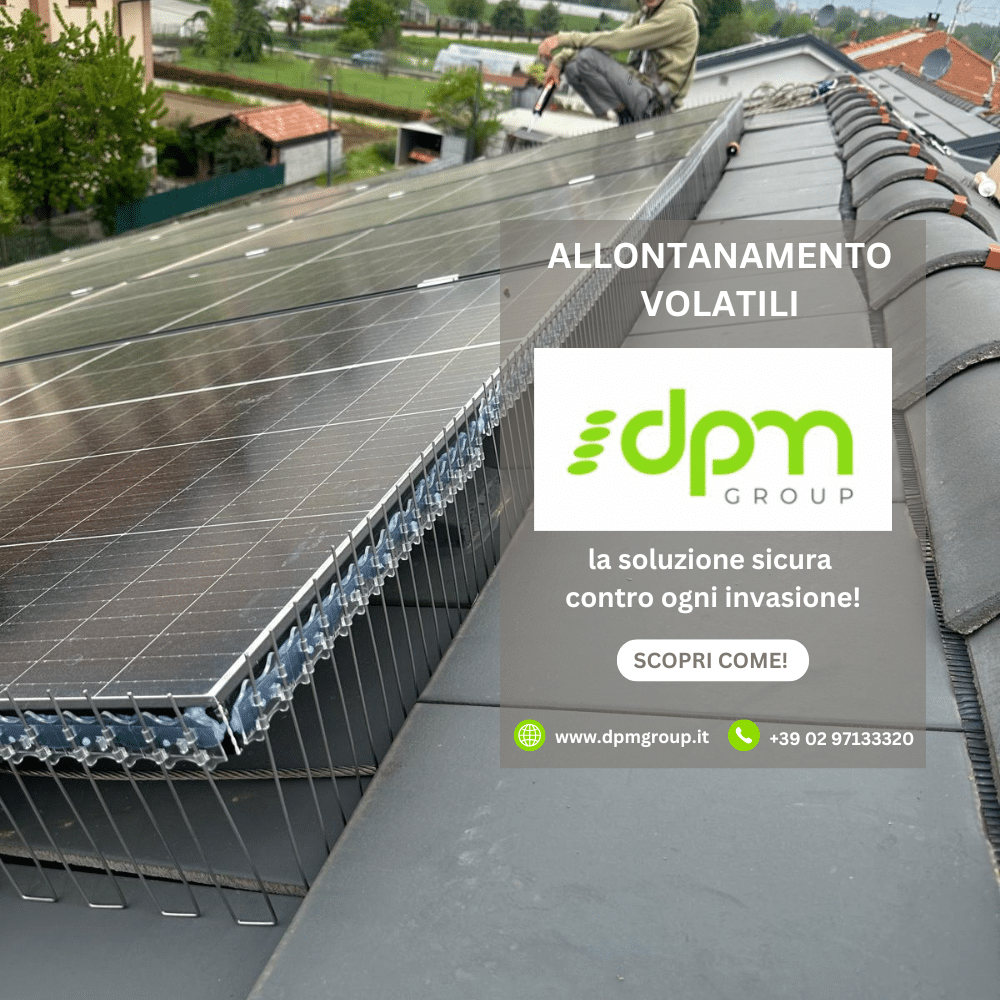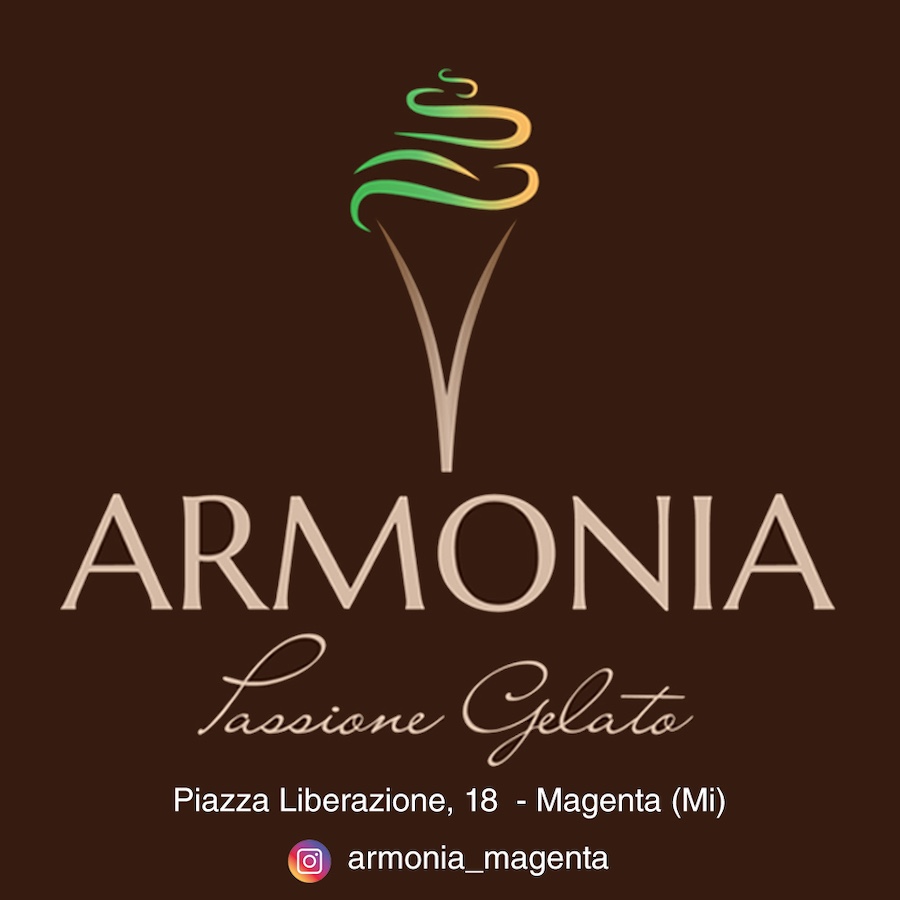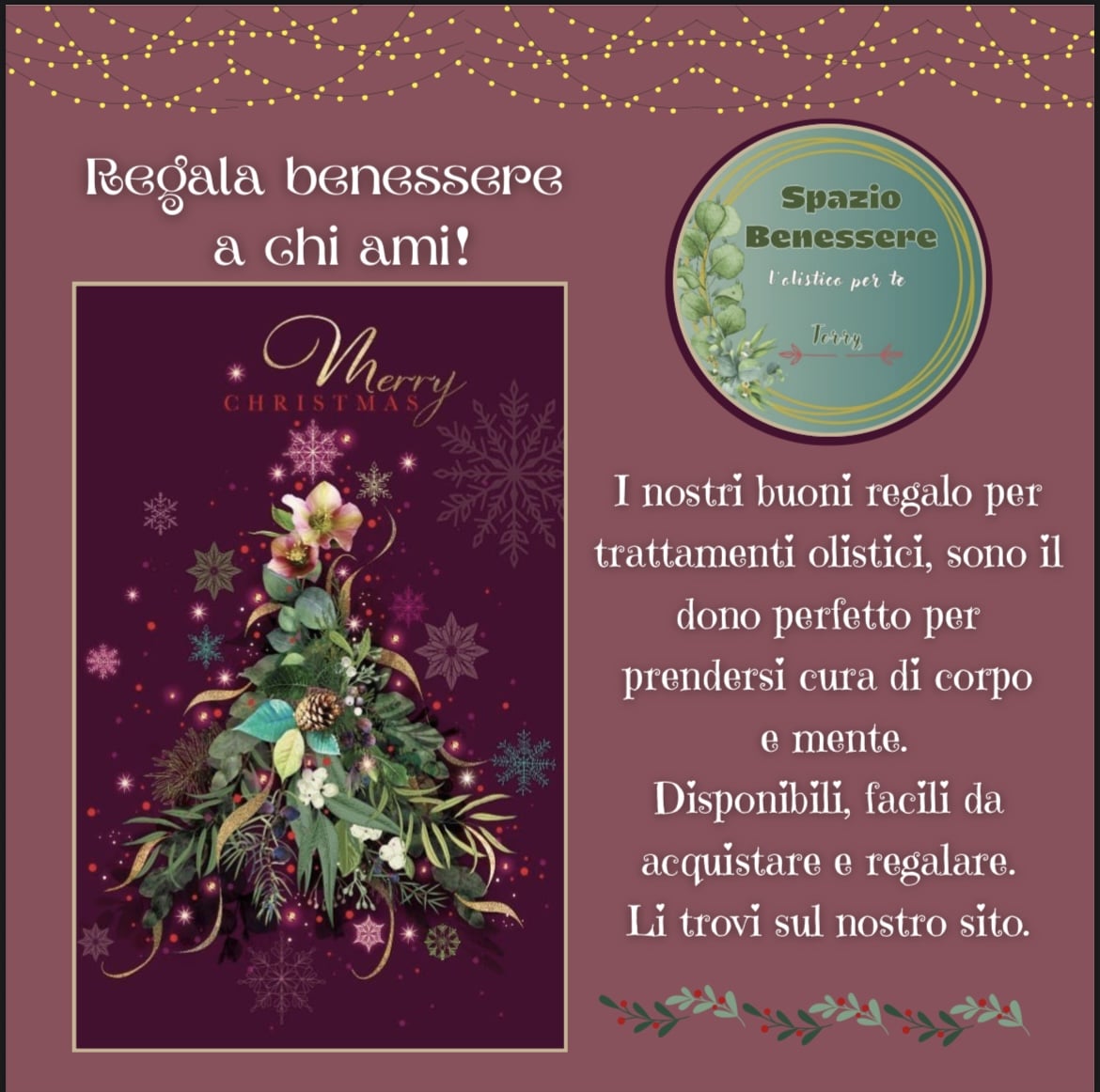RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Il tema del nuovo centro commerciale ad Abbiategrasso è strettamente legato a posizioni ideologiche. Il “si” o il “no” alla sua costruzione, oltre che su considerazioni contingenti (il possibile impatto negativo sugli esercizi commerciali del centro) si basa su divergenze politiche, a volte di puro principio, prive di un’approfondita analisi storico-urbanistica. Eppure i grandi centri commerciali modificano profondamente il tessuto sociale dei centri urbani e producono effetti sulle comunità che li abitano. Quella che segue è la sintesi di un lavoro di ricerca svolto nel 2019 con un gruppo di miei alunni dell’Istituto Bachelet, teso ad analizzare i rapporti delle grandi strutture commerciali con i temi dell’architettura, dell‘urbanistica e della socialità. È forse utile ripercorrerne i passi salienti, in modo che la forte divisione politica accolga in sé una visione più ampia.
L’urbanistica contemporanea ha spesso prodotto risultati contraddittori, amplificati da un globalismo culturale volto alla riproduzione di forme sganciate dai contesti sociali. È singolare il caso di Chongqing, agglomerato urbano cinese fra i maggiori del mondo, nel quale è stato edificato un centro commerciale che replica, in scala uno-uno, San Gimignano, uno dei siti medievali più belli d’Italia. Essendo un enorme mall, la San Gimignano cinese non ospita abitanti ma solo migliaia di clienti.
È un fenomeno, quello dell’erosione del tessuto sociale a favore di enormi spazi di vendita, diffusissimo anche nel nostro Paese, a ridosso delle città e delle province, e che sta progressivamente trasformando i cittadini in anonimi avventori di “non luoghi”.
Gli amministratori pubblici e i politici locali hanno certamente responsabilità notevoli nella diffusione di questo fenomeno, spesso legato a un’idea di sviluppo economico poco lungimirante e destinato all’obsolescenza. Il convegno “RoweRome”, tenuto alla Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma nel 2017, ha mostrato decine di esempi di shopping malls americani che, dopo il fallimento, hanno lasciato il posto a quartieri normalissimi, in una sorta di ritorno all’ordinario dopo l’indigestione di forme mastodontiche di consumo.
Ma anche gli architetti e gli urbanisti sembrano avere le loro responsabilità. Nel Rinascimento e nel ‘600 ad essi veniva richiesta una responsabilità etica, tesa al rispetto del paesaggio che via via andavano rimodulando. Oggi le grandi opere architettoniche, comprese quelle delle “archistar”, appaiono spesso monumenti autoreferenziali, lucidi manufatti calati in dimensioni parallele, slegati dal contesto identitario dei territori. È il caso dei super-grattacieli, simboli di un potere tutto economico, o, appunto, dei grandi centri commerciali, straordinarie opere di tecnologia e di design decontestualizzate rispetto al paesaggio naturale e culturale circostante.
L’effetto di questa tendenza è di rendere sempre più residuali gli spazi dei centri storici, ridotti progressivamente a zone franche ad uso turistico, defraudate della produzione identitaria della comunità. Al contempo, le periferie si estendono in base a principi sostanzialmente economico-finanziari, producendo spazi disarticolati, zone sempre più ampie di vuoto sociale e culturale.
Fra i centri storici ridotti a piccole disneyland e la periferia estraniante, si colloca quello che l’architetto olandese Rem Koolhaas ha battezzato junkspace, zone grigie in perenne mutamento, architetture urbane nelle quali, in tempi relativamente brevi, una stessa porzione di spazio può passare da libreria a pub, da filiale bancaria a palestra fitness. Il junkspace garantisce indotti economici appetibili dalle amministrazioni comunali ma anche un’erosione progressiva dell’identità sociale.
L’intreccio di una visione globale e locale, che chiameremo glocale, dimostra che non è attraverso la costruzione di questi mastodontici centri commerciali che il tessuto sociale di una città rimane coeso, e soprattutto che la desertificazione dell’ambiente cittadino da essi prodotta ostacola la crescita umana delle nuove generazioni, che di tutto avranno bisogno tranne di un ennesimo gigante del consumismo di massa.
Lo studio realizzato coi ragazzi è confluito in una brochure dal titolo “Abbia3grasso”, che è un gioco di parole nato dall’individuazione di tre luoghi del nostro territorio dove sarebbero possibili progetti di riqualificazione (l’ex fabbrica Siltal, l’area umida e la cascina Prinetti, al confine fra il territorio abbiatense e quello magentino). Non entrerò, qui, nei particolari di queste ipotesi progettuali. Mi limiterò a segnalare che in tutti e tre i casi gli studenti hanno immaginato luoghi di lavoro interconnessi con la città di Milano, manifestando la volontà di sprigionare le loro energie creative in progetti inediti, con possibili indotti economici e culturali. Non ho dubbi che le loro istanze, nella rincorsa di un’economia tutta basata sulle sfavillanti luci del nuovo centro commerciale, non troveranno spazio d’ascolto. Per cui possiamo concludere, parafrasando il titolo di un famoso film, che Abbiategrasso “non sarà un paese per giovani”.
Silvano Brugnerotto
Docente di Disegno e Storia dell’Arte
IIS Bachelet – Abbiategrasso