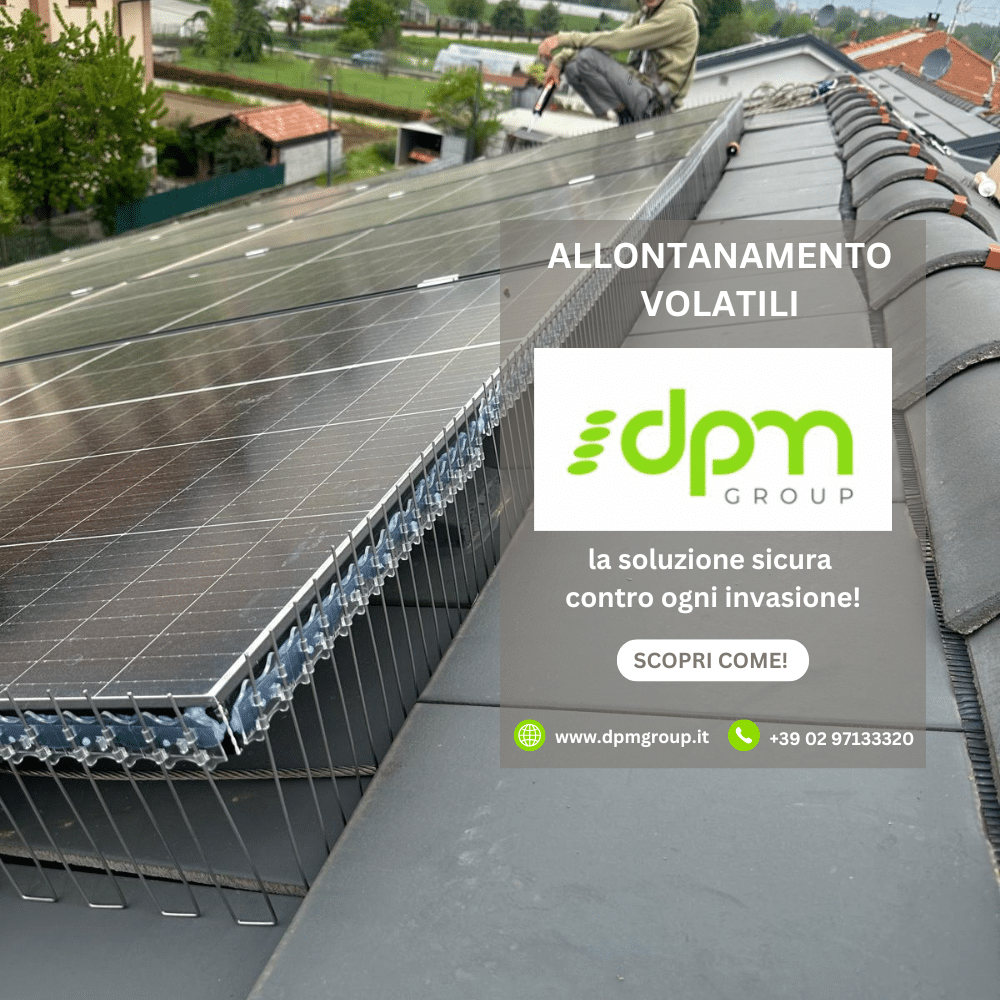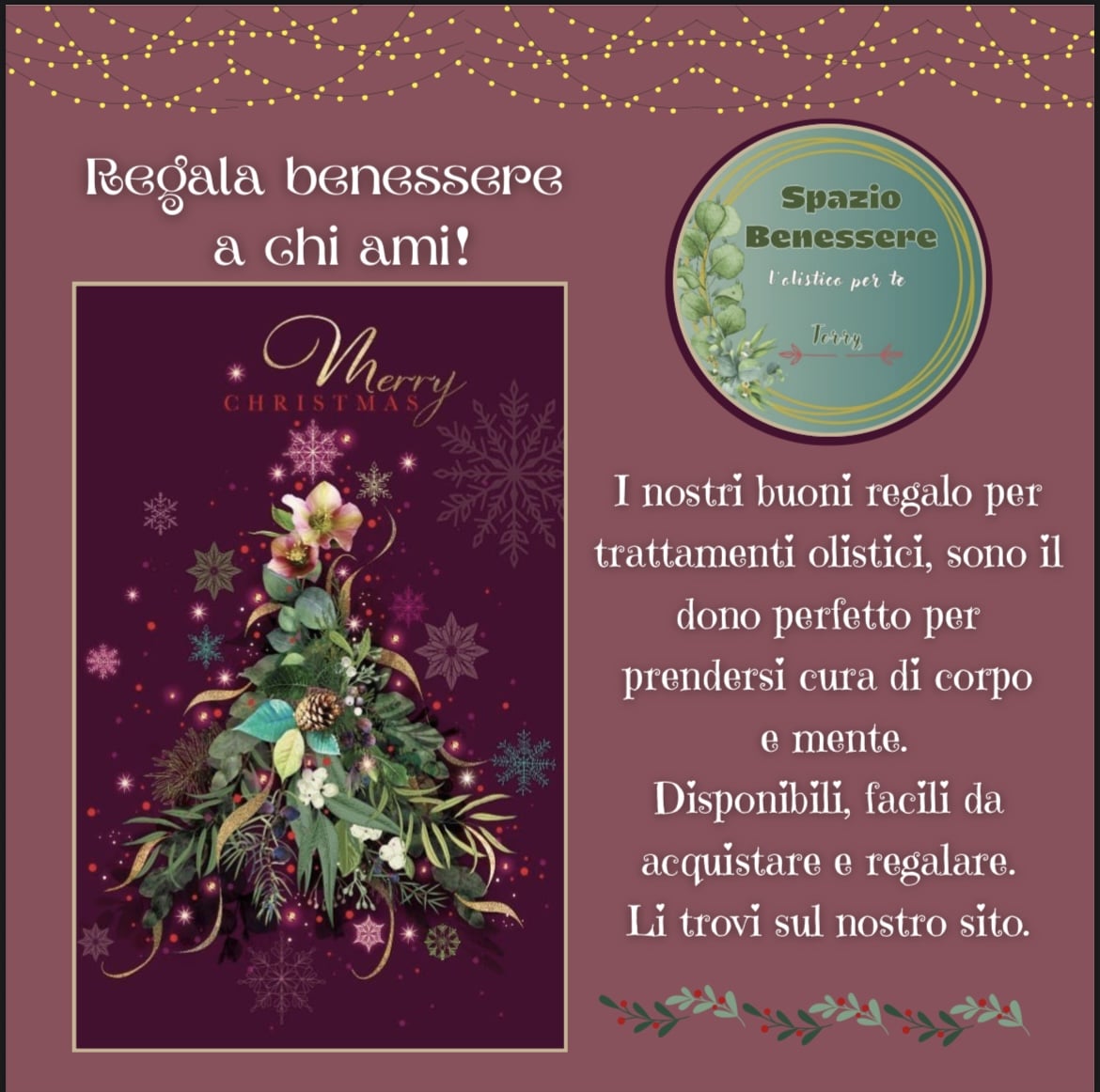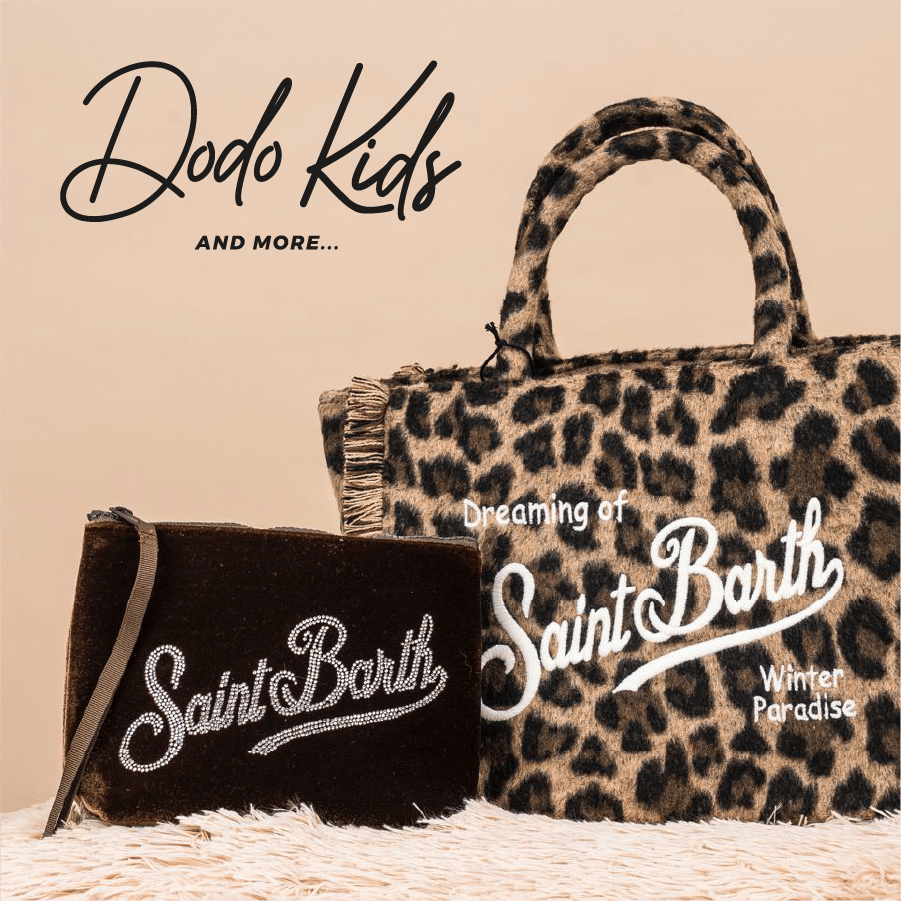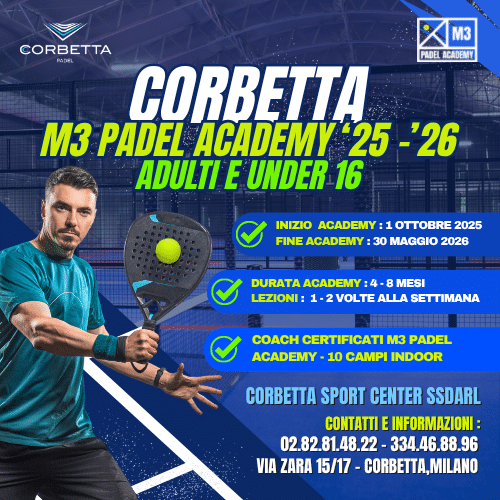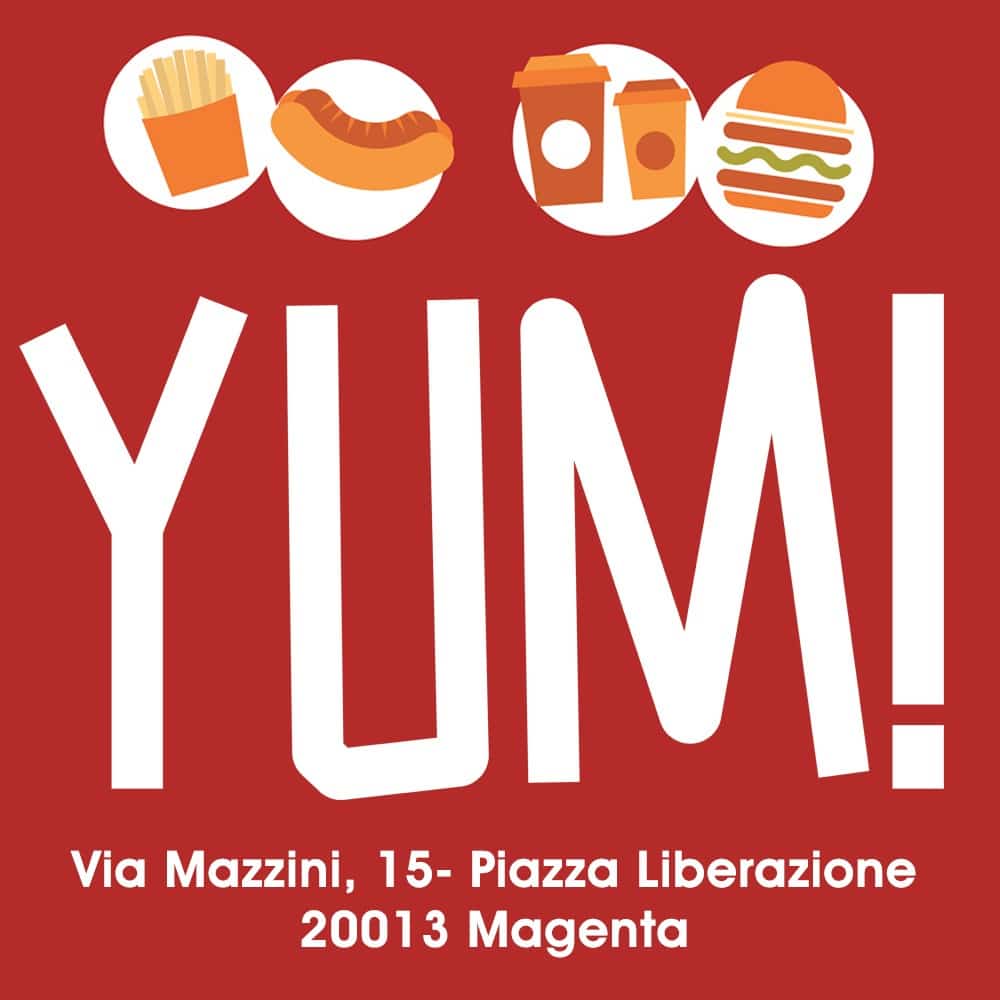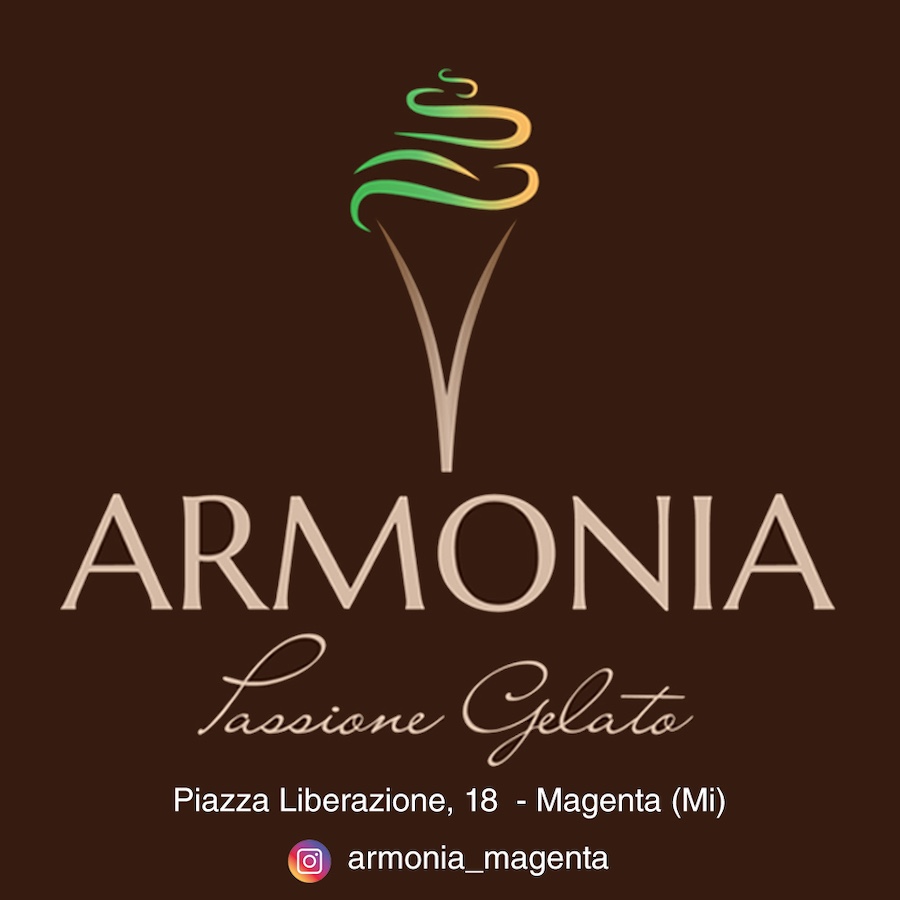Negli ultimi tempi, il tema della libertà di stampa e dell’influenza politica sui media italiani è tornato al centro del dibattito pubblico. Le polemiche sollevate da alcuni esponenti della sinistra — secondo cui la televisione sarebbe schierata con il governo Meloni e l’Italia vivrebbe una condizione di libertà d’espressione indebolita — hanno riaperto una discussione che affonda le radici lontano nel tempo.
Un riferimento utile è un vecchio numero de Il Domenicale, uscito il 18 gennaio 2004, nel quale il direttore Angelo Crespi affrontava un nodo cruciale della vita culturale italiana: quello dell’egemonia culturale. Il suo saggio, “Ombre Rosse sulla Mondadori”, proponeva un’analisi dettagliata dei rapporti tra intellettuali, case editrici e orientamenti politici. Crespi notava come molti tra gli scrittori più severi nei confronti di Silvio Berlusconi pubblicassero proprio con il gruppo editoriale di Segrate. Un paradosso che, secondo lui, mostrava il distacco tra la retorica anti-regime e la realtà di un settore culturale dove gli stessi critici continuavano a trarre beneficio.
Il lungo dominio culturale della sinistra
La tesi centrale di Crespi era chiara: la sinistra italiana, pur non avendo sempre detenuto il potere politico, avrebbe conquistato negli anni un’influenza profonda e durevole sulla cultura. Tra le cause, lo scarso interesse della Democrazia Cristiana per la produzione culturale, il ruolo delle mobilitazioni del Sessantotto, e l’efficace strategia — di matrice gramsciana — con cui il Partito Comunista avrebbe occupato posizioni chiave nei media, nell’editoria, nell’accademia e nell’elaborazione linguistica.
Secondo Crespi, questa lunga fase avrebbe prodotto un sistema culturale caratterizzato da “letteratura mediocre, provincialismo e incapacità di confrontarsi con il moderno”. Pur riconoscendo che il potere diretto di questo blocco si fosse attenuato, egli sosteneva che esso avesse lasciato in eredità un forte dominio simbolico e linguistico, ancora oggi capace di orientare la percezione pubblica e la narrazione della storia italiana.
L’uso politico del linguaggio
Uno dei punti più discussi del saggio riguardava l’uso del termine “fascismo”, spesso utilizzato — secondo Crespi — come etichetta polemica contro tutto ciò che non rientrava nell’orizzonte culturale progressista. Per il direttore de Il Domenicale, questa prassi linguistica sarebbe un esempio di quella “tirannia della minoranza” esercitata da un’élite intellettuale convinta di dover proteggere la società dal rischio di un presunto ritorno all’oscurantismo.
Crespi ricordava inoltre come, nonostante la potenza economica e mediatica di Berlusconi, le stesse reti Mediaset ospitassero spesso contenuti e autori considerati vicini alla sinistra. Allo stesso modo, la Rai — pur soggetta a periodici interventi politici — sarebbe rimasta, a suo giudizio, largamente influenzata da un’impostazione culturale progressista.
Una minoranza convinta di detenere il ruolo di guida
L’analisi del 2004 individuava nella cultura italiana una minoranza intellettuale non isolata né marginale, ma saldamente al potere. Una minoranza persuasa che solo il proprio intervento potesse impedire un presunto imbarbarimento del Paese, e che manteneva viva — apertamente o in forme rielaborate — l’eredità ideologica del comunismo, nonostante la sua sconfitta storica.
Un dibattito che non si è mai chiuso
A distanza di oltre vent’anni, molte delle dinamiche descritte da Crespi possono essere discussamente attuali. Se è vero che la scena mediatica e culturale è cambiata, è altrettanto vero che l’idea di una “egemonia culturale” continua a essere richiamata ogni volta che si parla di informazione, narrazioni pubbliche, pluralismo e rapporti tra politica e cultura.
Il dibattito resta aperto: la domanda non è soltanto “chi controlla i media?”, ma soprattutto “chi controlla il linguaggio con cui descriviamo la realtà?”. E, come dimostra la rinnovata attualità delle riflessioni di Crespi, questa domanda continua a dividere l’Italia culturale e politica.