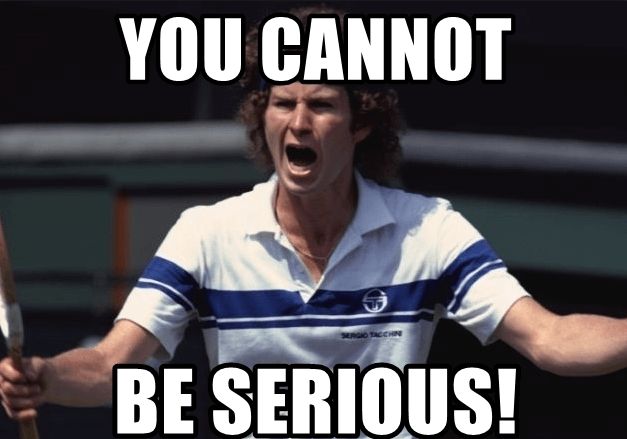Per le truppe cammellate del politically correct, noiose e bacchettone, fu Super Brat, lo spaccone capace di inquinare con i suoi atteggiamenti sopra chissà quali righe il contesto impomatato di circoli spesso nobiliari. Wimbledon per esempio. Per tutti gli altri aficionados dell’universo tennis, invece, fu Super Mac, un essere mitologico spedito dagli dèi della disciplina sul pianeta Terra per cambiare l’ordine precostituito delle cose. Quindi, divisivo come solo le personalità più ingombranti, c’è chi lo detestò e chi non seppe più farne a meno. Al punto che, finita in soffitta la sua racchetta di legno, nulla di un gioco come il tennis fu più lo stesso. Nemmeno con Federer, detto con il religioso rispetto per il dioscuro svizzero.
Di John McEnroe si possono dire un sacco di cose, magari che fu, anzi lo è ancora, il volleatore più forte che abbia mai messo piede su un playground. Oppure che, parafrasando Gianni Clerici che lo cantò in maniera mirabile, tutti dovremmo ambire nella vita a farci accarezzare da una donna come McEnroe fu in grado di fare con la pallina. Aspetti meravigliosi di un tennista meraviglioso, tuttavia ciò che è più importante, perché baciato dal requisito dell’oggettività, è che fu spartiacque, il punto di non ritorno. Prima c’era un tennis e poi ne sopraggiunse un altro, quello odierno. In mezzo, solamente lui, a sublimare il gioco che fu pallacorda e archetipo di eleganza stilistica. Un gioco esigente se si pensa all’educazione tecnica che si rendeva necessaria allora, molto meno democratico di quanto non sia adesso che attrezzi tecnicamente perfetti concedono una chance quasi a tutti; un gioco che McEnroe, se da una parte lo ha reso planetario come solo le cose belle sanno essere, dall’altra ne ha fatto il suo personale giardino di casa, con gli altri a guardarlo dipingere un tennis, naif e ingestibile, spesso impotenti.
Come nel 1984, l’anno di grazia impresso sugli almanacchi come il vertice della sua parabola tennistica. Una dittatura, aristotelica e feroce, che per gli amanti dei numeri significa ottantatré match vinti e tre soli presi in dodici mesi, uno ogni quadrimestre. Uno di questi, rimediato contro l’odiato e antitetico Lendl, è il paradosso che forse meglio dice di Mac. Quel giorno, calcando i campi di mattone tritato in Bois de Boulogne, esibì – per dirla alla maniera di Rino Tommasi – le due ore di tennis giocate sul rosso, lui che fu forgiato per dominare il cemento, più formidabili di sempre. Dimostrando, al cospetto di uno che ha aperto l’epopea purtroppo perdurante dei corri-e-tira moderni e che sulla terra battuta contava su almeno un paio di lauree, che l’arte del serve-and-volley non conoscesse limiti di efficacia e applicazione. Non un esercizio donchisciottesco, quindi, ma la presa del Palazzo d’Inverno percorrendo il sentiero più scosceso. Coraggio e talento. L’acme – un pomeriggio che sta al tennis come la finale di coppa dei campioni persa a Istanbul dal Milan forse più forte di sempre sta al soccer – nel giorno di una sconfitta, forse l’unica che ancora gli toglie il sonno. Perché, si sa, i geni come lui non riescono mai ad essere banali in ciò che fanno e, magari, disfano.
Lo ricordiamo oggi perché per John le primavere sono nel frattempo diventate sessantacinque. Metà delle quali spese combattendo, racchetta in pugno, contro avversari assai più valorosi di quelli che avrebbe incontrato ora e contro i demoni di una personalità abbacinante e complessa. Noi, che comunque vada non smettiamo mai di cibarci di tennis e un occhio di riguardo lo abbiamo sempre per chi fa lo sforzo di elogiare più la bellezza che l’efficacia, non possiamo che essergli grati. In tal senso, McEnroe è la Venere del Botticelli, ogni volta che la guardi ti sorprende con un dettaglio mai notato prima. E se la bellezza, anche la sua, con buona pace di Dostoevskij non ha salvato il mondo (del tennis) considerata la contingenza, Super Mac ci aiuta a comprendere ed apprezzare una delle definizioni, sempre di bellezza, più azzeccate che siano mai state concepite. Quella sussurrata da Alda Merini, per la quale “la bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori”. La poetessa dei Navigli sembra proprio parlare di lui, il discolo che a scuola tormenta la pazienza dei professori con quel ghigno beffardo stampato sul volto. John, buia tormenta dentro e luce tutt’intorno a illuminare il nostro sport preferito.
Tanti auguri, Genius.