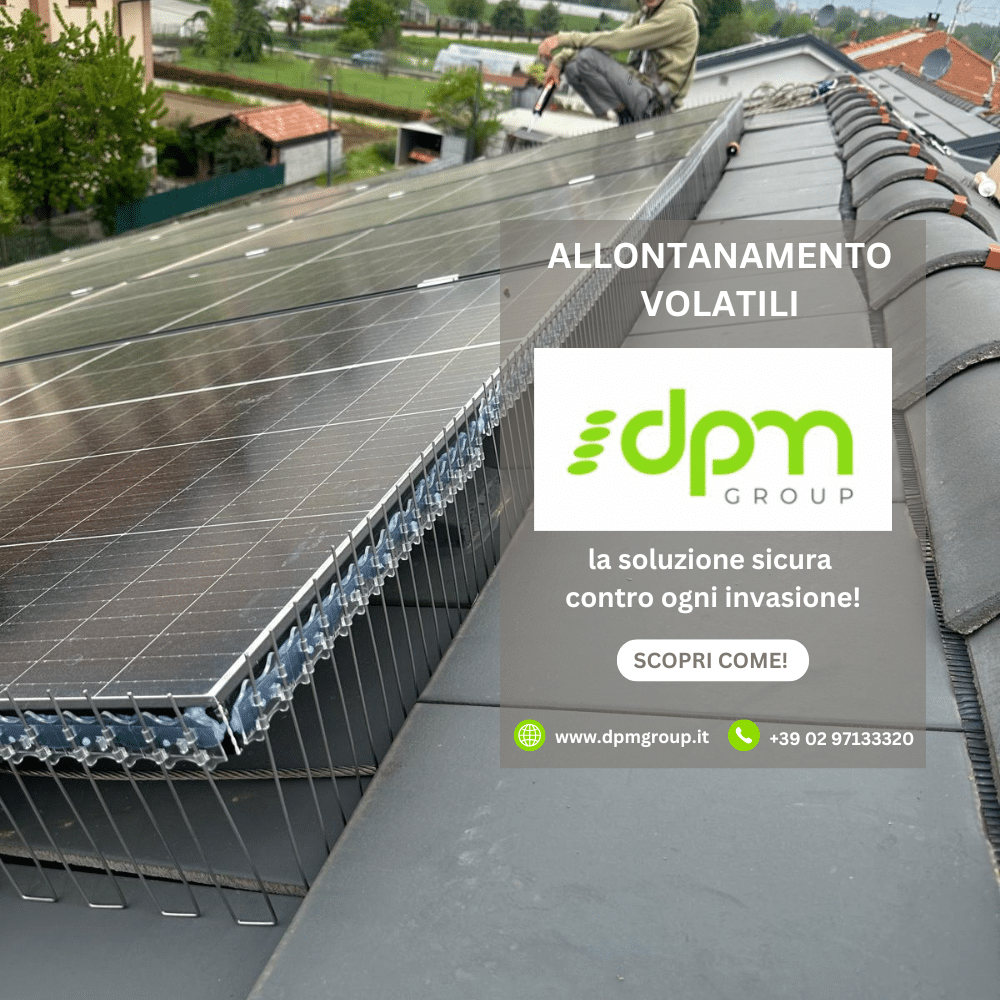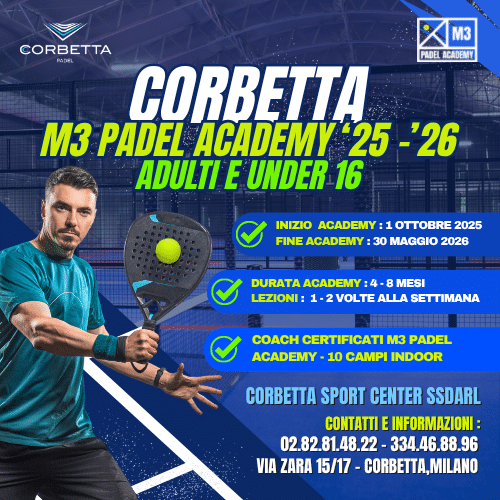Un pomeriggio come altri, una conferenza stampa organizzata nel tempio di Wimbledon, l’annuncio che era nell’aria. Fabio Fognini, trentotto anni dei quali una ventina spesi da tennista professionista, ha detto che può bastare così. Ciao a tutti, mi ritiro. Così, a pochi giorni di distanza da quello che sarà ricordato come il suo ultimo match disputato e perso contro Carlos Alcaraz, il predestinato, si chiude la sua carriera. Un match meraviglioso, cinque ore di agone d’altri tempi che hanno compendiato, in un pomeriggio che ha restituito al tennis il suo lato più artistico, tutto il Fognini che abbiamo imparato a conoscere e che, fuori tempo massimo, oggi sono in tanti a ringraziare.
Pensa un po’, gli stessi che per una carriera intera non hanno fatto altro che dargli addosso perché, a loro dire, non propriamente un esempio da imitare e chissà che diamine volessero dire. Intanto, non ci si ricorda che Fabio abbia mai ambito pubblicamente ad esserlo e, soprattutto, dimostrando, questi ultimi, superficialità di giudizio e limiti strutturali nella conoscenza di uno sport che, parafrasando il compianto Roberto Lombardi, oltre che ad essere diabolico è infarcito di dinamiche che mettono costantemente a dura prova l’animo umano. Tra paure da esorcizzare e attimi da cogliere perché non ritornano. E cosa saranno mai due racchette dilaniate ad un cambio di campo dopo un quindici scappato di mano o un’urlataccia al cielo per cercare di rimanere a galla nel magma di un gioco che sembra fatto apposta per fare a brandelli la psiche? Nulla. Tanto è bastato, però, per far sì che le anime candide dello sport, dagli addetti ai lavori ai fruitori più occasionali tutti inclusi, ne facessero un bad boy, quello da non imitare. Un “Balotelli”, qui nella veste di aggettivo.
Inimitabile, per aspetti decisamente più importanti, Fabio lo è stato davvero, merito di una quantità esondante di talento generosamente concessagli da Madre Natura. Con buona pace dell’attuale Golden Age azzurra, che senza soluzione di continuità garantisce la presenza in massa nelle fasi finali dei tornei più prestigiosi trasformando lo straordinario in ordinario e tolto l’inavvicinabile Adriano Panatta, nessuno qualora si trattasse di saper giocare a tennis gli si è mai avvicinato. Vale sempre la più azzeccata definizione di talento, inteso come la capacità di risolvere con semplicità situazioni intricate ai più. Un dritto in mezza volata, una volée strappata dalle stringhe delle scarpe, un lungolinea di rovescio, un colpo da pittino. Cose che gran parte dei giocatori più celebrati di lui dagli almanacchi non solo non fanno ma non pensano nemmeno. Merito di una mano, la sua, dalla quale – parafrasando questa volta Gianni Clerici – si avrebbe il desiderio di farsi dare una carezza.
Ma ha vinto poco, l’altro tormentone nazionalpopolare, il lato B del disco rotto che l’ha accompagnato ad ogni sortita. La confusione endemica, e pure un po’ bonipertiana, di quelli che ancora confondono la capacità di profondere un tennis di qualità con quella di sollevare i trofei. Come se un Mecir (che meraviglia il Gattone) fosse stato meno bravo di un Lendl a manovrare la racchetta o un Nalbandian (idem come sopra) di uno Hewitt. Solo perché i primi, di Slam, non ne abbiano mai vinti a differenza dei secondi, molto più scaltri nella conta dei punti. En passant, a voler fare le pulci al palmares di Fabio non è che sia proprio da buttare via. Un best ranking fissato al numero nove, sette se si parla di doppio, un Masters 1000 vinto a Montecarlo, altri otto tornei del circuito ATP, il triplo scalpo di Nadal sulla terra battuta. Qualcosa che, tanto per dirne una, a Federer sul mattone tritato non è riuscita. Federer.
Sempre a voler fare i pignoli, il giorno 15 luglio del 2019, momento in cui Fabio fissa la sua migliore classifica di sempre, davanti a lui albergano, in ordine, Djokovic, Nadal, Federer, Thiem, Zverev, Tsitsipsas, Nishikori e Khachanov. Con il triumvirato da sessanta Slam e briscola ancora a pieno regime, l’austriaco in rampa di lancio, il greco ed il tedesco all’apice della carriera e il giapponese, gran giocatore e altrettanta sfortuna, miracolosamente fuori da un un’infermeria. Senza dimenticare che nei suoi anni migliori, quando l’età era tutta dalla sua parte, a scalpitare nel circus c’erano pure i vari Murray, Wawrinka, Del Potro, Berdych. Fenomeni veri, insomma. Tutto ciò per ricordare a quelli fissati con i numeri che non si ricorda un’epoca peggiore, o migliore secondo i punti di vista, per emergere di quella che ha fatto da contorno all’azzurro. Un po’ diverso da oggi, per usare un eufemismo, dove si può essere – detto con rispetto parlando – Ruud o Fritz, se non Shelton, per insidiare il podio. Anzi, il norvegese per poco non si è preso pure la vetta, fermandosi ad una sola vittoria dal bersaglio grosso.
Fognini che, appunto, in tempi di vacche magre ha tenuto in piedi la baracca italiana tutto da solo. In Davis, per esempio, quarantatré vittorie tra singolare e doppio, impreziosite dal capolavoro contro Murray a Napoli, sempre a proposito di vittorie eccellenti. Avrebbe potuto vincere di più? Può darsi. Paolo Bertolucci ripete spesso che Fabio avrebbe potuto giocare a mo’ di Agassi a flipper-tennis, con i piedi francabollati sulla linea di fondo e in assetto di perenne controbalzo, per il talento disponibile unito al senso del ritmo di un metronomo e acquisita una gestione più serena delle pieghe agonistiche. Forse è vero, qualche torneo in più se lo sarebbe messo in bacheca. Ma realmente sarebbe cambiato qualcosa? No.
L’altro giorno, Carlitos Alcaraz, oggi l’unico fenomeno epocale in circolazione, ad un certo punto è parso stranito, e non gli capita spesso avendo potuto scampare per una fortuita questione anagrafica ai trucchi da illusionista di Federer. Perché, davanti a lui, Fabio sciorinava di solo braccio – le gambe non ci sono da un pezzo ma, in compenso, il ventre da birra sì – una successione di colpi mai uguali a quelli che li hanno preceduti da mandarlo ai matti. Arrivando a fare urlare al murciano al suo box che uno così (Fabio) potrebbe giocare fino a cinquant’anni. In un match, il loro, parlato dai due protagonisti con lo stesso linguaggio, quello degli artisti. Improvvisatori congeniti e censori degli stereotipi in missione per conto degli dèi del gioco. Jake ed Elwood, Belushi e Aykroyd, ma vestiti di bianco. Alcaraz, uno che se ne avesse il desiderio non perderebbe praticamente mai, e Fognini a fare sobbalzare il centrale di Wimbledon.
L’ovazione finale del pubblico e il tributo dell’avversario devono quindi averlo convinto. La storia è un po’ quella già scritta dalla moglie di Fabio, Flavia Pennetta che, all’apice della carriera e con in mano il trofeo degli US Open appena conquistato, ha preso il microfono e ha comunicato l’intenzione di ritirarsi. Spiazzando un po’ tutti. Fabio, sceso di classifica e con un fisico che comincia a non volerne più sapere della fatica bestiale necessaria ad un tennista, dev’essersi chiesto il senso, dopo un match indimenticabile, di ritrovarsi nel pantano di un Challenger e con quali motivazioni per inseguire una pallina e avversari con l’età dei suoi figli. Si capisce bene la sua preoccupazione quando dice che, in fondo, giocare a tennis è l’unica cosa che sappia fare. Vent’anni sono una vita. Vent’anni nei quali gli esperti non hanno mancato di sottolineare che se avesse avuto una testa diversa, chissà. Probabilmente, la genialità non sarebbe stata la stessa e nessuno che ami visceralmente il gioco, e pure Fabio, si sarebbe mai sognato di fare cambio. Un pizzico di servizio in più, se proprio ci tocca guardargli nelle tasche, e un po’ di fegato se lo sarebbe risparmiato ma, appunto, conta davvero poco.
Siamo egoisticamente dispiaciuti, orfani di uno dei pochi motivi che il tennis contemporaneo ci abbia offerto per dedicare qualche ora di tempo al nostro sport preferito. Arthur Schopenhauer, già nel 1819 con “Il mondo come volontà e rappresentazione”, scriveva di come genialità e pazzia avessero un lato in cui l’una confinasse con l’altra, anzi l’una trapassasse nell’altra. Fabio Fognini, questo incontro di peculiarità lo ha reso tennistico e non avrebbe potuto farci un regalo migliore. Un calcio nel sedere all’omologazione, in campo e pure fuori, che è sempre anticamera di noia e bruttezza che rifuggiamo. “Chiunque abbia bisogno di me, nel tennis, può chiamarmi. Anche solo per fare due chiacchiere”. È l’ultima frase da tennista di Fabio. Ti chiameremo, Fabio.
Pascal, che fai, lo avvisi tu? Grazie di tutto.