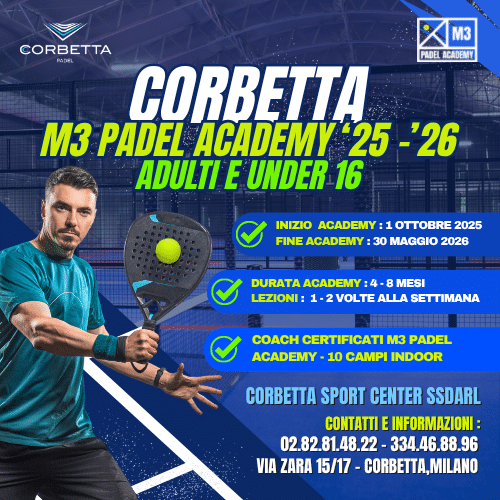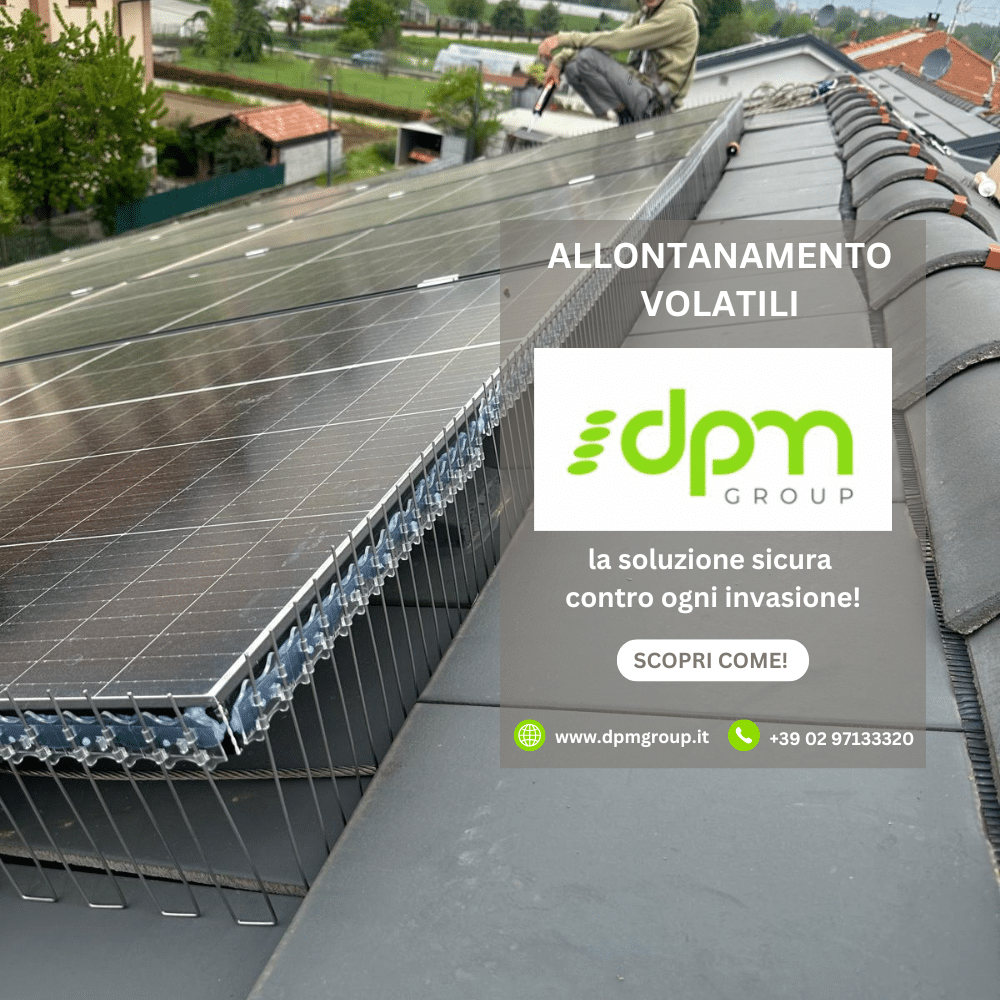Questione di fame, si dice in questi casi. Basterebbe chiedersi come possano avere dentro lo stesso sacro fuoco uno che il tennis ha iniziato a giocarlo su campi improbabili schivando le bombe che dilaniavano la sua nazione e uno che, invece, per uscire di casa aveva la possibilità di scegliere tra una Ferrari, un jet privato e un sottomarino. E non è un’iperbole. Infatti non ce l’hanno. E il talento, purtroppo ma solo per gli amanti della bellezza sopra ogni cosa, non c’entra nulla; perché nel tennis, si sa, è paradossalmente piuttosto remota la possibilità che il più talentuoso sia anche il più forte. Non a caso, il primo, quello abituato a guardare che dal cielo non piovano ordigni, è diventato il giocatore più forte della storia del gioco, della Terra e di eventuali altri pianeti, mentre il secondo, baciato da una forma epocale di talento, con gli almanacchi non è che abbia costruito chissà quale feeling. Uno, sempre il primo, è ovviamente Novak Djokovic; l’altro è quello che, a farci quattro chiacchiere, non capisci mai se è pazzo o geniale, ma solo perché è entrambe le cose, e all’anagrafe fa Gulbis, Ernests Gulbis.
Figlio di Ainars, magnate dell’energia nonché terzo uomo più ricco della Lettonia, e di Milena, attrice e donna meravigliosa, che non si sia dedicato al tennis per diventare ricco, del resto lo era già, o famoso, idem, o per girare il mondo, vedi i mezzi di locomozione di cui sopra, è una cosa che ripete spesso. “Gioco per darmi un obiettivo”. Quello di poter dire a sé stesso di aver raggiunto il livello dei migliori, se possiamo permetterci di interpretare il suo pensiero, vanitoso e criptico. Vien da sé una certa allergia per il lavoro duro che, se per i colleghi è pane quotidiano, per lui è congiura. Così, difficilmente lo si è visto tirato a lucido e con il serbatoio della benzina pieno all’atto di scendere in campo. Ernests, e qui si rischia di sbagliare per difetto, ha dilaniato nell’arco della carriera qualcosa come mille racchette, che non è certo un motivo di vanto, anzi, ma è l’assist buono per provare a delineare gli strani connotati del personaggio che, troppe volte e troppo in fretta, lo si è etichettato come negativo. “Ne rompevo una sessantina a stagione – racconta – e poi, per sentirmi ancora più un idiota di quanto già non fossi, mi recavo alla fabbrica per guardare gli operai che producevano i miei attrezzi. Così mi ci sentivo”. Sipario.
Tornando al tennis giocato, chi pensa sia stato solo un fenomeno da baraccone – effettivamente in più di una circostanza si è davvero messo d’impegno per sembrarlo – prende un abbaglio. Ernests, che se oggi parliamo di lui è perché ha deciso che con il tennis agonistico possa bastare così, è stato giocatore vero. Verissimo. Detto di una forma abbacinante di talento e, aggiungiamo adesso, di una mano che parafrasando il vate Clerici vorremmo ci accarezzasse tanto è raffinata, non si diventa il numero dieci al mondo per le casualità della vita, serve sostanza e neppure poca. Obiettivo centrato all’indomani di una semifinale Slam, in quel di Bois de Boulogne, disputata e persa – guarda un po’ – contro Djokovic, quello delle bombe, ma solo dopo averlo messo alle corde su una superficie per giunta non ideale fino all’inevitabile accensione prematura della spia della riserva. Fa niente se, una volta fatta la doccia, anziché partire per Londra con destinazione Queen’s Club Championships come da programma scelse di tornare a Riga con il gruzzolo racimolato a Parigi, mezzo milione di euro mal contati, per farsi accompagnare dal cugino spiantato al casinò. Dove un rosso e nero sbagliato fece evaporare in una sola puntata il frutto delle fatiche (si fa per dire) parigine, con il suo accompagnatore costretto a pagare cocktail e, si dice, signorine.
Non dev’essere mica tanto facile vincere sei tornei ATP, battendo qua e là un paio di volte Federer, con attitudini simili e un addome più riempito che scolpito. Cose da Gulbis, insomma. Come il suo rovescio, per esempio, uno dei colpi bimani più belli ed efficaci del tennis moderno. Per intenderci, siamo ai livelli elitari di un Safin, sempre a proposito di follia, e di un Nalbandian; detto a beneficio di chi ancora si ostina, perché accecato dal bigottismo del politicamente corretto e che vorrebbe i tennisti stereotipati in fotocopia e silenti, a non voler ammettere che Ernests è di quelli che non capitano tutti i giorni. E se la dinamica del dritto era bizzarra e inaffidabile almeno quanto lui, in compenso il servizio sapeva essere demoralizzante ma solo per gli avversari. Una sentenza, al pari della morte e delle tasse, quando la testa era sgombra da nubi.
Si diceva del talento che, se inteso come la capacità di risolvere situazioni intricate e ad altri precluse con disinvoltura, fa proprio scopa con Gulbis. Per il semplice fatto che la sua competenza tecnica è stata realmente da primo della classe. È bravo ma non si impegna, come si direbbe allo scolaro discolo e brillante insieme. Del resto, la vita è una sola e se finisci in galera, magari a Stoccolma, è logisticamente difficile che ti stia adeguatamente preparando per il prossimo torneo. Ernests, in arresto, ci è finito davvero. “Agente – disse al poliziotto che lo scortava – lei, quando conosce una ragazza, prima di andarci a letto domanda che mestiere fa? Vede, agente, a me non interessa”. La donna in questione, di lavoro faceva la prostituta e pare che a Stoccolma non fosse cose gradita quella di chiudere la nottata con lei. Il nome, Ernesto, lo deve alla passione dei genitori per Hemingway mentre il corredo cromosomico molto probabilmente è eredità del nonno, cestista che fece grande la nazionale sovietica. Di Ernests capì tutto quella vecchia volpe di Niki Pilic, manco a dirlo il primo allenatore di Djokovic e mentore di chissà quanti campioni, che osservandolo giocare ancora ragazzino decise saggiamente di non compromettere il fegato inseguendo le traiettorie sinusoidali del lettone: “Troppo ricco e troppo talento – disse – per cavar fuori qualcosa di buono”, prima di lasciarlo andare incontro al suo imprevedibile destino tennistico.
Se il suo sogno è sempre quello di poter incontrare, chissà dove, Einstein per conversare un po’ sul senso delle cose, pur nella convinzione probabilmente infondata che il genio della relatività mai avrebbe accettato l’invito di “uno stupido atleta”, tanto per usare le sue stesse parole, con quelli come Federer o come Nadal, dioscuri in campo ma molto meno fuori, non è mai stato troppo tenero. “Noiosi in ciò che esternano – era solito ripetere, attirando, così, l’ira di milioni di tifosi – mica come quei pugili che alla cerimonia del peso se ne urlano in faccia di tutti i colori”. Eppure, anche se sembra impossibile, ci sono stati dei momenti nei quali Gulbis ha tentato di violentare l’indole inadatta a fare fronte alle insidie psicologiche che propone la disciplina del diavolo per alzare quella benedetta asticella che le sue qualità tecniche avrebbero potuto spedire in cielo. Allora, per recuperare un minimo di condizione dopo settimane di bagordi, lo si è visto fare a sportellate in tornei Challenger, dove i campi fanno schifo, l’organizzazione è alla viva il parroco e si incontra gente che pur di arrivare dorme in auto e sputa sangue su ogni palla, come se da ciò dipendesse la propria sopravvivenza. Sempre a proposito di fame. Non troppo tempo fa, poi, si è giocato anche l’ultima carta del mazzo, assoldando Piatti e trasferendosi a Bordighera nel tentativo di tornare in alto. Ma si sa, c’è poco da inventare nello sport, figuriamoci nel tennis e non c’è Piatti che tenga.
Anche noi, che tennisticamente lo amiamo in maniera viscerale, lo avevamo perso di vista ormai da un po’, tanto per dire che l’annuncio a mezzo social del ritiro non è che ci abbia colto di sorpresa. Se è vero che il tennis farà benissimo a meno di uno che, sovente, non è stato archetipo di dedizione alla causa, per usare un eufemismo, è altrettanto vero che, di un tennis omologato, robotico e allergico alla fantasia, Gulbis ha rappresentato la ventata d’aria fresca. L’effetto sorpresa, l’idea che potesse accadere qualcosa di non preventivato, l’elogio dell’eccesso e della bellezza. Hai detto niente. “I pazzi e gli ubriachi sono gli ultimi santi della terra”, disse Charles Bukowski. Se il pensiero del guru del realismo sporco corrispondesse a realtà, e a noi piace terribilmente pensarlo, Ernests Gulbis, che vivaddio è sia uno che l’altro, in un giorno che si spera essere il più lontano possibile lo si vedrà scorazzare in Paradiso. Con una coppa di Gout de Diamants in mano e il sorriso beffardo di chi a prendersi troppo sul serio non ne vuole proprio sapere.
Hey Ernests, dov’è che si va stasera? Sì, va bene, ma offri tu.