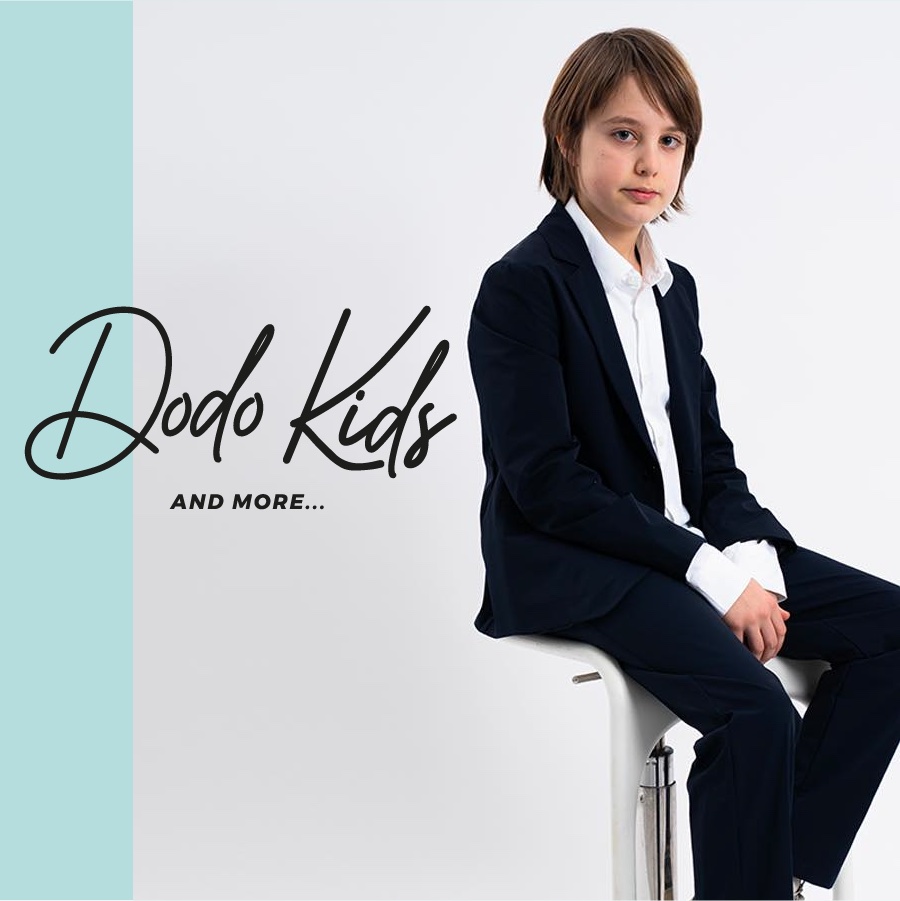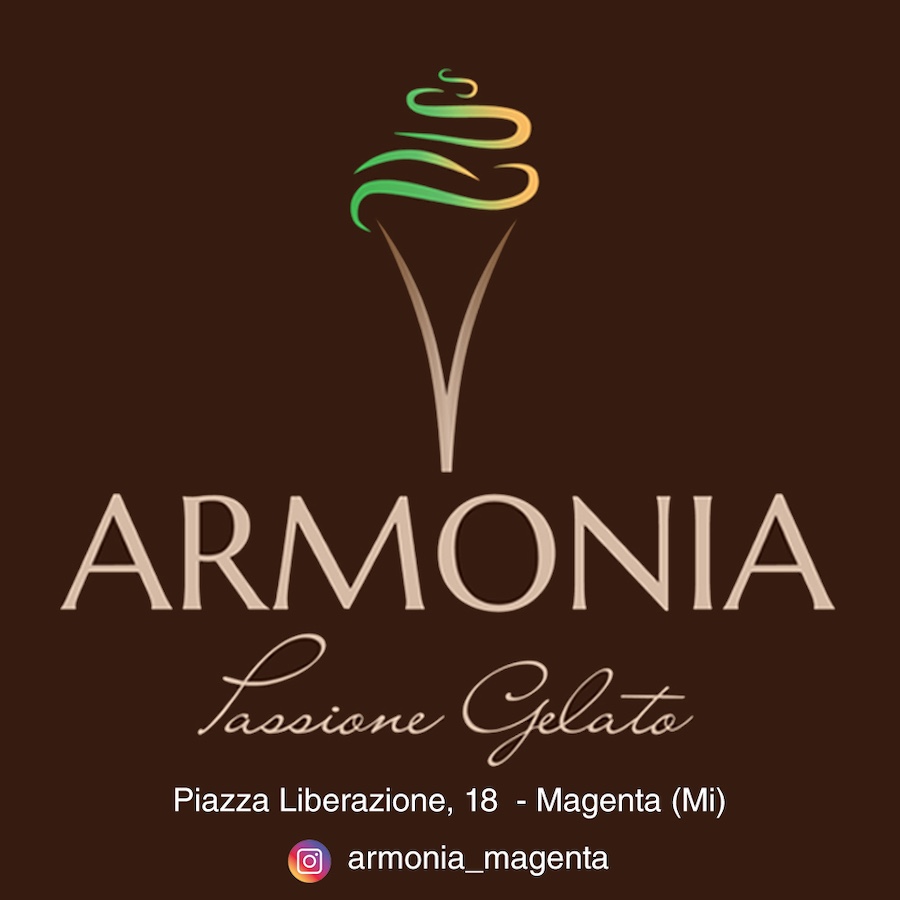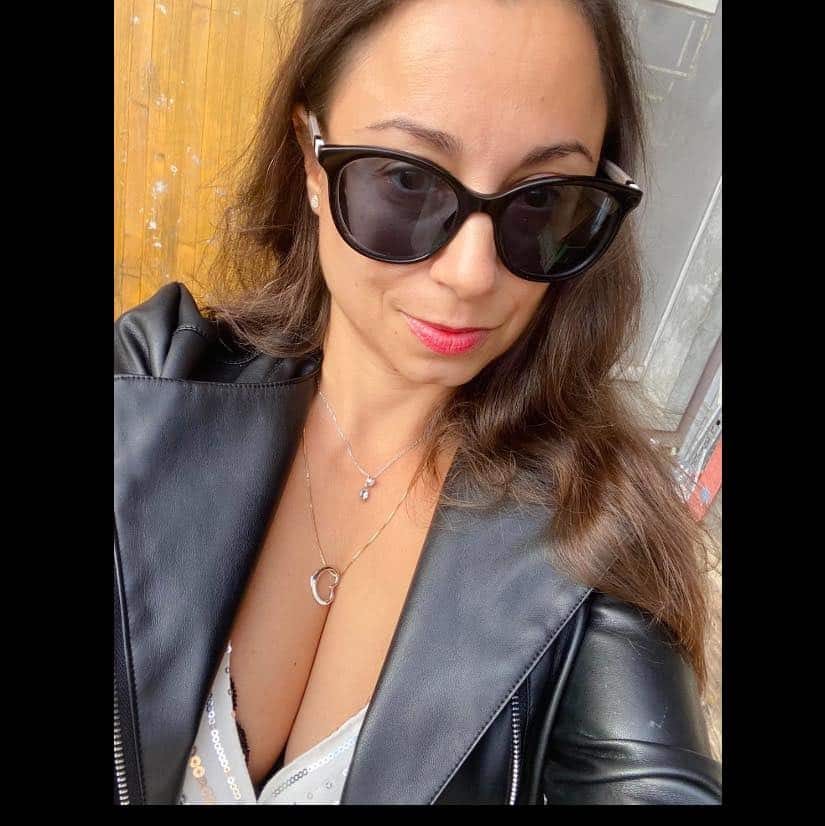Con Kaballà, al secolo Giuseppe Rinaldi, facciamo un tuffo nello studio del dialetto mescolato alla storia della contaminazione musicale, trasformando questa intervista in una pietra miliare che celebra l’avvento di un nuovo genere, narrando dei padri che l’hanno reso grande.
Ciò che ha fuso nel suo album storico, che aveva già segnato un’epoca ed un cammino 33 anni fa, è difficile da descrivere a parole.
Le sonorità rock- folk – pop, ti circondano a tutto tondo ad un ritmo incalzante ed assolutamente moderno, e come nella trama di un film, attraverso testi lievi e dotati di una poetica che attinge dal mito greco e popolare, si scioglie in sentimenti di amore e venerazione per la figura femminile.
Ma non manca una satira graffiante e pungente come in “Gloria”, brano di critica a quella parte della natura siciliana, connivente con il peggiore spettro della sua terra, e che in un funerale, sa partecipare omertosa.
Molti poi i variopinti personaggi, dal lavoratore che sogna il ritorno al tipico emigrante in partenza.
Emerge infine la natura potente degli elementi, che sembrano governare queste note ed il protagonista che vi intesse il suo verbo, discostandosi da ogni tipico cliché.
Un verbo dialettale che si veste a tratti di influenze leggendarie, mentre sprofonda in quel mare, che concede nutrimento e amore profondo; perché se il tempo sfugge, l’amore può renderci eterni.
L’intervista.
D. Nell’evento nel quale parlerà della rimasterizzazione di “Petra lavica”, cosa si prefigge di comunicare al pubblico e come si svolgerà?
R. Si tratta come ha detto lei della rimasterizzazione del mio primo lavoro del 1991. Diciamo per iniziare che la ripubblicazione è avvenuta in vinile in edizione limitata, ed è stato il mio primo lavoro discografico, ormai 33 anni fa. Fu uno dei primi esempi di contaminazione tra musica non tradizionale e dialetto. In Italia, prima di allora, il dialetto era legato a forme di musica più vicine al folk. Dagli anni Novanta in poi, il precursore fu DeAndré con “Creuza de Ma”, si svilupparono le prime forme di musica contaminata che non era di origine tradizionale ma di origine pop-rock.
I primi esempi di dialetto in una veste destinata al grande pubblico, si erano avuti con i Tazenda in Sardegna, i Pitura Freska in Veneto, e poi arrivai io con questo album 33 anni fa.
Nell’incontro con il pubblico, al quale parteciperanno alcuni dei protagonisti di quel momento storico, poi il discografico che ebbe il coraggio di realizzarlo, Stefano Senardi, e si parlerà di dialetti e di musica pop; di ciò che ha rappresentato la musica pop contaminato con il dialetto da quel momento in poi.
D. Quali sono le differenze principali dalla prima versione del 1991?
R. Le differenze principali sono molto delicate naturalmente, vengono fuori semplicemente ad ascolti in alta fedeltà, quando si tratta di vinile. Le specialità sono date dalla brillantezza dei suoni, come in genere si fa nelle rimasterizzazioni. La confezione è molto più curata: sono state aggiunte fotografie dell’epoca, l’interno dell’album è patinato. Il vinile è colorato di giallo, e naturalmente l’intervento di uno dei più grandi ingegneri del suono della musica italiana dagli anni Settanta in poi, ossia Rodolfo Foffo Bianchi, che si è occupato di produrre da Elio e Le Storie Tese, a Pino Daniele a Lucio Dalla, passando per la progressive italiana: quindi un monumento, e nel mio caso, l’ha curato insieme al figlio.
Ha fatto brillare di più i suoni dell’epoca, senza tradire l’intenzione di un disco di allora suonato in quella maniera, che vuole trasmettere calore e non è fatto di “plastica”…. In genere, la musica di adesso tende ad essere proprio di plastica, perché è divulgata in supporti. Si può sentire anche in streaming, ma è chiaro che se ne sentono le differenze sulle piattaforme che distribuiscono dei suoni che privilegiano questo tipo di mondo e di suono.
D. Difatti lei mi ha già anticipato perché una delle mie domande si sarebbe incentrata sul suono bellissimo e coinvolgente ed indescrivibile, in questa rimasterizzazione! Ma torniamo quindi a “Petra Lavica”, titolo dell’album, e la prossima domanda è un pochino più culturale… Nelle altre nazioni e penso ad esempio alla Gran Bretagna, alla Scozia e all’Irlanda, non penso che cantare nei propri dialetti sia così sbalorditivo come da noi. Perché in Italia è così?
R. Rispondo molto volentieri. “Petra Lavica” già in dialetto siciliano produce una “T-R” simile all’anglofona. Infatti ai tempi ho guardato più alle produzioni all’estero che all’Italia, e quindi lei ha ragione: io guardavo tantissimi live irlandesi. In Irlanda la contaminazione tra folk e rock e musiche diverse, come pure in certe zone dell’Inghilterra, e dell’America volendo, molto spesso incontravano anche lingue diverse come il celtico, il pough e chi più ne ha più ne metta, in quel periodo anche la musica world per esempio, che inventò la contaminazione di Peter Gabriel fuori dall’Italia.
Posso dire che questo mio album 33 anni fa è stato un precursore per l’Italia, visti appunto i pochi esempi De Andriani e pochi altri, come Battiato.
Ed in tutto questo non ho ancora citato la canzone in napoletano: la musica napoletana ed il dialetto napoletano hanno come una “cittadinanza” diversa, perché hanno una storia lunghissima, che parte dalla canzone classica e arriva negli anni Settanta con gli Osanna, con Pino Daniele, che mischiano il blues ed il jazz con il dialetto. Ed andranno avanti fino ai trapper odierni, che assurgono a dimensione nazionale, ma con un dialetto che ha dimensione direi internazionale; mentre le altre lingue che pur hanno prodotto letteratura, penso al veneto con Goldoni, penso al siciliano con Pirandello, penso alla peculiarità della lingua sarda, hanno avuto meno sperimentazione. Dai Novanta in poi ci sono stati pochissimi esempi e se ne sentono ancora ma sicuramente c’è stata più timidezza rispetto alle nazioni che ha citati lei.
D. Passiamo ai testi. Ho visto che c’è stata una scelta di poetica sull’amore molto bella, che vede la donna come una entità da venerare quasi, quasi irraggiungibile… Ma c’è anche un testo, il primo, che secondo me si distanzia dal filo conduttore dell’album: è “Gloria”. Vi percepisco critica e quasi satira: a cosa si ispira?
R. “Gloria” è una invettiva vera e propria contro le ombre tipiche di una straordinaria terra che è la Sicilia, piena di tante cose belle ma insieme a queste, ci sono anche delle storture, cose che noi siciliani puro-sangue abbiamo sempre esecrato, a partire da Sciascia in poi… Parliamo della Mafia. Quella è una canzone i poteri forti e la mafia. I funerali sono i funerali dei morti di mafia. Sono le facce imbiancate che vanno a piangere a questi funerali, e magari sono conniventi con questo fenomeno. Infatti, quella canzone è in italiano perché speravo che arrivasse a più gente possibile. Se avessi saputo scrivere in inglese, l’avrei fatta in inglese, per arrivare a tutto il mondo. Ci sono gli incipit che ricordano Jacopone da Todi, e dice: “Se fossi imperatore di tutto il mondo, taglierei la testa a tutte le persone perverse e la lascerei solo a bambini e pazzi”… Perché quelli sono portatori di verità.
Il resto è amore e spesso mito. Una delle tante dominazioni siciliane, che va da quella greca a quella dello stil novismo normanno, a tutte le dominazioni che hanno fatto grande la Sicilia.
D. Nell’album, c’è “Il Mirto e la Rosa”, è riferita ad un’usanza o leggenda particolare?
R. Non proprio. Questo brano in realtà è semplicemente il titolo di un libro che avevo letto, e mi piaceva molto il titolo ed è una work song alla maniera americana, nel senso che sicuramente il mirto e la rosa sono elementi di mediterraneità, che io ho voluto immettere in storie dure anche di migrazione che ancora accadono in Sicilia. Il ritorno a casa dopo duri giorni di lavoro e la felicità di essere nel posto delle tue origini.
D. Quindi per i brani prettamente in italiano come “Sciogli i capelli”, in parte abbiamo già detto che c’è un motivo?
R. Si la mia era una scelta innovativa e sperimentale, poiché io non volevo essere pedissequamente dialettale, volevo e questo successe un po’ per i giovani in Sicilia di allora, perché volevo la lingua parlata, nel senso che spesso la lingua tuttora di noi siciliani figlia dell’alfabetizzazione del dopoguerra, nei Sessanta tutti parlavamo l’italiano, e manteniamo però spero non si perda, il vernacolo: ossia le nostre lingue locali. La nostra lingua portata dai giovani era mista: un po’ siciliano e un po’ italiano con allocuzione in siciliano. Quindi spesso io entravo in questo modo duale di contaminare il linguaggio. Mi piaceva molto questo e l’uso dei suoni scelti di pari passo ai suoni del dialetto.
“Sciogli i capelli” ad esempio nasce dai miei studi classici. Nasce da un frammento di sasso, noi siamo figli anche della letteratura che avevo letto, e mi piaceva anche questa atmosfera provenzale, noi siciliani li abbiamo avuti un po’ tutti. Quindi siamo figli anche del dolce stil novo.
D. Quali musicisti hanno apportato il loro contributo?
R. Sono stati tanti, e sono stato veramente fortunato. Io ero all’esordio e quindi ho avuto due produttori, che sono stati assieme a me anche compositori delle musiche. Si tratta di un radiofonico ed compositore musicale Gianni DeBerardinis. Poi ci sono stati nomi come MassimoBubola, Lucio Fabbri, Mauro Pagani, WalterCalloni, Max Costa, Giancarlo Parisi, Fabrizio Cosmi, per un esordio per me è stato un onore e una fortuna poterli avere con me.
D. La scelta del vinile 33 giri non rischia per le vendite di diventare soprattutto un prodotto da collezione per pochi?
R. Assolutamente le do ragione. Ma oggi la vendita non esiste francamente più. Esistono gli streaming e persino il CD, che ai tempi fu innovativo, oggi non serve più. Ma al contrario del Cd che sembrò grande innovazione, il vinile è piu durevole e dal suono puro. È un’operazione culturale e non commerciale. Gli ultimi CD prima del cambiamento digitale, furono proprio il mio e quello diCapossela.
D. Ha mai pensato di intraprendere una qualsiasi collaborazione con una istituzione, tipo come da noi esiste il Centro di dialettologia ed Etnografia?
R. Mi piacerebbe moltissimo e sono già entrato in contatto con cultori e professori nella mia carriera, spesso vado in Sardegna dove sono molto attenti a questo. Ho fatto anche dei concerti lì in siciliano, con colleghi sardi e sicuramente in Sicilia ci sono vari studiosi che potrebbero interessarsene. Io ho fatto anche molte altre cose, colonne sonore per film, e spesso non sono bravo ad organizzare e conciliare tutte le cose. Ma ho cercato molte volte di venire in contatto con queste realtà, ma per ora non in maniera organica. Se accadrà ne sarò felice.
D. Secondo lei i dialetti sono a rischio?
R. C’è un forte rischio che il dialetto che chiamerei lingua minore pre-esistente alla lingua italiana e che tanto hanno dato come “affluenti” al “fiume principale”, possa disperdersi. Per questo, sono encomiabili tutti gli artisti i letterati e tutti coloro che svolgono determinati ruoli che ne permettono la conservazione e sopravvivenza. Penso che è un patrimonio che non va assolutamente trascurato e penso a Camilleri che ha riscosso anche un successo commerciale, ed è riuscito a riutilizzare il siciliano in libri di molto successo.
D. L’ultima domanda riguarda gli elementi della natura con la quale l’album pare fuso e mi chiedevo quale sia lo spirito puro del siciliano.
R. Lo spirito siciliano si distingue intanto per il sentimento che pervade questo album, io dalla Sicilia ero andato via e noi siciliani abbiamo spesso una frattura sentimentale con la nostra isola.Tomasi di Lampedusa descrisse la nostra isola come una madre con la quale si ha un rapporto conflittuale, tornando quindi alla sua domanda, il sentimento oltre che nella parola del dialetto, che contraddistingue il siciliano, è quello d’amore. Se si è profondamente siciliani si può scrivere anche in italiano come Verga da Milano, come i “Malavoglia” ma si sente lo stesso la forte sicilianità negli elementi della natura, e comeVincenzo Consolo.
La canzone che amo di più è “Suttu lu Mari”, ed è tratta a pié pari da uno dei racconti più belli della letteratura italiana scritto da Tomasi di Lampedusa: la storia mitica del ribaltamento del mito della sirena, che non è l’ingannatrice di Ulisse, ma l’amorevole dispensatrice di eternità, un mito tipicamente siciliano.
D. Cosa posso ancora chiederle?
R. Lei ha fatto delle domande veramente molto belle e interessanti, e la ringrazio per l’intervista che è andata molto in profondità e non sempre nelle interviste ci riescono. Peccato non potrà essere all’incontro con il pubblico di stasera, la sua voce nel dibattito sarebbe stata interessante.
Monica Mazzei
Freelance culturale