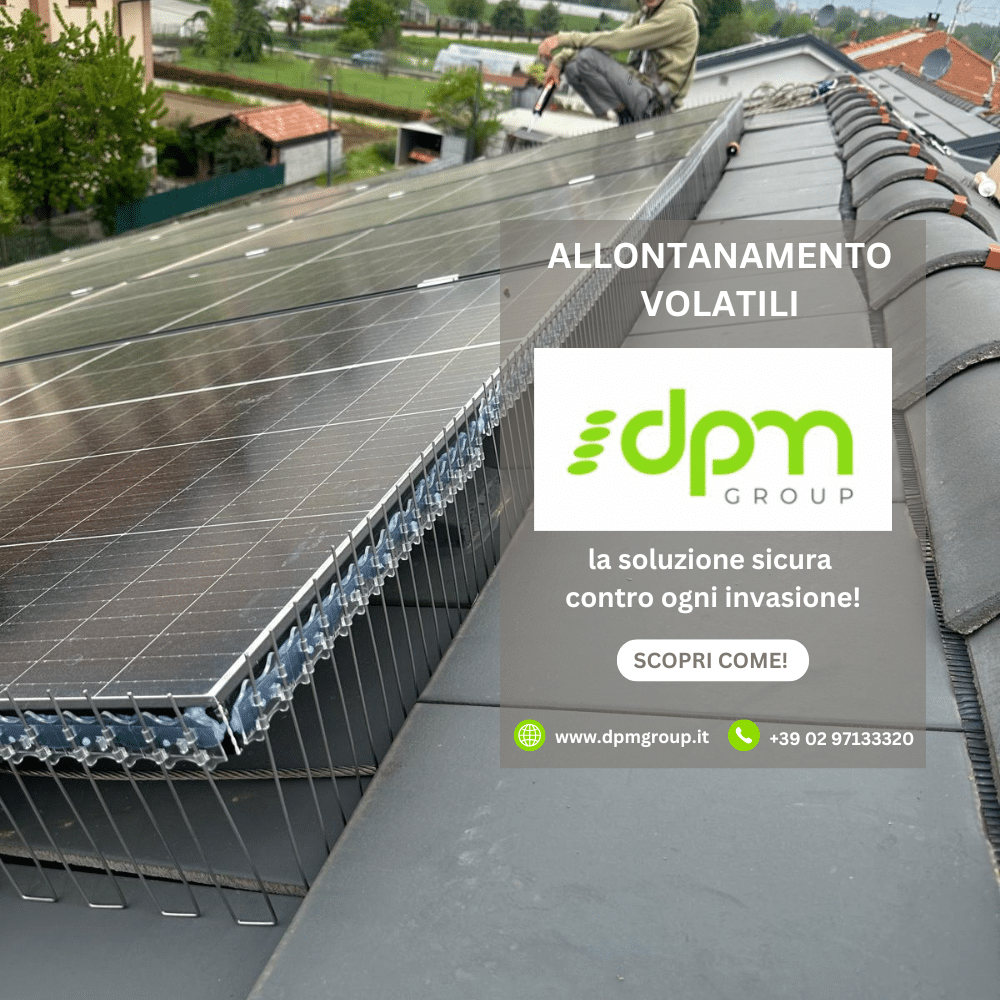A beneficio di chi finisce sempre per invaghirsi degli artisti che nella vita collezionano più sconfitte che trofei, ma che hanno dentro qualcosa di speciale.
Cagliari, anno 1990, pianeta Terra anche se sembra Marte. Il suolo è quello ricavato dalla vigorosa rullatura del mattone tritato, c’è rosso ovunque. Sotto ai piedi, sui vestiti, nei polmoni, con la polvere che smossa da suole che paiono tanti piccoli aratri impregna un’aria già densa, irrespirabile. Atmosfera marziana, quindi, poco ossigeno, pulsazioni che schizzano in alto, affanno. L’ambiente circostante è quello descritto da Ridley Scott in The Martian, quindi disagevole, che evoca nei protagonisti lo spirito di un sacrificio estremo. Con un’aggiunta non casuale al silenzio del pianeta rosso: una bolgia dantesca chiamata tifo, quello poco tennistico della Coppa Davis. Avvolgente, scomposto, spesso ingestibile ma appropriato. In un weekend decisamente non qualunque, lontano duecentomila ipotetici chilometri dal campo base, l’Italia del tennis il suo Mark Watney – un sopravvissuto, appunto – lo ha spedito davvero. Agli ordini di Capitan Panatta, ha sulle spalle il compito arduo di chi è chiamato a sovvertire un pronostico apparentemente blindato. L’uomo mandato dalla provvidenza tricolore a sfidare una leggenda è Paolo Canè. Un tipo bizzarro, lo si intuisce solo a guardarlo, ma che a tennis gioca dannatamente bene. Troppo, e non è detto sia un vantaggio.

Ha il viso scavato di chi potrebbe essersi fatto quaranta giorni nel deserto, una capigliatura generosa e ribelle che lambisce spalle non molto pronunciate e quattro arti troppo magri per un vestiario abbondante. Più che l’archetipo inflazionato del tennista, il quinto dei fratelli Ramones ma senza un paio di jeans sgualciti addosso. A generare musica ribelle non è però la Mosrite Ventures imbracciata dai padrini del punk bensì una racchetta, lo stesso attrezzo che, sempre a proposito di stravaganze, ebbe un giorno modo di frantumare sulle mani di uno spettatore poco interessato al gioco, intento, così com’era, a sorseggiare champagne in una fase concitata di match. Artista tormentato, Paolo da Bologna è il Modì nato sotto le due Torri nell’Italia del boom economico ma idealmente cresciuto nel Montparnasse maledetto di settant’anni prima, quale scherzo temporale del dio Chronos. Una benedizione per quelle stagioni azzurre di transizione, ricambio generazionale e pathos ai minimi storici.
Davis, dunque, primo turno. Sul punteggio di due partite pari, l’anarchico bolognese e Mats Wilander si contendono fin dalla domenica, perché nel frattempo siamo a lunedì, il passaggio del turno per le rispettive compagini. Paolino, attanagliato dal coacervo dei dubbi che pervadono chi intravede la chance di sovvertire una gerarchia precostituita, ha dalla sua due certezze da sommare all’abbacinante forma di talento di cui è depositario. Una, la consapevolezza che per sconfiggere un rivale di quella risma occorra disputare una maratona col piglio del centometrista. Tattica obbligata, quindi, quanto di meglio per non lasciarsi sopraffare in campo da pensieri fuorvianti. Due, davanti al pubblico amico non ha mai perso e vorrà pur dire qualcosa.
Quinto set, allora, cinque pari il punteggio con un equilibrio che in geometria si definirebbe stabile. Lo scambio intrapreso è estenuante, uno di quelli collosi che Wilander non perde praticamente mai, quando Paolo, intriso di acido lattico, rompe gli indugi. L’attacco per la verità non è un granché, tanto che il colpo di sbarramento dello svedese sembra risolutivo. Sembra, perché Canè, in trincea senza elmetto, gioca la miglior volée di rovescio di tutta la carriera, una smorzata in tuffo plastico, chiamando l’erede di Borg alla precipitosa rincorsa. Wilander, un felino, arriva sulla palla e con un tocco che trasforma la racchetta in una stecca da biliardo obbliga il nostro, nel frattempo rialzatosi, a mulinare le gambe disperatamente all’indietro. Non è dato sapersi con quali forze ma Canè su quella palla telecomandata giunge di nuovo e tira un passante sul quale Mats si limita a una soluzione interlocutoria: la sua condanna a morte. Canè, buttato fuori dall’occhio delle telecamere dal senso euclideo altrui, vede in una lontananza reale la pallina rimbalzare docile al centro del campo, chiede ai muscoli l’ultimo sussulto e vi si avventa, caricando il rovescio che il mondo del tennis gli invidia. Punto Italia.
Paolo, sepolto dall’abbraccio virtuale di una nazione francobollata al piccolo schermo in un mezzogiorno di fuoco e dall’urlo liberatorio del Galeazzi monumentale al microfono, si lascia crollare a terra esanime, in un tutt’uno con l’inglobante rosso di cui sopra. Una caduta che è l’inizio del trionfo perché la partita delle partite, il marziano per un giorno, finirà per vincerla. Paolo scrive così una pagina indimenticabile dello sport italiano che fu di Pietrangeli e Panatta, da quel momento un po’ meno soli. Gratitudine eterna.

Sfortunatamente, per lui e per i suoi tifosi necessariamente sui generis, la parabola di Paolo Canè non si è mantenuta con costanza sui livelli di eccellenza che avrebbero potuto far di lui un top player. Il motivo del sinusoidale “vorrei ma non posso” è ben sintetizzato da una chiosa che si attribuisce a Juan Carlos Ferrero, ex numero uno del tennis mondiale, che recita più o meno così: “Il gioco è mentale per il 50%, fisico per il 45% e tennistico per il restante 5%”. Una sentenza micidiale per tutti i Canè del mondo. In altre parole, stando all’autorevole parere dell’iberico, campione dall’abnegazione pronunciata ma dal talento così così, essere dotati di una dimestichezza tecnica sopraffina è condizione lungi dall’essere sufficiente per primeggiare in uno sport dai risvolti psicologici complessi e che necessita di un supporto atletico sostanzioso. La storia centenaria della disciplina ideata dal Maggiore Walter Clopton Wingfield come evoluzione dell’antica pallacorda è piena di conferme in tal senso. Uomini virtuosi la cui racchetta fu il prolungamento naturale dell’arto dominante, luminescenti alla vista ma dalla psiche fragile come cristallo se catapultati in un contesto agonistico serrato. A pensarci bene, la peggior frustrazione possibile, in un esercizio che, pur generandolo, non legittima il bello come metro assoluto di valutazione. E sui playground, pur nelle tante contraddizioni, Paolo era incantevole come pochi altri.

Non a caso un’esteta come Gianni Clerici ritiene che il felsineo sia ancora oggi da considerare il più grande talento che il tennis italiano abbia mai avuto. Con un neo implacabile sotto forma di un nervo ballerino. Paolo, sempre parafrasando lo Scriba, è infatti fatalmente somma di due personalità antitetiche: Neuro, il posseduto, e Canè, il ragazzotto eccentrico ma buono, con il primo che sta al secondo come Mister Hyde sta a Dottor Jeckill. Due facce della stessa medaglia che si alternano senza un filo logico nel ruolo di protagonista, al punto che ogni qualvolta Canè sia apparso in totale controllo di sé ecco irrompere sulla scena Neuro, la nemesi fatta in casa, a ribaltare il tavolo con sopra tutte le carte da gioco. Da assennato e persino tatticamente accorto a iracondo e sciagurato, tutto in un amen, quale profondo marchio di fabbrica.
E così la bacheca di casa Canè, soggetto più di molti colleghi alla severa legge di Ferrero, consta di “soli” tre titoli ATP, un bronzo olimpico e un best ranking fissato entro i primi 30 giocatori al mondo. Ventiseiesimo per la precisione, l’indomani il successo di Bastad, Svezia manco a dirlo. Molto per l’inaffidabile Neuro ma poco per il Canè capace di mettere in riga nei momenti di gloria campioni, tra gli altri, del calibro di Connors, Edberg, Wilander, Cash e Ivanisevic.
Classe 1965, un metro e ottanta per una settantina di chili scarsi, Paolo non è stato frenato nell’ascesa apparsa in diversi frangenti possibile solo dalla limitata propensione all’autocontrollo delle emozioni. Tra un’imprecazione urlata al cielo, qualche fioriera distrutta al Foro Italico – habitat che di rimando lo amava e odiava in egual misura – e innumerevoli partite scivolate via come sabbia per le dita, anche un fisico non propriamente garantito ci ha messo lo zampino. Limitata resistenza nella ripetizione ravvicinata dello sforzo e, soprattutto, una schiena fragile, vera disdetta per chi del tennis ha scelto di farne una professione. In campo, invece, il suo è stato un tennis ricco, arioso, caleidoscopico. Che a guardare annoiati i campioni stereotipati di oggi suscita un’irrisolta forma di nostalgia. Merito di un campionario tecnico completo, dove forse solo il servizio non fu di primissimo ordine, con un diritto carico, lavorato e moderno e un rovescio monomane – turbo, come fu definito – capace di coniugare l’eleganza del gesto all’efficacia letale delle soluzioni. Un lato sinistro del corpo che è naturalezza, una fucina di velocità e traiettorie inconsuete e vincenti. Paolo, al netto dei successi che non sono arrivati, ha personificato la nobile dottrina della variazione di angoli e rotazioni che si manifesta nella successione di scelte mai uguali, dunque imprevedibili, e dell’estro quale antidoto alla deriva monocorde di uno sport destinato già allora a essere egemonizzato dai robot del corri-e-tira. Rettore all’università del lungolinea, l’esercizio schematico di maggiore complessità, e uomo dalla capacità di tocco propria di chi, a tennis, potrebbe giocare anche con una padella, per la maggior parte degli addetti ai lavori Paolo ha disatteso le speranze che la comunità del tennis aveva riposto in lui. Forse. Perché se è vero che sono in molti a poter vantare un curriculum più prestigioso e la celebrazione oggettiva degli almanacchi, sono molti di meno gli atleti che possiedono i requisiti per essere iscritti all’esclusivo club di chi ha promulgato un tennis fatto di colpi senza tempo. Geni squattrinati, cavalieri erranti sposi di improbabili battaglie, marinai inaffidabili, inventori inascoltati, sognatori. Personalità folli, insomma, accomunate dalla capacità di far perdere la testa a chi, romantico il giusto, rigetta il ruolo egemonico del risultato nel nome della bellezza.
Paolo, affettuosamente ribattezzato da Panatta “l’uomo delle imprese” per i mismatch sfavorevoli ribaltati in carriera, ha avuto il pregio di trasformare in più di una circostanza un limite caratteriale penalizzante per genesi nella virtù di un momento baciato dagli dei del tennis. È il calore sprigionato dall’arena gremita da un pubblico amico – atmosfera da Davis, dunque – a fare di un inguaribile pazzoide un gladiatore senza paura. Pronto a sfidare a testa alta sé stesso, le sue incertezze, il suo avversario. Per uno spaccato temporale lungo un decennio che sarebbe delittuoso dimenticare, le missioni impossibili da risolvere su un campo da tennis tinto di azzurro, quelle per cui essere tifosi è innanzitutto un privilegio, hanno avuto per maestro di cerimonia proprio Paolino Canè, in una strana ma esaltante ingerenza del destino. Testa matta, cuore grande e turborovescio: tutto ciò che serviva per innamorarsi di lui. Allora circoletto rosso a prescindere, Neuro. E grazie di tutto.
(Teo Parini)

Alle prese con una verde milonga
Il musicista si diverte e si estenua
E mi avrai verde milonga che sei stata scritta per me
Per la mia sensibilità per le mie scarpe lucidate
Per il mio tempo per il mio gusto
Per tutta la mia stanchezza e la mia mia guittezza
Mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un sorriso
Di tregua ad ogni accordo mentre mentre fai dannare le mie dita
Io sono qui sono venuto a suonare sono venuto ad amare
E di nascosto a danzare
E ammesso che la milonga fosse una canzone
Ebbene io, io l’ho svegliata e l’ho guidata a un ritmo più lento
Così la milonga rivelava di se molto più,
Molto più di quanto apparisse la sua origine d’Africa
La sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera
(Paolo Conte)
Ci sono due generi di donne, ai quali un uomo può decidere di concedere non tanto e non solo il proprio cuore, ma tutta la sua follia e l’espressione più compiuta della parola Desiderio. Le prime, in vero decisamente preponderanti, carezzano la vita (e i sentimenti, e gli uomini cui decidono di concedersi) dominate dalla paura di rimanere sole, di sedurre impenitenti la solitudine, di cercare il riparo e il tepore di una vita relazionale serena. Senza colpi di testa, senza guizzi d’imprevedibilità. Poi ci sono quelle che sanno reggere lo stelo di un calice di Pinot Noir di Borgogna con incantevole voluttà, che seducono dalle dita sino a gambe flessuose fasciate in pantaloni di pelle, gettandosi verso il Desiderio del proprio amore con occhi neri che al fondo concedono d’intravedere la furia di uno Tsunami e la dolcezza mai stucchevole di uno Chateaux d’Yquem. Sono donne ai confini del Possibile, per chi le brama. Ma il solo rincorrerle, o il solo pensarle come oggetto d’Amore, rende la vita “veramente degna di essere vissuta”, come disse il più ammaliante dei figli di Joe Kennedy, quel Robert Francis Kennedy il cui sogno fu spezzato nel 1968.
Il tennis, una delle metafore meglio riuscite della vita, non sfugge alla medesima regola. Perché anche i giocatori di tennis si dividono in due: inutile vi si dica che Teo Parini ed io bruciamo di calda, irrefrenabile, incontenibile, smodata venerazione per quelli come Paolo Canè.
E siccome la summa delle sue doti tecniche è stata compulsata al millimetro di palla che corre imperiosa lungolinea, come il più riuscito dei passanti, dalla devozione di Teo, noi cercheremo di sviscerare le ragioni del perché, se non state dalla nostra parte, siete condannati ad un vita di triste mestizia. Non solo sportiva.
E allora riavvolgiamo il nastro del tempo per tornare al 1988. L’Italia del riflusso e la Milano da bere s’estendono magicamente fino a Saint Vincent, dove la gaudente Valle d’Aosta- gonfiata di denaro proveniente dall’autonomia e dal Casinò- decide di scalare i piani della Dolce Vita politica e sportiva organizzando un torneo internazionale di tennis in pieno agosto.
Dura poco, ma è uno spaccato iconico degli anni Ottanta e della corsa irrefrenabile dell’Italia sino alla quinta piazza delle potenze mondiali, stando ai dettami di quel Pil che Bobby (profetico..) smascherò come vani poco prima di essere assassinato.
Dunque, torneo internazionale di Saint Vincent: nani, ballerine, telecamere Rai, dolce vita tra i monti, Bisteccone Galeazzi che interrompe una telecronaca pomeridiana per annunciare che un amico ha pescato delle ottime trote di montagna, e che si sarebbe prospettata una cena luculliana.
Ci sono due ragazzi, classici villeggianti lombardo-piemontesi, appassionati di tennis e di pallacanestro. L’occasione è ghiotta: sul ‘centrale’ del piccolo centro montano, agghindato a festa, sfilano alcuni tra i più grandi terraioli dell’epoca (la superficie era la terra rossa): i nostri Claudio Pistolesi, Claudio Panatta, Diego Nargiso, il divino Kent Carlsson, principe di Svezia, cui solo sfortune ed infortuni negano la conquista del trono che avrebbe meritato: quello di più grande terraiolo di fine anni Ottanta. Più di Wilander, dei nascenti spagnoli, più di tutti.
Era martedì, o mercoledì, quando il match clou delle 20.30 vede scendere in campo Paolino Canè contro un malcapitato carneade, di cui non resterà traccia nella storia del tennis (e tanto più nella nostra memoria). E’ un Canè che di lì a poco, nel catino di Cagliari, vestirà i panni di Leonida contro re Serse. Ma c’è già tutto, nella sua imperfetta completezza. Le telecamere, le luci, soubrette e starlette di arte varia: Paolino Canè è inquieto, quella sera. Il principale avversario, come sempre o quasi, non è l’incolpevole dirimpettaio di rete. Il nemico da battere è quell’intricato groviglio composto dai suoi demoni, dalla sua inquietudine, dai suoi avvolgenti fantasmi interiori.

“Cazzo che mal di pancia, mi scappa da cagare!”, prorompe in un urlo a 10 centimetri da un inebetito raccattapalle, certamente più fortunato del giudice di linea che chiama ‘Out’ un servizio del bolognese con una frazione di ritardo. ‘Fai così, domani mattina ti alzi, fai colazione, alzi il telefono e dici pronto, la palla era fuori. Ma vaffanculo!”.
E via così, tra un turbo rovescio che fende la discesa a rete del carneade come il coltello arroventato taglia il burro, un paio di dritti incrociati che mandano in visibilio i compassati valligiani, pugno verso il cielo appena Canè sente che la platea, il pubblico, lo desidera. Lo brama. Lo venera. Ecco perché il risultato conta poco o relativamente. Infatti Paolo Canè quel torneo non lo vincerà, eliminato ai quarti o giù di lì da qualche onesto mestierante della racchetta.
E’ tutta qui, o quasi, la prossemica sportiva di un Campione che senza conquistare le masse del tennisticamente corretto ha acceso d’amore e di attrazione (quella più pericolosa, come accade per i malti di Scozia che furono la concausa della dipartita terrena di Fabrizio De Andrè; non sono cose per tutti, e non è questione di stomaco o capacità di reggere gli alcoli).

Paolo Canè è stata un’icona perfetta dei rutilanti anni Ottanta, specie se visti dalla prospettiva filtrata dalle corde di una racchetta. McEnroe, Connors, Lendl, Gattone Mecir, Edberg, il giovanissimo Pete Sampras, l’altrettanto inquieto Ivanisevic, la leggendaria coppia di doppisti formato da Flach e Seguso.. Paolino Canè, senza aver alzato insalatiere al cospetto del duca e della duchessa di Kent, o atteso ad ampollose cerimonie retaggio dei fasti pre rivoluzionari al centro del court Philippe Chatrier, appartiene e apparterrà per sempre all’aristocrazia del tennis.
Vi s’insinuerà sempre, come vorreste facessero i vostri occhi, il vostro cuore, il vostro respiro (e le vostre mani) dentro quegli occhi, e attorno a quelle gambe. Come un ladro o come un assassino, avrebbe detto Ivano Fossati. Perché il vero amore per il beau geste, nella vita e nel tennis, conta più della vittoria. E l’attesa del piacere, quand’anche non diventasse mai vero piacere, ti accompagnerà per tutta la vita. Molto più e molto meglio di una rigidamente forzata copulazione, umana e tennistica.
Del resto voi con chi andreste a cena, con Canè o Wilander? Meglio un giorno da Canè, che cento anni da Wilander…
Et alors, monsieur Canè, ca va?
Fabrizio Provera
Jimmy, non credi che possiamo
offrirci un pranzo da pascià
a questo punto della nostra vita
vento d’autunno quindi entriamo qua
Jimmy, non so se sei d’accordo
abbiam mangiato una bontà
e caso mai possiamo farci anche un bel giro
con quelle due, ma ci vedi tu fin là
Jimmy, non pensare
zitto che il nemico ci ascolta
Jimmy, non giurare
con te stesso: è l’ultima volta
ne abbiam viste tante di regine
andare sull’altro marciapiedi
al sole e noi nell’ombra
ombra e sole è sempre così
Jimmy, ridendo e scherzando
non vorrei dire, però
ci meritiamo, di più
di più, di più, di più
Jimmy, di più
(Paolo Conte)

Jimmy Villotti, chitarrista jazz e sodale di Paolo Conte
E invece come un ladro come un assassino
Vengo di giorno ad accostare il tuo cammino
Per rubarti il passo, il passo e la figura
E amarli di notte quando il sonno dura
E amarti per ore, ore, ore
E ucciderti all’alba di altro amore
E amarti per ore, ore, ore
E ucciderti all’alba di altro amore
Perché l’amore è carte da decifrare
E lunghe notti e giorni da calcolare
Se l’amore è tutto segni da indovinare
Perdona
Se non ho avuto il tempo di imparare
Se io non ho avuto il tempo
Di imparare
(Ivano Fossati)
DEDICATO A MATILDE, E ALLA SUA AFFOLLATA SOLITUDINE