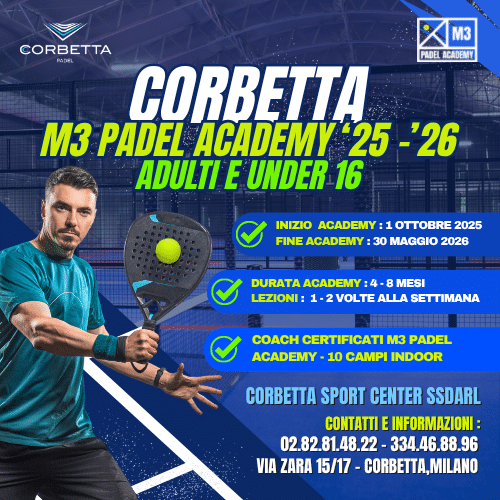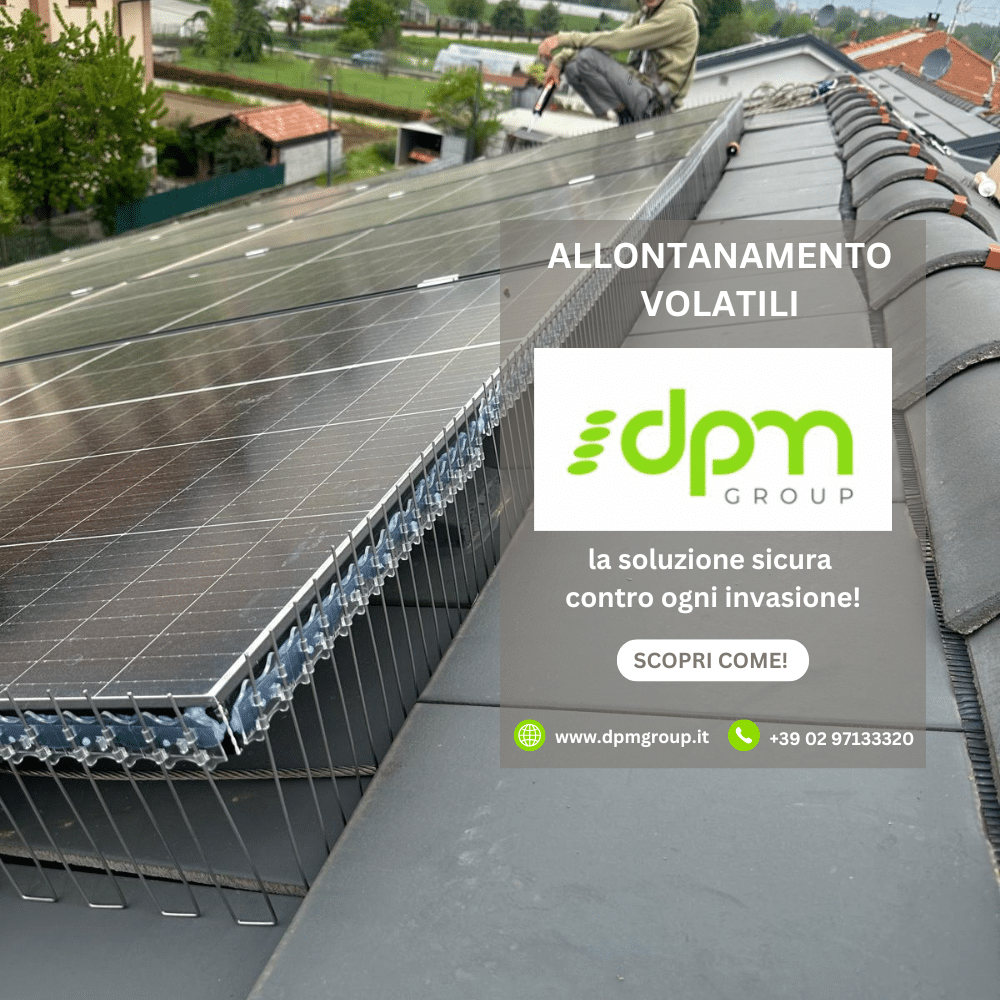Non è nostra abitudine vendere tappeti e qualcuno deve prendersi la briga di dire le cose come stanno. Il Giro d’Italia, evento nazionalpopolare, fenomeno identitario di costume, società e cultura, in questa edizione sta esplorando i suoi minimi storici. Un disastro su tutta la linea che è un attentato al nostro patrimonio genetico. All’uopo, la giornata di ieri ne è l’attestato tridimensionale. Tappa numero sedici, nata per far transitare i corridori dallo Stelvio (Cima Coppi) poi sostituito dal passo Umbrail per questioni di sicurezza, ma quest’ultimo era praticamente la stessa cosa per collocazione e altitudine quindi con buona probabilità anch’esso impraticabile, infine neutralizzata nella sua lunga parte iniziale dopo un tira-e-molla tra i corridori decisi a non fare la discesa dell’Umbrail sotto la neve – sacrosanto, ma quanto sono lontani i tempi del Lupo del Gavia – e gli organizzatori, più interessati agli affaire di contorno e relativi desiderata che a trovare una soluzione decente, sportivamente parlando.
Così, la partenza è un caos dantesco, tra corridori che non si presentano nei tempi stabiliti, risibili passerelle pubblicitarie della carovana prima ideate (la sfilata cittadina a Livigno) e poi cancellate, il trasferimento in macchina imbastito in fretta e furia con i bus delle squadre già partiti e non si sa bene perché, fino allo ridefinizione della partenza con riduzione della tappa a poco piu di un centinaio di chilometri. Tutto deciso minchiam, sui due piedi, da un’armata Brancaleone organizzativa in evidente stato confusionario e in balia delle esigenze di chi paga la baracca, e ci può stare, e delle volontà dei corridori, peraltro comprensibili nel caso specifico. Ma chi pensa che le disgrazie siano finite con l’avvio della corsa commette un errore di sopravvalutazione delle nefaste circostanze.
Se, infatti, il lato gestionale è paradigma di come non debbano essere fatte le cose, quello prettamente sportivo, che al solito ci interessa di più, è stato, se possibile, anche peggiore. Più che una tappa, a Milano, quella di ieri, la si definirebbe una mano di ‘ciapa no’ sotto alle intemperie. Insomma, non se la voleva aggiudicare nessuno. Chi per volontà, quelli della UAE, chi per stramba inadeguatezza tattica, gli altri, ed è finita nell’imbarazzo generale con il monarca Pogacar che se l’è dovuta prendere controvoglia e non è un’iperbole. È successo che sull’ascesa finale, dopo il pasticcio dei Movistar che hanno finito per inseguirsi da soli prima di mettere ko il loro stesso capitano, le operazioni ricadessero sulla squadra della maglia rosa, la cui voglia di vincere era pari a quella di farsi l’Umbrail nella tormenta, cioè nulla.
Tanto che, nella pochezza generale, Pogacar ha giustamente pensato di concedere una giornata di gloria al fidato Majka, gregario enorme ma nell’occasione senza la gamba per correre in proprio. Così, terminato il solito lavoro del compagno, Pogacar si è ritrovato in testa al gruppo e pure da solo perché, nel frattempo, i rivali (si fa per dire) di classifica erano già rimbalzati tutti all’indietro. Davanti, reduce dalla fuga, un gigantesco Pellizzari, il più giovane dei partecipanti, che, seminato uno per uno i compagni di avventura, cominciava ad assaporare l’aria dell’impresa. Gli ultimi duemila metri, però, sono risultati surreali, non un bello spettacolo.
Invece, bontà loro, hanno scelto l’assolo dell’uomo solo al comando, col risultato di una corsa dallo stesso interesse di una puntata di Porta a porta. Senza mancare di rispetto a nessuno, perché se c’è una cosa che non fa difetto ai ciclisti è l’amore per la disciplina e la più assoluta dedizione alla causa, non aver saputo portare al via di questa edizione del Giro corridori più attrezzati dell’eterno Thomas, a cui va la massima stima, o di Martinez, gregario formidabile con in tasca metà della vittoria rosa di Bernal, è una colpa irredimibile per chi ha il privilegio di organizzare un evento così italiano. Evento che, duole dirlo, per una serie di ragioni non propriamente fortuite è passato da avvicinare in qualche frangente l’egemonia e il blasone del Tour a perdere anche il primato sulla Vuelta che, oggi, è corsa di maggiore appeal e il lotto dei partecipanti lo conferma.
Più in generale, si assiste ad un’epoca ciclistica per certi versi senza precedenti. Dove cinque corridori fanno uno sport e tutti gli altri ne fanno un altro.
Così, nella malaugurata circostanza per la quale solo uno dei dioscuri risulti presente, come in questo Giro, il lato agonistico della vicenda è irrimediabilmente compromesso, tanta è la differenza di cilindrata. Tornando all’arrivo di ieri, vedere Pogacar fare brandelli della concorrenza senza volerlo e in conserva perché con un occhio già al Tour, il tutto nel contesto di una classifica che vede tra lui e gli altri lo spazio di un’era geologica, è motivo di grande rammarico. Perché il Giro d’Italia, per storia, tradizione e ruolo sociale, si merita di meglio. Fortuna vuole che Tadej sia proprio un bravo ragazzo: l’abbraccio finale con Pellizzari e lo scambio della maglia che ha reso orgoglioso l’azzurro, sono gesti che riconciliano con lo sport e ci ricordano che i ciclisti, anche quando tutto intorno butta male, sono sempre persone speciali.