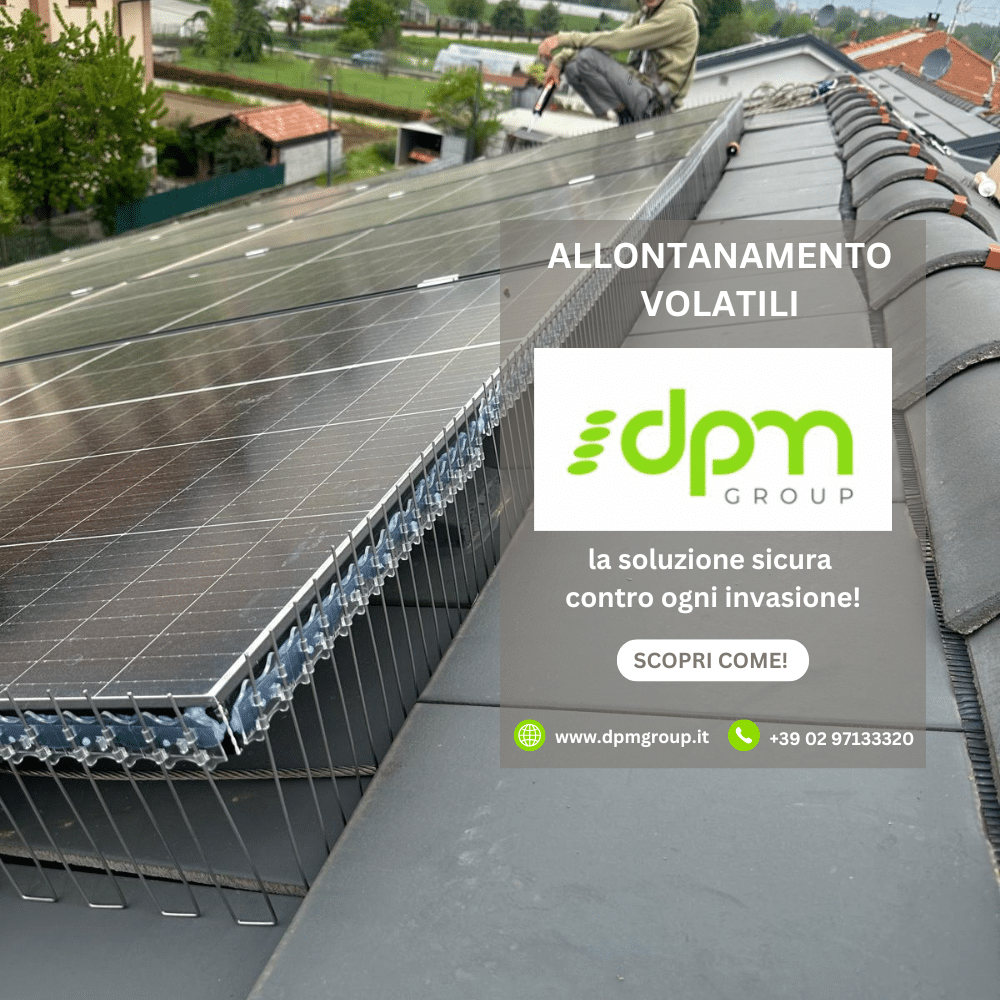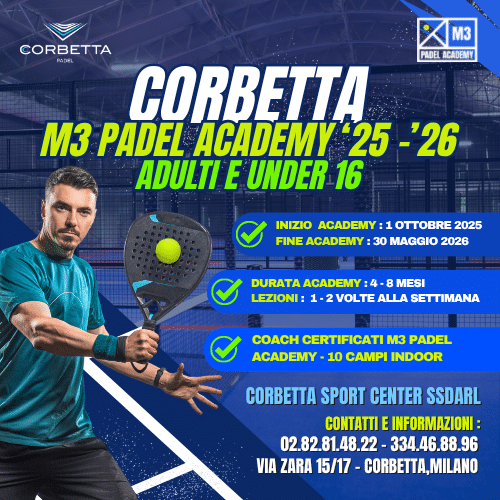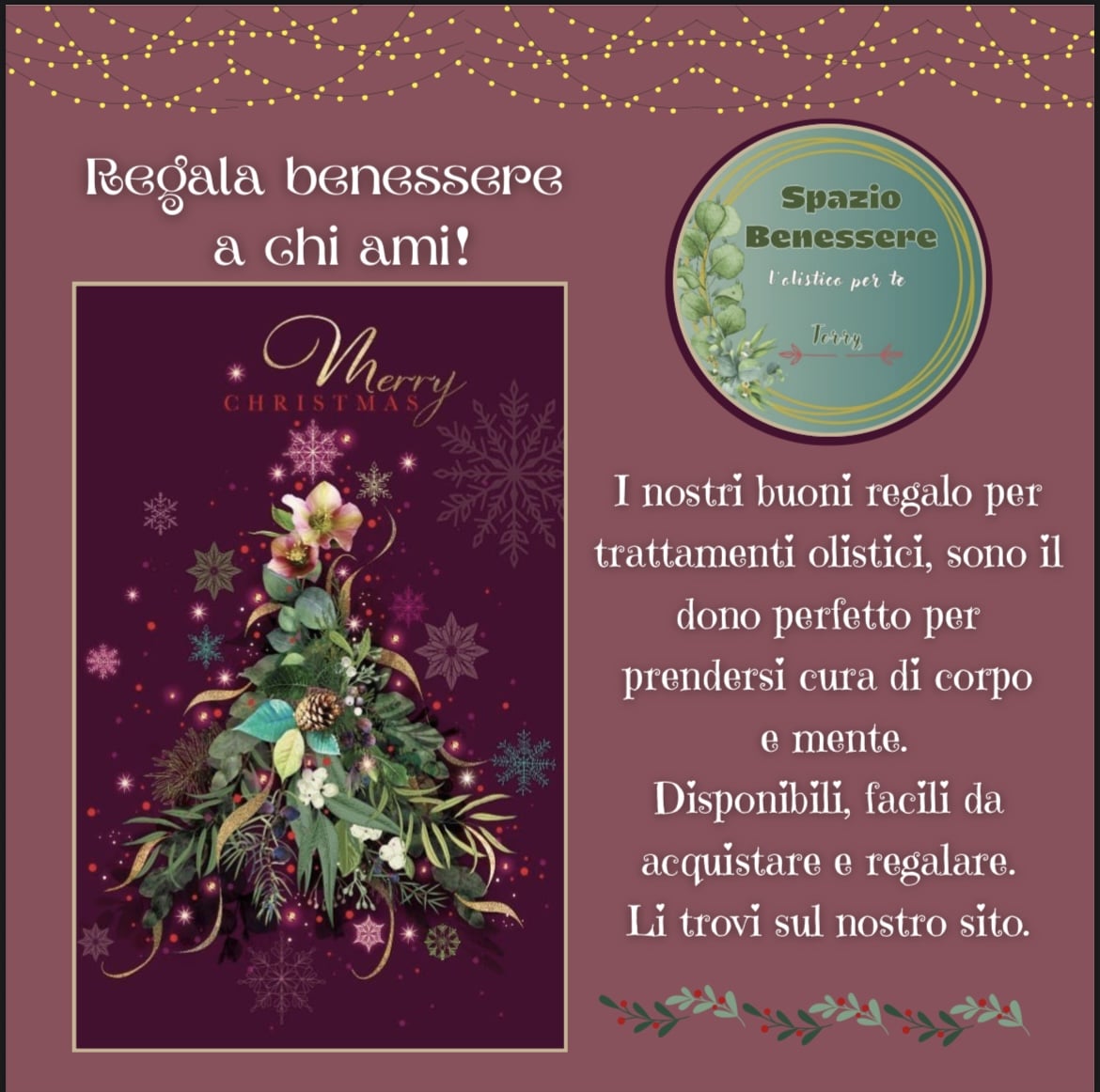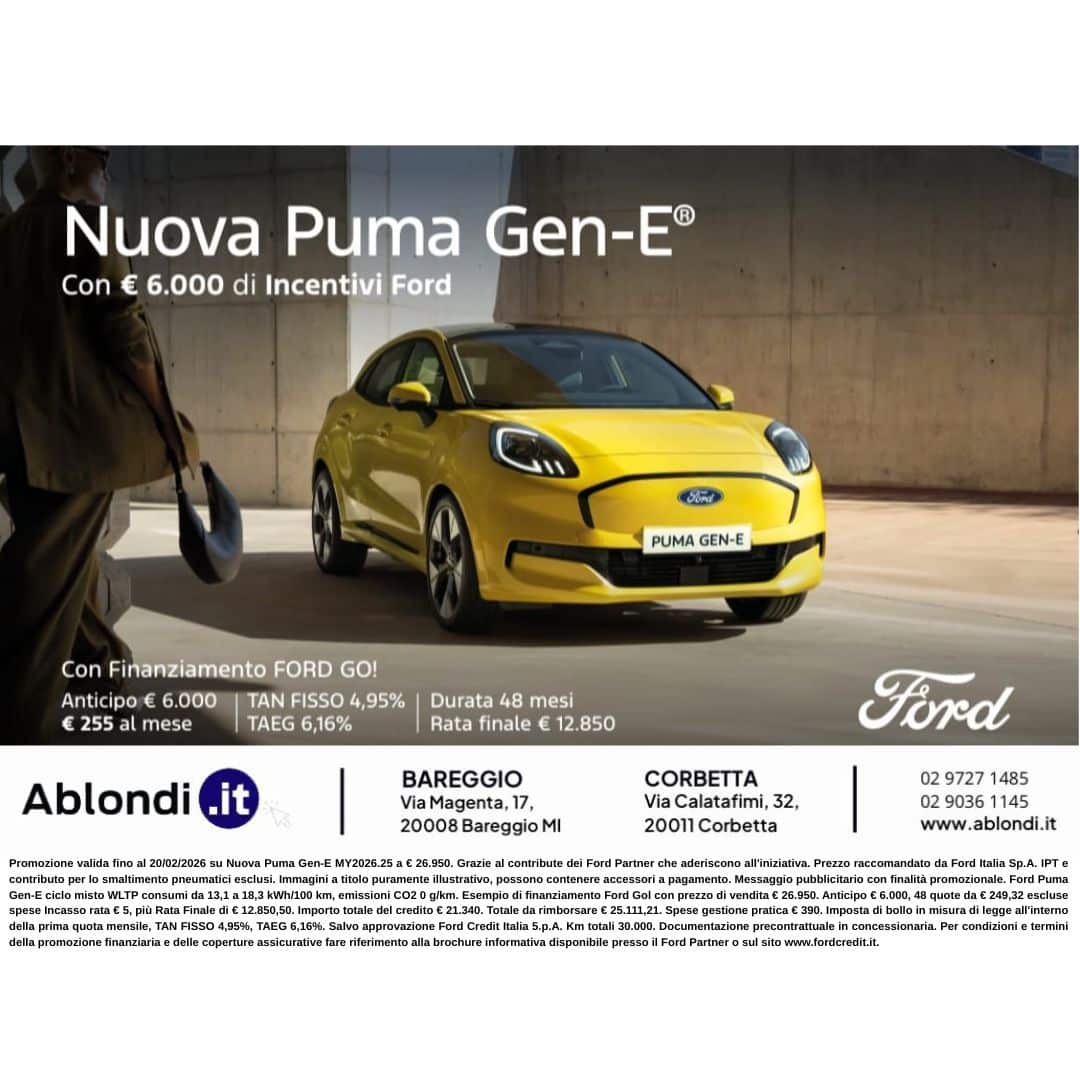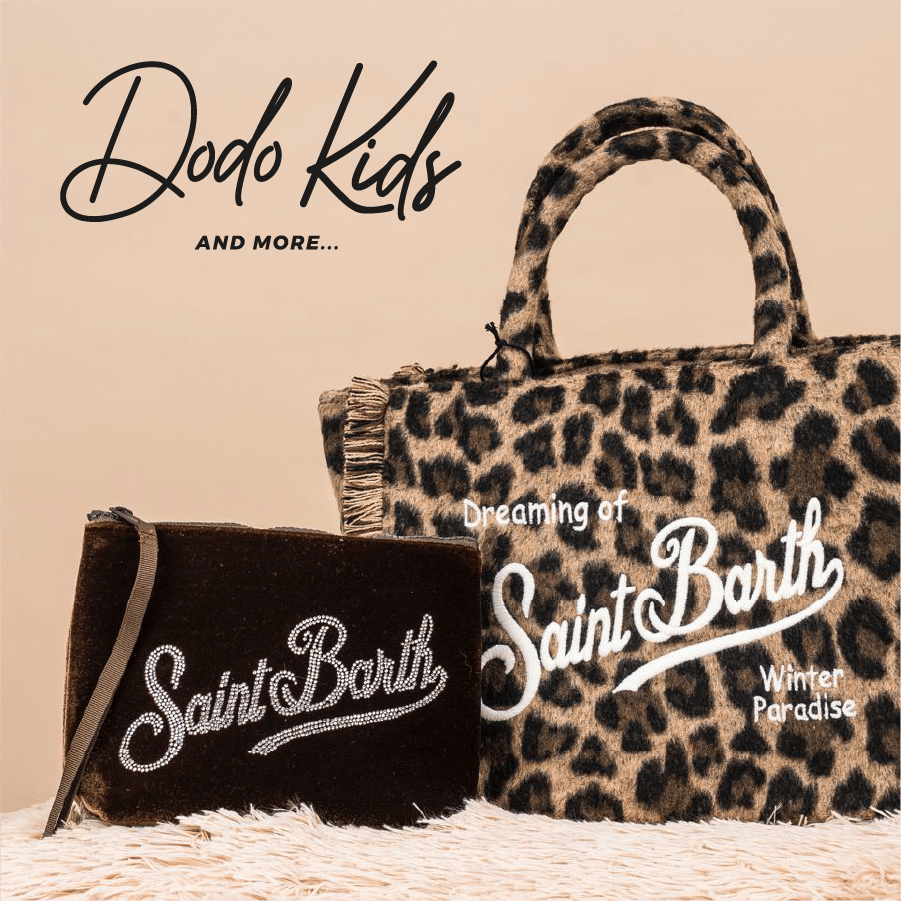“La musica sveglia il tempo”, dice Daniel Baremboim. Il tempo è invisibile, è inodore, non è udibile. Eppure, senza di esso, non esisterebbe la musica; che lo impiglia tra le battute dello spartito rendendolo visibile, udibile, percepibile ed addirittura eseguibile! Uno strano effetto, poi, quello dell’insieme, perché alla fine di tutta questa fatica per scrivere, suonare e mostrare il tempo, rimane invece una sensazione di “senza… tempo” !
Al tema del “Tempo”, cosa sia, come ci avvolga ed accompagni, come ci lasci invece “nudi” davanti all’imperscrutabile; a questa dimensione, Totem ha voluto dedicare la stagione musicale 2024-25, dopo un anno di pausa forzata dovuta ai doverosi lavori di messa in sicurezza del bel teatro Lirico. Perché la musica, suonata ed ascoltata dal vivo, è davvero una esperienza di risveglio : fuori e dentro il tempo.
Dove ci eravamo lasciati ? (per chi vuole)
… Ci eravamo lasciati all’estasi dei “Poemi Sonori”, programma dell’appuntamento del 29 aprile 2023, con la bacchetta fulminante del direttore Lorenzo Passerini, la meraviglia dei musicisti delle Orchestre Vivaldi e Città di Magenta; con l’incredibile emozione del violoncello di Enrico Graziani che ci ha commossi e stupefatti sia come ‘solo’ di orchestra sia nel bis ‘insieme’ ai colleghi violoncellisti: un gioiello poco noto, “Adoration” di Florence Price. Perle che il pubblico del Lirico può scoprire grazie agli spazi musicali che l’associazione culturale magentina “Totem – La tribù delle Arti” ci propone in un crescendo di cultura, abilità e complessità artistiche.
Il programma di Sala di quella memorabile serata (Enescu, Strauss e Shostakovic), a voler guardare, dopo un anno e mezzo, ci ricollega, come percorrendo un ‘tunnel temporale’, al primo appuntamento con la stagione in corso. Sono diversi gli elementi che accomunano.
Sabato 16 novembre il concerto inaugurale della Stagione sinfonica di Magenta 2024/2025.
“Mahler”
L’epoca storico-musicale, a grandissime linee, è quella della contemporaneità, quando gli autori cominciavano a riflettere e lavorare sulla “scomposizione” delle forme romantiche e le nuove domande di “senso”, soggettivo e non, che, con il finire del XIX secolo e dei suoi pilastri storico-esistenziali, emergevano per poi esplodere prepotentemente in una realtà europea in preda ad enormi mutamenti di cui ancora oggi possiamo valutare la portata. Ancora oggi, terminato anche il XXI secolo, siamo di fronte ad un analogo fragore… .
Dall’esplorazione musicale del tardo romanticismo (tecnicamente, “modernismo”) alla nostra contemporaneità la questione del rapporto tra l’uomo ed il tempo non cessa di interrogare e frugare il fondo della nostra coscienza: individuale e collettiva.
Da “nona” (di Shostakovic) a “nona” (di Mahler), eccoci di nuovo al punto. Eccoci di fronte al mistero del tempo e del senso dell’esistenza umana: sulla terra, nel cosmo?
Sabato sera al Lirico l’Orchestra Vivaldi con L’Orchestra Città di Magenta (orchestre “in residenza”), diretti dal maestro Maurizio Agostini (curriculum di eccellenza), ci hanno condotti oltre la soglia del contingente, del transeunte, inglobandoci nei movimenti sonori, quattro, creati da Gustav Mahler tra il 1909 ed il 1910, con i quali il maestro si congedava dalla vita quasi a volerne riassumere la irregolare, quanto ineluttabile, parabola. La propria ed universalmente quella di tutti. Una parabola fatta di contraddizioni, di momenti aurei od oscuri; di meraviglie e di frenesie, di armonia e di caos, di dramma e di requie. Tutto questo attraversiamo con la sinfonia, in tutto questo – l’esistenza in mundo – ci diamo da fare inseguendo il tempo ed i modi della storia.
Mahler ripercorre il tempo dell’uomo, si confronta con il “finito”, ciò che è finito, e guarda oltre esso.
Nel primo, sublime, movimento, forme di grazia e bellezza, come frammenti sonori emergenti dall’oscurità, ninfee, che svaniscono e si trasformano in suoni altri, turbamenti, perdite, attraversati dal tempo e dalla coscienza che esso stesso genera. Tutto è cristallino quanto labile, reminescente. La memoria della bellezza e la coscienza della sua caducità, corruttibile come tutto ciò che avviene in terra.
Il silenzio in cui si chiude questo prima parte lo ritroveremo protagonista nell’ultima. Veniamo immessi quindi in una seconda età, secondo movimento, fatto di accenni di danze, marce, di slanci giovanili (tratti dai materiali popolari e tradizionali, come usavasi nel romanticismo) che presto si tramuteranno in stridore, in caricature delle forme sonore. Lo sguardo retrospettico non può non marcare l’illusione fino a rappresentarne, terzo movimento, il lato grottesco, quello del del “mondo”, dell’affanno vorticoso, realtà beffarda, che ci costruiamo o cui siamo costretti; che ci travolge ed impiglia come in una rete – uno spazio delimitato e turbolento – dentro la quale perdiamo il senso primigenio, forse anche la percezione, di una vita più profonda ed ampia che “batte il tempo” con ritmo nascosto.
Il quarto movimento, l’ultimo, è in verità ‘il cuore’ della Nona sinfonia in Re maggiore. Qui tutto è placato; tutto si è consumato, siamo al “finito”. Le note divengono rarefatte, dialogano intensamente con il silenzio. Quando il battito rallenta, dove ci troviamo? In quale spazio temporale? Il tempo ci attraversa o siamo noi stessi fatti di tempo? Esistiamo oltre di esso?
Di sicuro, l’arte sa contenere questa sostanza sconosciuta; dando forma all’informe anche quando la forma si storce o si cancella.
Ed ecco il viaggio biologico, filosofico ed estetico di Gustav Mahler . Ottanta minuti e quattro movimenti in cui gli elementi compositivi ed orchestrali, nelle forme tipiche romantiche, vengono manipolati e sottoposti ad ardue prove di maestria e durante i quali siamo attraversati da molteplici sentimenti.
Reminescenza, bellezza, l’illusione dell’armonia, la sua perdita, il distorcersi delle forme, il loro frammentarsi; dall’ironia al sarcasmo, al rifugio nel ritmo primordiale, nell’unica forma perfetta fatta di silenzio.
Dall’arpa al clarinetto, dal corno alle campane, legni e timpani, archi, ottoni e percussioni. L’Orchestra dà il meglio di sé, sottoposta – con percepibile impegno di energie fisiche ed emotive – ai repentini cambi e complessi registri della partitura.
Sotto la guida del maestro Maurizio Agostini (esperienza, curriculum e sensibilità di eccellenza, date un occhio alle note di sala) gli strumentisti hanno profuso abilità ed energie donandoci questo viaggio mozzafiato nella grande riflessione di un genio sull’orlo dell’infinito.
La musica classica è davvero “classica” : tratta di qualcosa il cui valore non termina, non finisce. Continua a generare ed accogliere o risvegliare il nostro bisogno di comprendere, esprimere, sentire.
Ci piace sottolineare qui anche l’introduzione all’opera, dal palco, a cura di Matteo Vercelloni (violoncellista dell’orchestra): in una manciata di minuti parole sublimi quanto la musica stessa che poi avremmo ascoltato.
I prossimi appuntamenti della Stagione.
Il prossimo appuntamento di stagione sarà a dicembre, sabato 21. Dopo una traversata tanto titanica il programma propone un alleggerimento con le belle musiche tratte dal “magico mondo Disney”. Una formula ormai collaudata dalle maggiori orchestre sempre apprezzata dal pubblico e che ben si accompagna al periodo natalizio.
Pausa a gennaio, si riprende il 15 febbraio con un concerto cameristico, “L’archetto virtuoso”, ricco ed accattivante (musiche di Franck, Ravel, de Sarastase, Fiorenza, Tartini).
Sabato primo marzo tornerà sul podio il maestro Passerini e ci tornerà con Brahms : concerto per pianoforte ed orchestra in si bemolle maggiore e sinfonia n. 1 in do minore.
Venerdì 14 marzo concerto sinfonico a cura del conservatorio di Novara con il direttore Nicola Paszkowski.
Ultimo appuntamento sabato 12 aprile: Bach e Bruckner per vivere il mistero della Pasqua. Orchestre Vivaldi e Città di Magenta, Coro degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano diretto dal maestro Filippo Dadone; sul podio Ernesto Colombo.
Il programma è consultabile sul sito di Totem Magenta, del Comune, del Teatro Lirico, di Pro Loco e dei media magentini.
Alessandra Branca