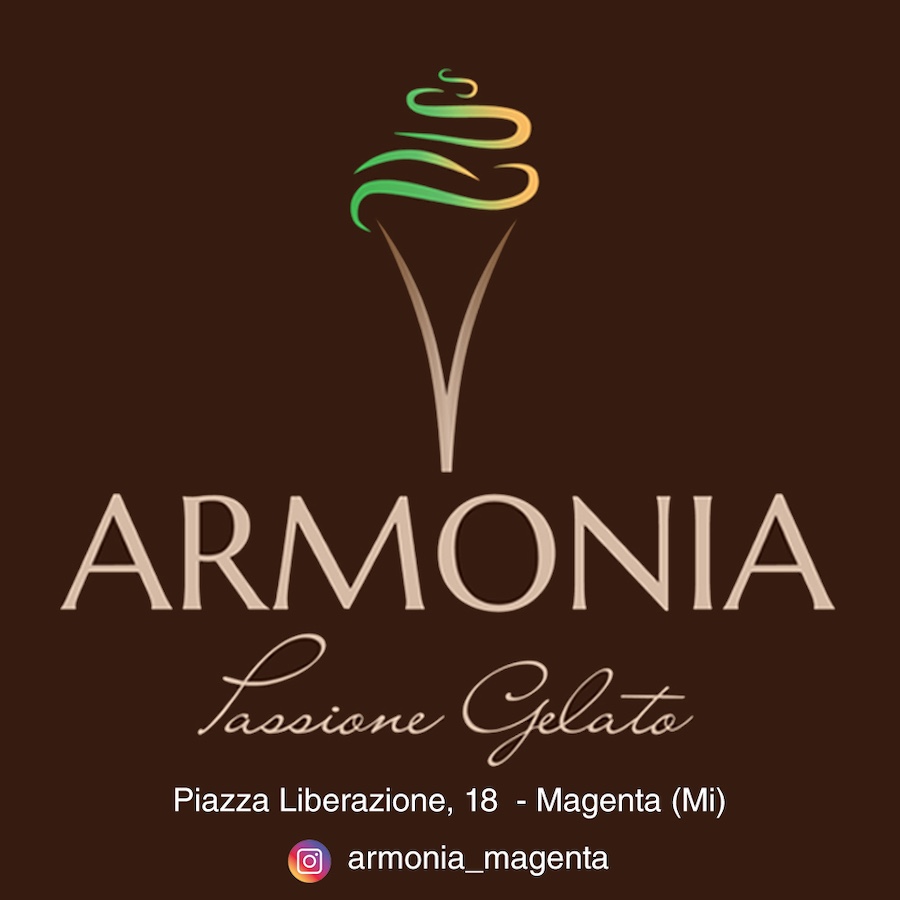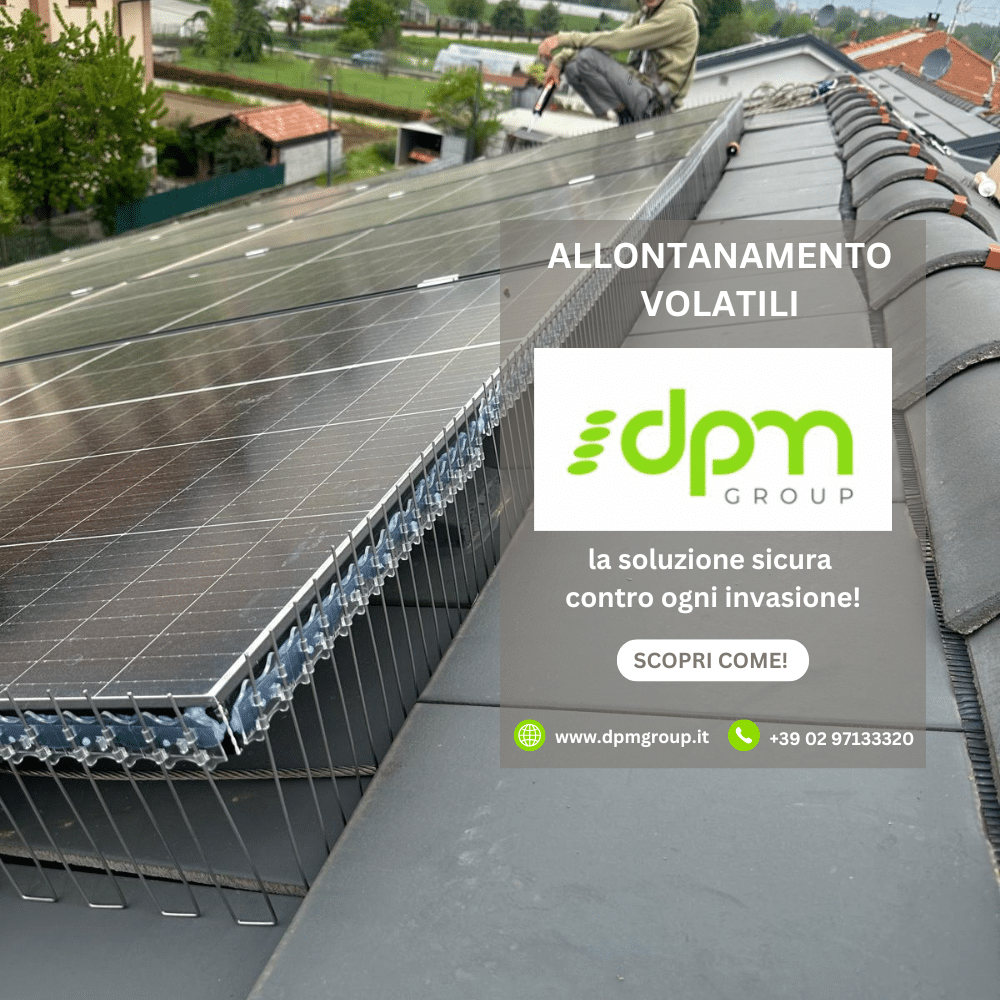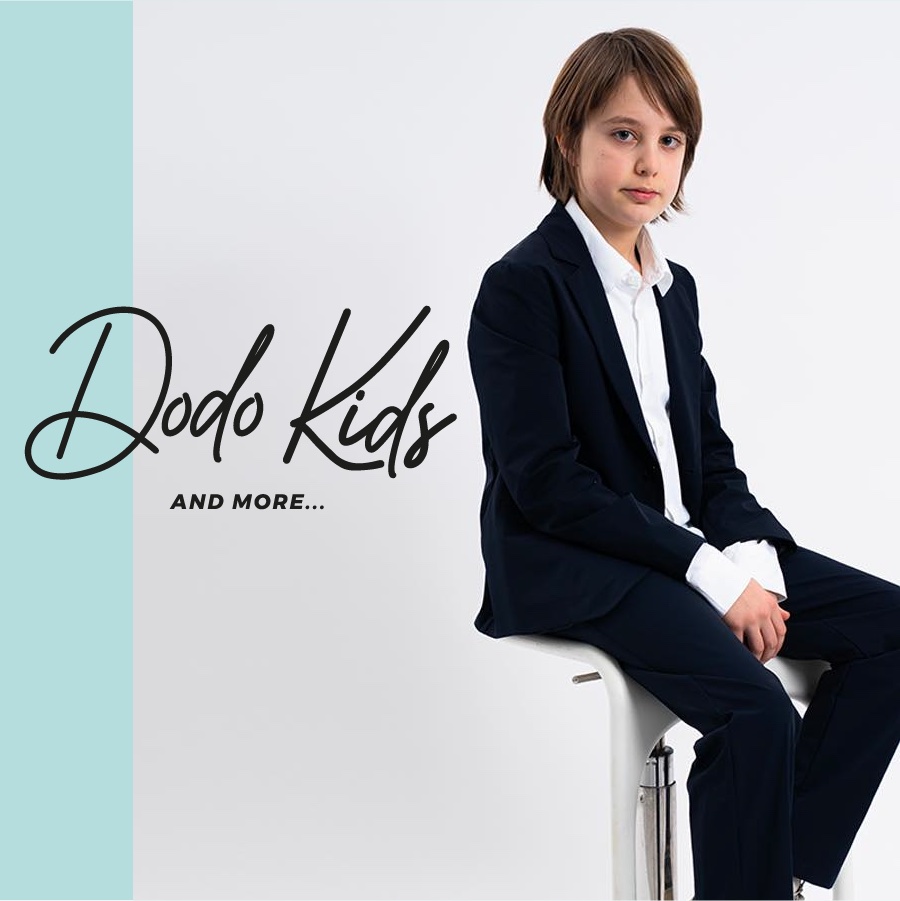Il Naviglio Grande è una presenza amica per gli abitanti dei paesi che sono attraversati da questo antico canale, una sorta di pellicola in cui si è specchiata la storia: attraversamenti di eserciti, feste, viaggi, amori e attività produttive che hanno accompagnato la vita di tante generazioni.
Per chi non se lo ricordasse, il canale fu messo in cantiere dai milanesi nel XII secolo, dopo la battaglia di Legnano del 1177, allo scopo di difendersi dai pavesi fedeli al Barbarossa.
Si procedette convogliando le acque del Ticinello, un fossato derivato dal Ticino presso Tornavento, biforcandole a Castelletto di Abbiategrasso: il ramo di maggior portata fu diretto a Milano prendendo appunto il nome di Naviglio Grande, che poi, nel 1272 fu collegato alla fossa interna della città. L’altro ramo, invece, fu diretto a Pavia col nome di Naviglio di Bereguardo. Si trattò di un’opera gigantesca se si pensa all’epoca della sua costruzione e al percorso lungo ben 50 km. Se dovessimo confrontare quel dispendio di energie, di capitali e la sua utilità a qualcosa di moderno, potremmo paragonarli a quelli della costruzione di un’autostrada, se non addirittura ad un complesso aeroportuale.
Nel 1252 iniziarono i lavori di prolungamento: in un primo tempo da Abbiategrasso a Gaggiano, poi fino a Milano. Tra i promotori del prolungamento del canale ci fu, per sua disgrazia, anche l’allora podestà di Milano Beno de’ Gozzadini. I libri di storia lo ritraggono come un uomo energico, che era già riuscito a realizzare delle importanti opere pubbliche. E tra i suoi progetti vi era, per l’appunto, anche questo, ma mancavano i soldi. Così domandò al clero di contribuire economicamente al lavori, ed era così convinto dell’utilità del prolungamento che nelle riunioni comunali riuscì a convincere ventiquattro notabili che era necessaria una tassazione. Seguirono molti intrighi e il povero podestà fu accusato di concussione e il popolino, esasperato per la tassazione, aizzato con l’inganno da certi consiglieri, trascinò in istrada il Gozzadini dove ne fece strazio gettando poi il cadavere nel fossato della città. Il collegamento con Milano fu così rimandato di qualche anno e così, all’originaria funzione difensiva si aggiunsero quella del trasporto delle merci, incrementata soprattutto dalla costruzione del Duomo, per il quale necessitavano marmi, legname, pietre, tutte merci che viaggiavano per concessione di Gian Galeazzo Visconti.
I barconi dal fondo piatto che trasportavano queste merci portavano la scritta AUF (Ad Usum Fabricae), che i milanesi ben presto trasformarono nel vernacolare “A uf”, cioè a sbafo, gratis.
Oltre alle merci, sui barconi navigavano per pochi soldi anche le persone, mentre i nobili che raggiungevano le loro residenze campagnole, usavano imbarcazioni private.
Lungo il canale gravitavano lavandaie, pescatori, cestai, scopai, che utilizzavano per la loro produzione le piante acquatiche come il salice e la saggina.
Le acque del Naviglio venivano sfruttate altresì per ottenere energia idraulica che azionava le ruote e le turbine dei mulini.
Se la prima metà dell’Ottocento rappresenta l’apice nell’utilizzazione delle vie navigabili di tutto il milanese, durante la seconda esse perderanno importanza come via di trasporto merci e passeggeri, sostituite dalle ferrovie che erano sì più care, ma la maggior spesa veniva ammortizzata dalla velocità.
Oggi il Naviglio Grande continua ad essere utilizzato per irrigare ampie aree agricole e, nell’alto milanese, anche per raffreddare gli impianti della centrale termoelettrica di Turbigo la cui diga viene usata per regolare il flusso dell’acqua, ma esso ha acquisito anche una funzione di svago: gite in battello, gare di canoa, pedalate lungo le alzaie, spuntini e pranzi in vecchie e nuove trattorie. La vita continua.
I miei romanzi storici li trovate nelle librerie e nei bookshop on line.
A cura di Luciana Benotto