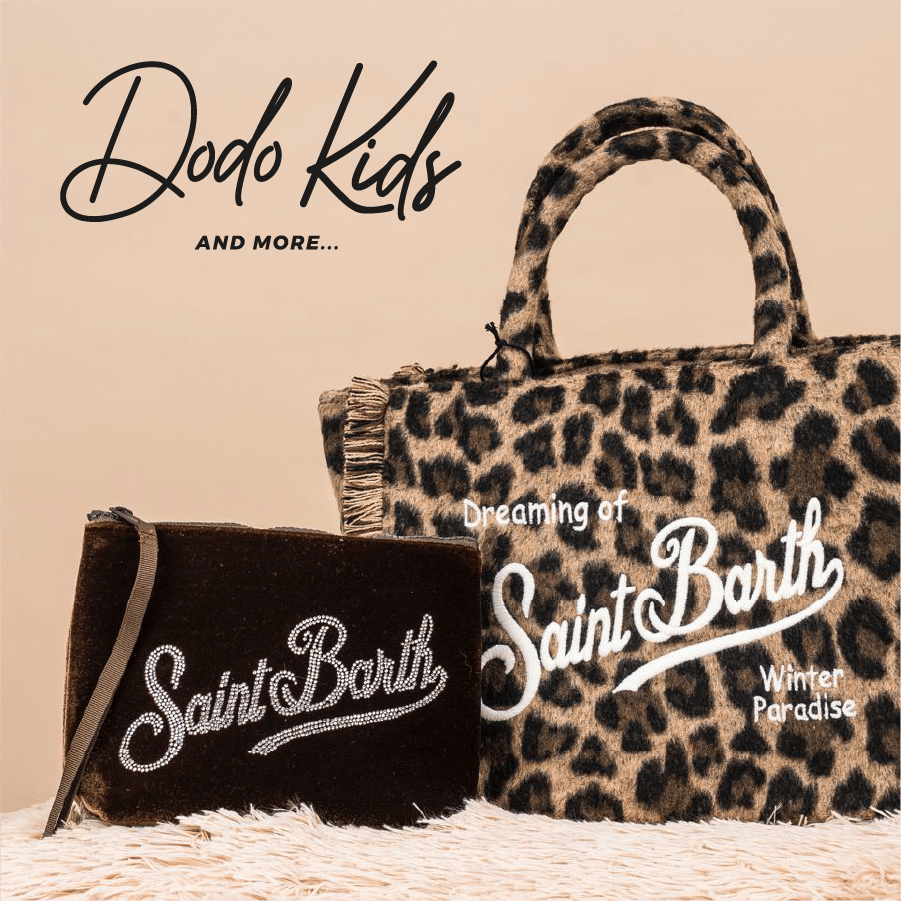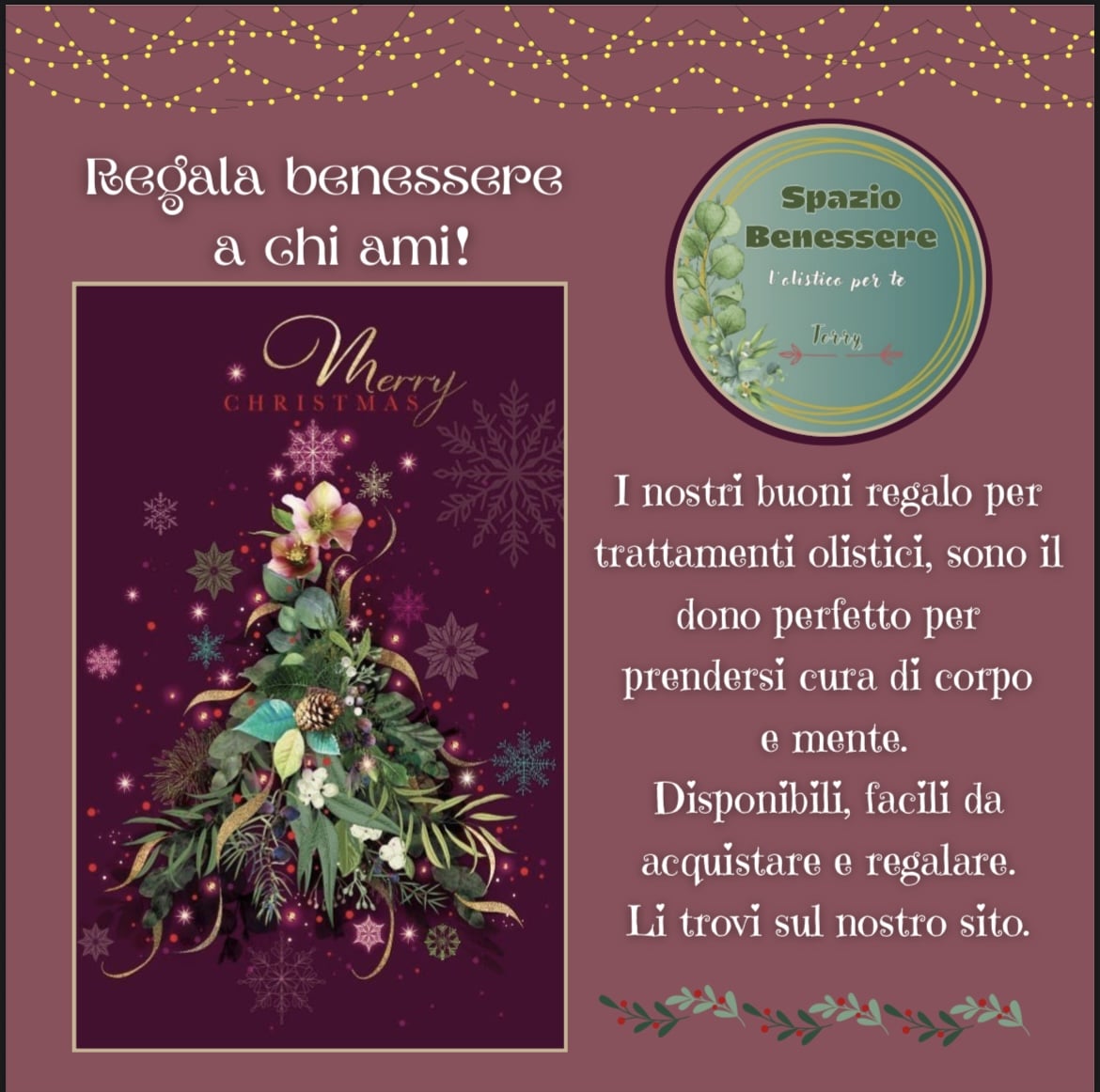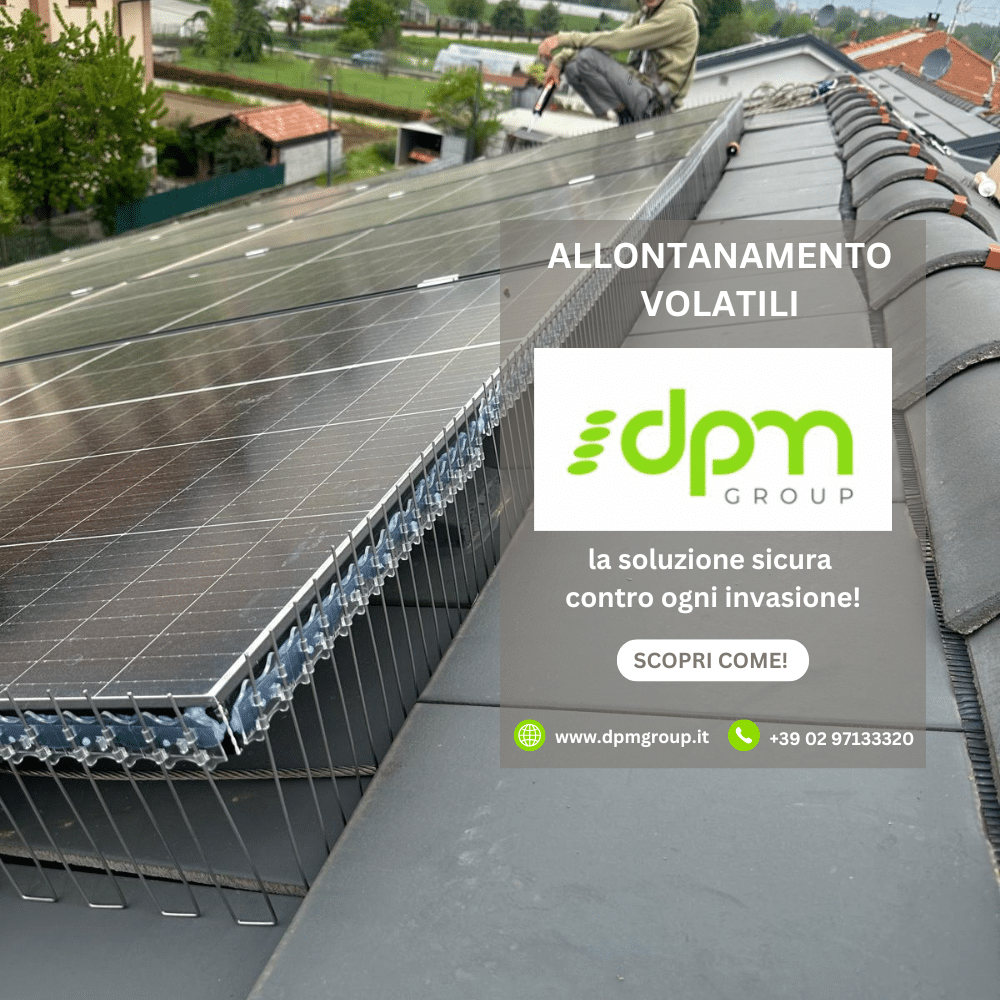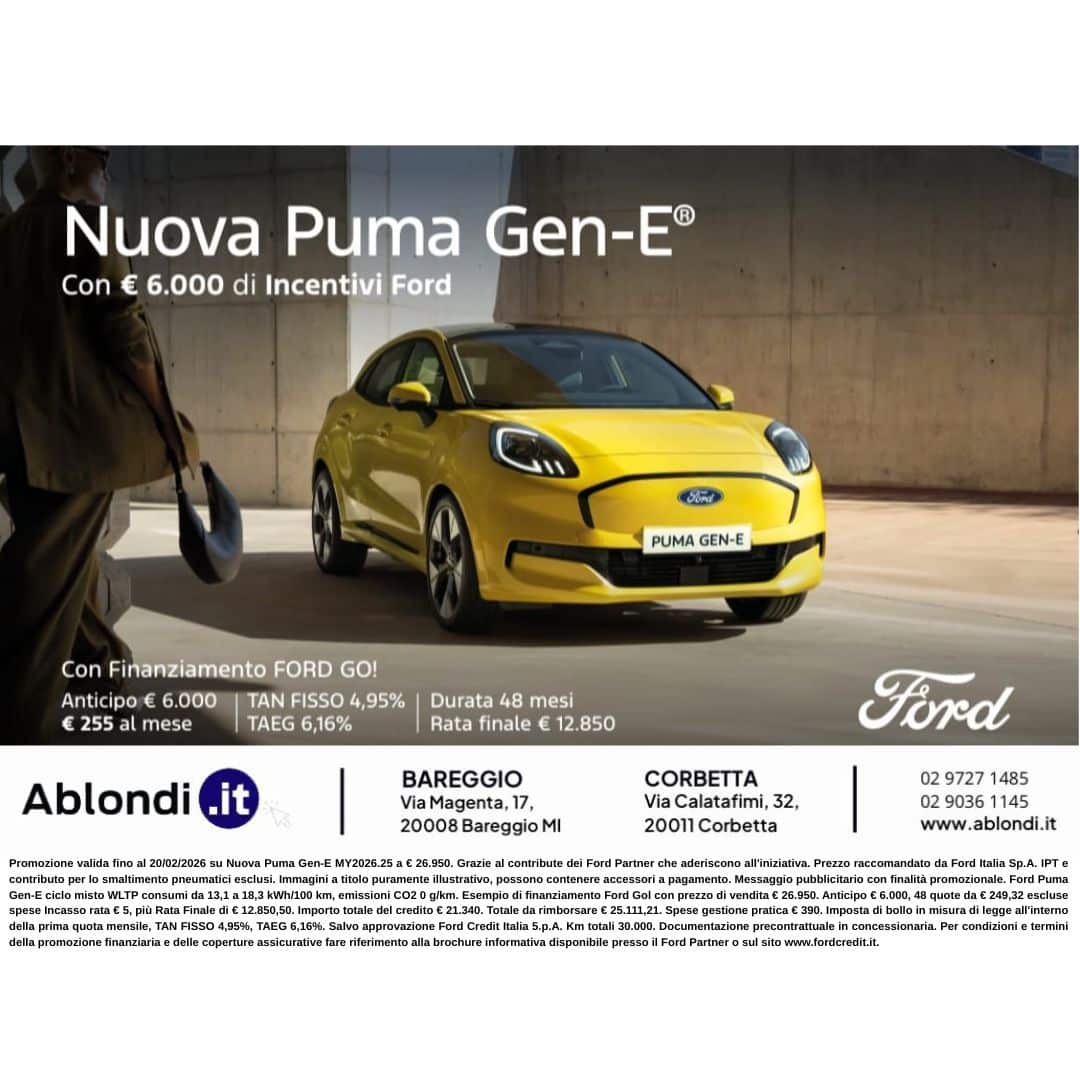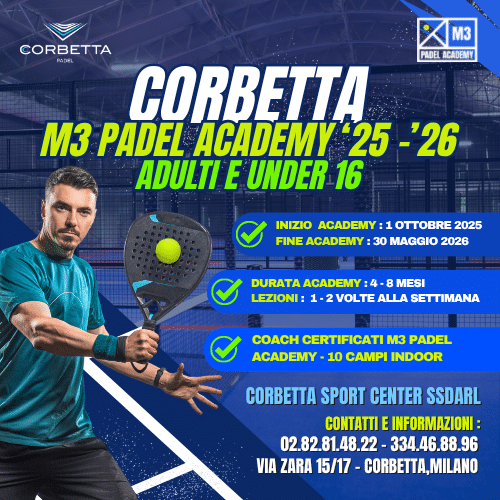Oggi è il turismo domenicale a muovere l’economia che ruota attorno al Ticino e al Naviglio Grande, ma un tempo c’erano i lavori “d’acqua dolce”, lavori che davano da vivere alle nostre genti. Vediamo di rammentarli insieme e di far rivivere con un po’ di nostalgia quel mondo costellato sì di fatiche quotidiane, ma anche ricco di poesia.
Come non ricordare quello dei barcaroli, un mestiere che ha attraversato indenne secoli di storia, sino a quando la velocità di barche e barconi a fondo piatto è stata surclassata dal trasporto su gomma, nonostante certe merci pesanti e di scarso valore intrinseco fosse più conveniente trasportarle via acqua. Ma prima di sparire del tutto, questa professione ebbe un’impennata dal secondo dopoguerra agli anni Sessanta del Novecento, dovuta alle esigenze di ricostruzione di Milano duramente colpita dai bombardamenti del ’43, e poi grazie anche alla migrazione dal meridione durante il boom economico, migrazione che vide aumentato il bisogno di case, necessità che fece incrementare il trasporto di ghiaia e sabbia a Milano, tanto che in quegli anni i nostri barcaroli trasportavano ogni giorno nel capoluogo lombardo tonnellate di sabbia che caricavano dalle cinque cave distribuite tra Turbigo e Boffalora tramite una trentina di barconi. Le ore di lavoro erano così tante che capitava che essi dormissero in barca.
Un altro mestiere legato all’acqua era tutto al femminile: stiamo parlando delle lavandaie. Diversi pittori hanno ritratto queste donne chine sugli appositi lavatoi di pietra, talvolta con in testa un cappellino di paglia o un semplice fazzoletto che le riparava dal sole e un po’ meno dalla pioggia. Queste scene, talvolta idilliache sulle tele, nella realtà nascondevano un lavoro massacrante che ha spezzato molte schiene, rovinato mani sempre immerse nell’acqua fredda, acqua che ha procurato reumatismi a generazioni di donne. Fare il bucato grosso era una faccenda pesante, ci voleva una salute di ferro e braccia robuste, visto che i panni bagnati sono faticosi da strizzare e da battere. Di solito i panni erano ritirati la domenica, poi il lunedì venivano messi a bagno nell’acqua leggermente insaponata, indi si passava al bucato vero e proprio che avveniva nella cà de bugà dove c’erano un fornello dotato di una caldaia di rame e grandi mastelli. Il fornello serviva a preparare la lisciva ottenuta facendo bollire la cenere o la soda caustica, che veniva versata sulla biancheria coperta da un telo che fungeva da filtro, dopodiché la si lasciava in ammollo. Per ultimo si andava al Naviglio per il lavaggio finale eseguito con spazzola e sapone, che si concludeva col risciacquo. Insomma, la lavatrice era ancora di là da venire.
Un altro lavoro era quello dei raccoglitori di sassi di quarzo. Essi lavoravano in coppia quando si trovavano sulla particolare imbarcazione affusolata adatta allo scopo: mentre uno governava la barca, l’altro adocchiava i sassi e li raccoglieva; ma se si sera soli, la raccolta, forse meno fruttuosa, poteva avvenire anche sul greto del Ticino. Il quarzo veniva poi venduto alle vetrerie di Murano, dal momento che fornisce la massa vetrosa, base delle pregiate lavorazioni. Ma il Fiume Azzurro era battuto anche dai cercatori d’oro. Essi setacciavano la sabbia, come ancora qualcuno fa tutt’oggi, per trovare le pagliuzze o i granelli lasciati dai ghiacciai del Gottardo e del Sempione dopo l’ultima glaciazione. Un tempo i veri cercatori, individuato il luogo che ritenevano adatto, assaggiavano l’acqua per sentire il sapore del nobile metallo; a quel punto prendevano una tavola detta banco che aveva delle apposite incisioni, che servivano a trattenere i granelli, dopodiché quanto rinvenuto si spostava nell’albiolino, con cui si eliminava la sabbia rimasta e poi l’operazione si concludeva con un’ulteriore fase di pulitura, ed ecco finalmente emergere l’aureo brillio. Ovviamente non possiamo dimenticare i pescatori di professione, che nelle acque limpide cercavano pazientemente di far abboccare cavedani, trote, lucci, tinche, balbi e carpe per sbarcare il lunario. Oggi però quelle acque limpide non esistono più: il Ticino come tanti altri corsi d’acqua è inquinato, ma di lui rimane però la magica atmosfera del tempo che fu.
I miei romanzi storici li trovate nelle librerie, nei bookshop on line e nelle biblioteche.
A cura di Luciana Benotto