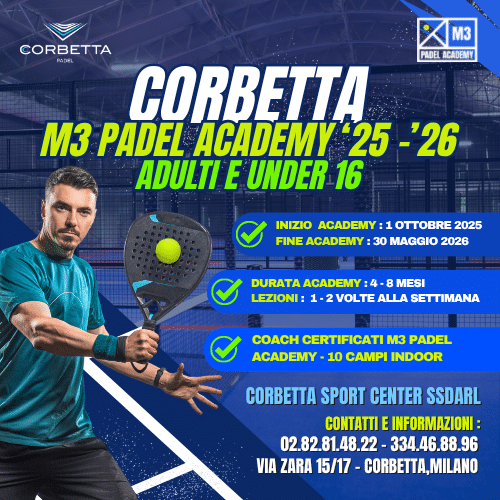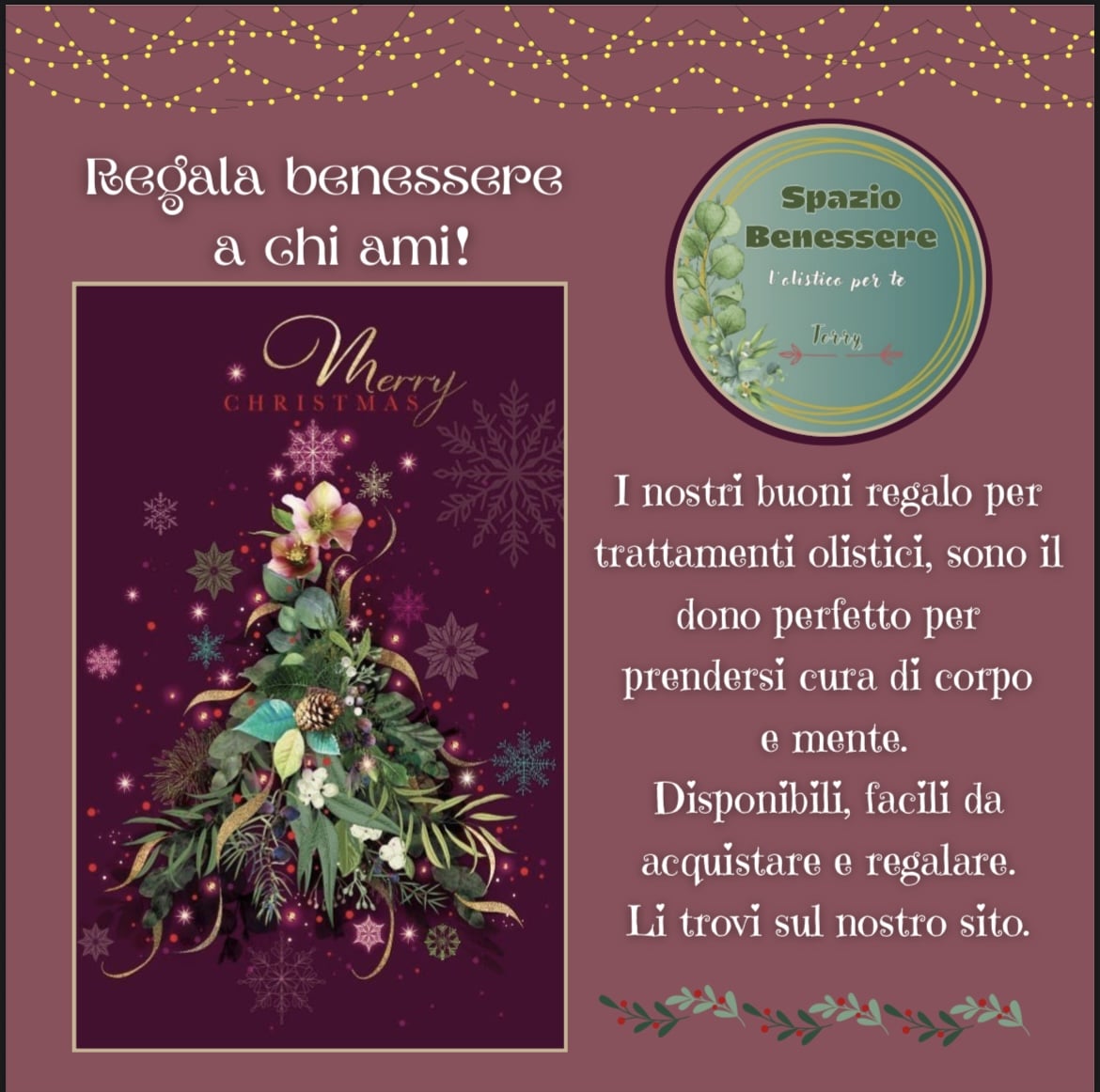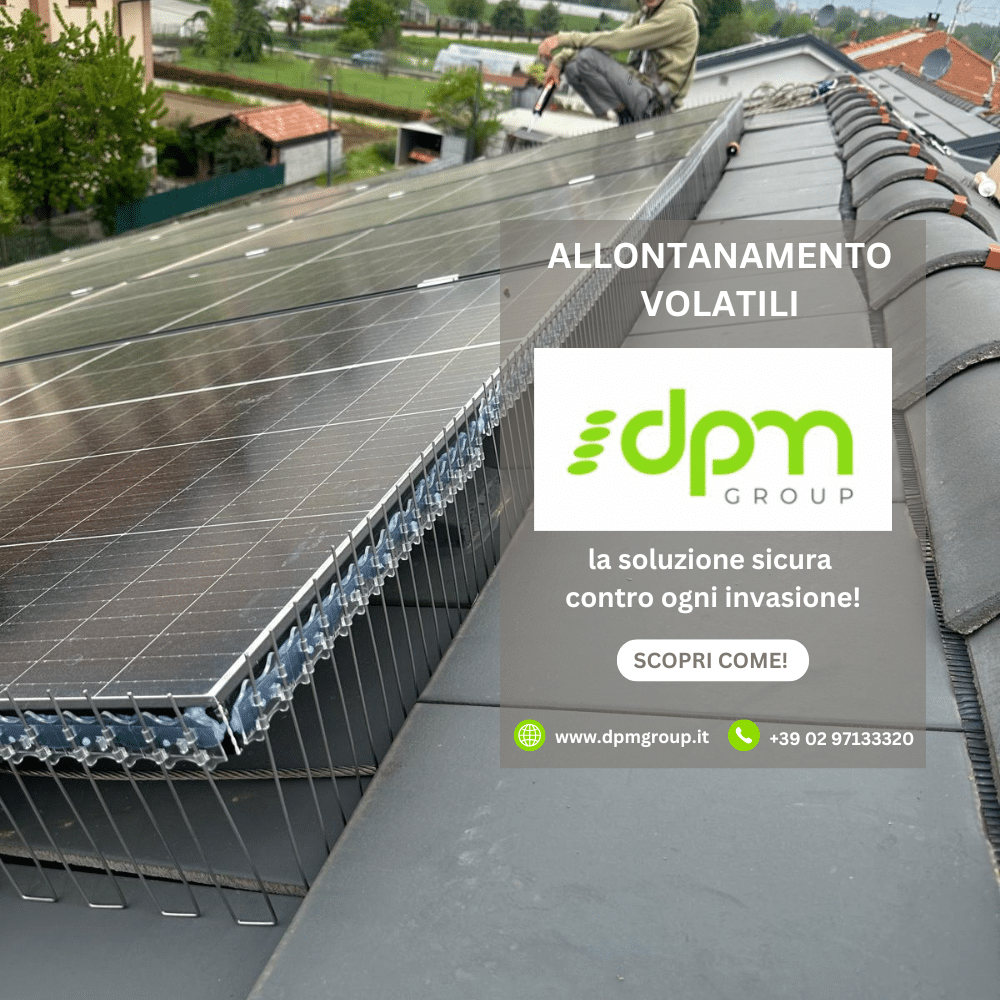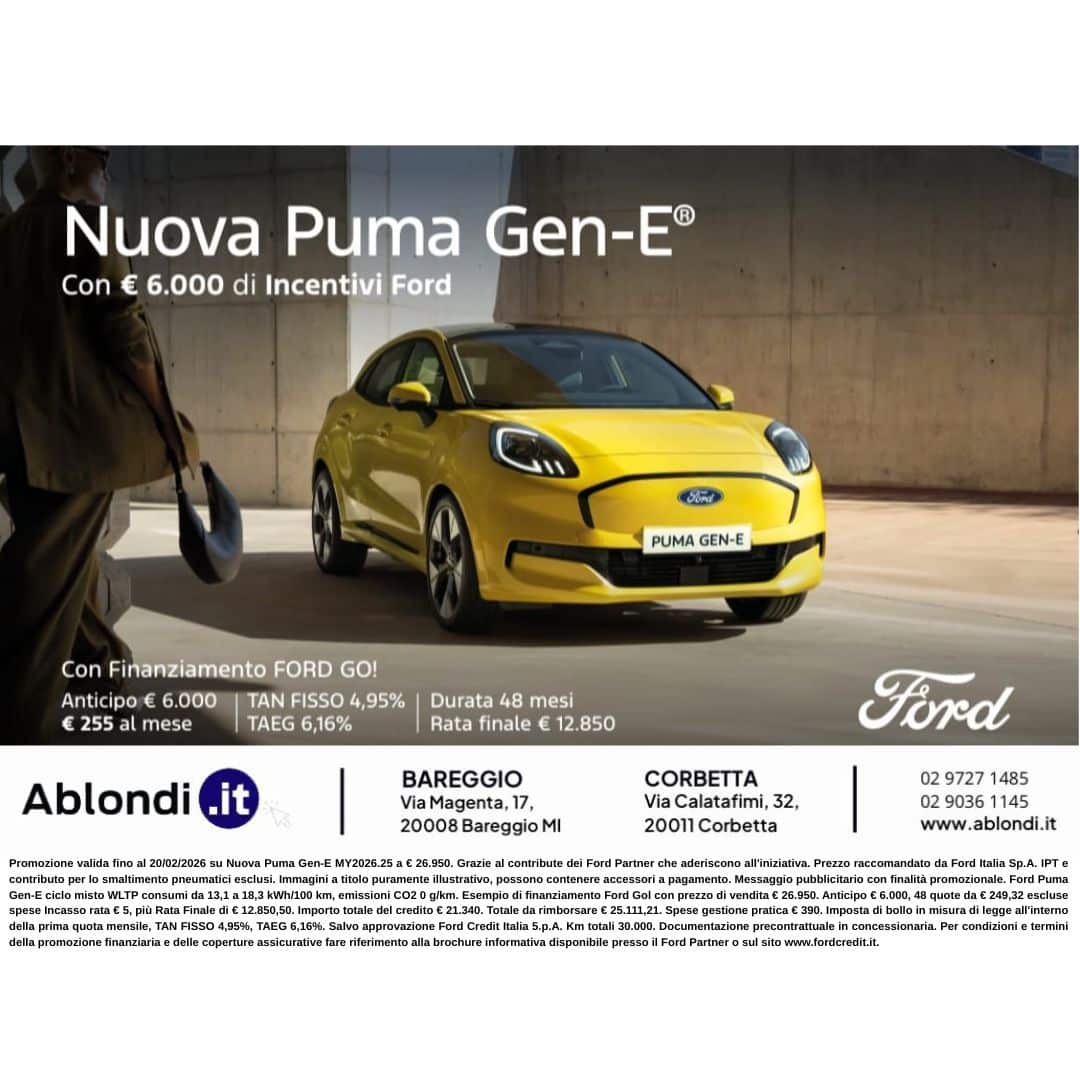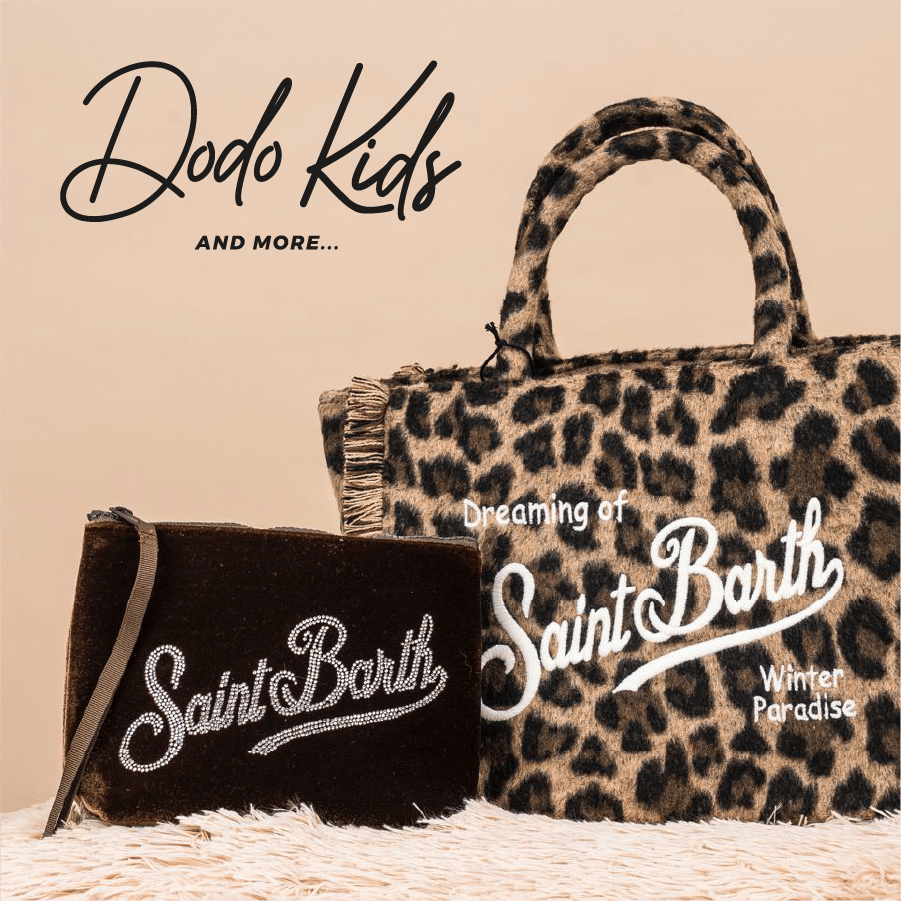La fortuna che, come si sa, è cieca e distribuisce i suoi doni a casaccio, e quel lontano giorno del 1765 salì in carrozza a Lainate, assieme al marchese Litta e al pittore Giuseppe Levati, e con loro raggiunse il monastero cistercense di Parabiago, dove il gentiluomo si stava recando per far visita ad un parente.
Usciti dal convento i due vollero visitare la parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, dopodiché continuarono il loro giro passeggiando nel centro del paese sino a giungere all’inizio di via Santini. Proprio lì aveva la sua bottega di falegname Giuseppe Maggiolini, che davanti al suo laboratorio aveva messo ad asciugare al sole alcuni mobili intarsiati. Sarà stata la finezza dell’intaglio, saranno state le bellissime sfumature di colore delle tarsie o il disegno o la linea, fatto sta che il Levati capì subito di essere di fronte a lavori di eccezionale qualità, tanto che, fattolo notare al marchese, decise di entrare per conoscere l’autore di tali pregevoli pezzi e, per essere sicuro di non essersi sbagliato, commissionò all’artigiano un comò di cui avrebbe fornito il disegno.
Quella fortuita passeggiata cambiò il destino di Giuseppe Maggiolini che, da falegname di umili origini, divenne ben presto uno dei più famosi maestri dell’intarsio, annoverando tra i suoi clienti famiglie quali i Melzi d’Eril, i Borromeo, i Belgioioso, i Pallavicini, i Visconti di Modrone (solo per citarne alcuni) e, nientemeno che l’arciduca Ferdinando, figlio dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria; ma vediamo di frugare nel suo privato, al fine di poter disegnare un ritratto del grande artista.
Figlio di Caterina Cavalleri e di Gilardo Maggiolini, Giuseppe venne al mondo il 13 novembre del 1738. Suo padre, originario del lago di Como, si era trasferito presso il convento dei monaci cistercensi di Parabiago quando questi l’avevano assunto come massaro e guardaboschi alloggiando tutta la famiglia in una casa addossata alla chiesa della Madonna di Dio il Sa; il piccolo Giuseppe crebbe così all’ombra del convento ricevendo una severa educazione cristiana e lavorando la terra, ma ben presto scoperse che la sua vera passione erano i lavori di falegnameria e, mentre il ragazzo apprendeva il mestiere dal falegname del convento, don Antonio Maria Caldiroli, professore di letteratura del collegio Cavalleri si prese a cuore le sorti di Giuseppe che, nel frattempo, era rimasto orfano di entrambi i genitori, tanto che decise di impartirgli lezioni di disegno architettonico e di ornato, che gli sarebbero state utili per la futura professione.
La mancanza di una famiglia, la solitudine ed anche il bisogno d’affetto, furono probabilmente i motivi che lo spinsero, seppur giovanissimo, a chiedere la mano di Antonia Vignati, una governante che si occupava della biancheria del convento. I due si sposarono il 26 gennaio 1757: lui aveva diciannove anni, e lei trenta. Il pranzo di nozze consistette in una polenta conciata con latte e formaggio, mangiata dalla sposa con la forchetta che si era portata in dote, e dal Maggiolini col compasso, dal momento che non possedeva forchette. Ma questo inizio sottotono non demoralizzò il giovane falegname che, l’anno seguente, affittò proprio quella casetta in via Santini, dove sette anni più tardi la fortuna l’avrebbe baciato tramite le labbra del pittore Levati.
Quest’ultimo in quel periodo stava lavorando, insieme ad un’èquipe di artisti, alla ristrutturazione del ninfeo della villa Litta di Lainate, luogo dove il Maggiolini consegnò il comò e fu lì che, strabiliato dalla bellezza del mobile, il noto pittore iniziò a presentargli i suoi famosi colleghi, conoscenze che gli aprirono molte porte, e se a queste aggiungiamo la protezione del marchese Giambattista Morigia, deputato alla corte dell’imperatrice Maria Teresa, il gioco è fatto.
A partire dal 1765 Maggiolini cominciò a lavorare per la nobiltà e l’alta borghesia e nel 1772, in occasione dei lavori di restauro del Palazzo Reale di Milano affidati al celebre architetto Piermarini, fu addirittura incaricato della realizzazione di tutti i pavimenti in legno del palazzo e successivamente pure di quelli della Villa reale di Monza: e tanta fu la soddisfazione dell’arciduca Ferdinando, che gli conferì il brevetto di intarsiatore della Corte Arciducale. Le commissioni crebbero così tanto che il nostro Giuseppe aprì un laboratorio anche a Milano, dove lavoravano ben trenta operai, tra i quali anche suo figlio Francesco. Dalle sue botteghe uscivano letti, canterani, scrigni, specchiere, librerie, comodini, credenze, tavolini, secrétaires, tutti pezzi unici i cui disegni erano fatti da artisti quali il Levati, l’Albertolli, il Cantalupi e l’Appiani. I secrétaires erano addirittura personalizzati, tanto che solo il proprietario conosceva il marchingegno per aprirli. Maggiolini inventò anche il tavolino da letto, costruito a causa di una malattia che costrinse, per l’appunto a letto, l’arciduchessa Maria Beatrice d’Este, e tanto fu apprezzato per la sua comodità, che le ordinazioni cominciarono a fioccare.
Ma perché piacevano così tanto i suoi mobili? Possiamo cominciare col dire che egli usava moltissime varietà di legni, si dice addirittura ottantasei, un campionario davvero eccezionale costituito da diverse qualità di ebano, acero, palissandro, ciliegio, bosso, tiglio, rovere, robinia, pioppo, pino, noce, mogano, pero, platano. Di questi legni usati sempre con la loro tinta naturale in un mirabile gioco di chiari e di scuri, solo i verdi, gli azzurri e il rosa pallido erano colorati artificialmente in quanto tali tinte non esistono in natura. E così, l’accostamento delle tarsie dava vita a mazzi di fiori, uccelli, insetti, figure cinesi, motivi persiani, turcheschi, soggetti esotici, quest’ultimi molto di moda all’epoca. Ma la sua bravura non consisteva solo nel saper accostare con maestria tarsie dalle sfumature ricercate, ma anche e soprattutto, nel creare con quei suoi tasselli, ognuno di dimensione diversa, un mosaico ligneo nel quale non c’erano né mastice, né filetti riempitivi, né impiallacciature, ma solo accostamenti perfetti. Erano i suoi, mobili neoclassici dalle linee pure e severe antitetici ai fronzoli e alle sinuosità inquiete e ridondanti del barocco e del rococò: erano mobili dalle proporzioni equilibrate.
Il suo successo proseguì ininterrottamente per trent’anni, sino al 1796, quando con l’arrivo dei Francesi l’arciduca fu costretto ad abbandonare Milano. L’armata francese, insieme alle idee rivoluzionarie, portò la sua moda, i suoi mobili laccati, dorati, impiallacciati, ricchi di appliques di bronzo dorato, che ben presto invasero il nostro mercato, facendo perdere il gusto del lavoro italiano. Quel cambiamento di stile fece progressivamente calare le commissioni fatte al Maggiolini che, a malincuore, si vide costretto a licenziare un po’ della sua maestranza. Ma la fortuna non lo voleva proprio abbandonare; infatti, nel 1805, in occasione dell’incoronazione di Napoleone, fu chiamato ad eseguire in solo otto giorni una scrivania da mettersi nella sala imperiale. La sua bravura e la sua fama non passarono inosservate agli occhi dell’imperatore il quale, affidandogli nuovi incarichi gli aprì nuove porte sino alla sua dipartita, avvenuta nel novembre del 1814. La direzione passò allora al figlio Francesco, che ne continuò la tradizione per altri vent’anni, quando anch’egli passò a miglior vita. Oggi i mobili superstiti sono disseminati nelle più disparate collezioni museali e private italiane e straniere; e se qualcuno volesse vederne i disegni, la Civica raccolta Bertarelli che ha sede al Castello Sforzesco di Milano, ne possiede addirittura millesettecento.
I miei romanzi storici li trovate nelle librerie, nei bookshop on line e nelle biblioteche.
Luciana Benotto