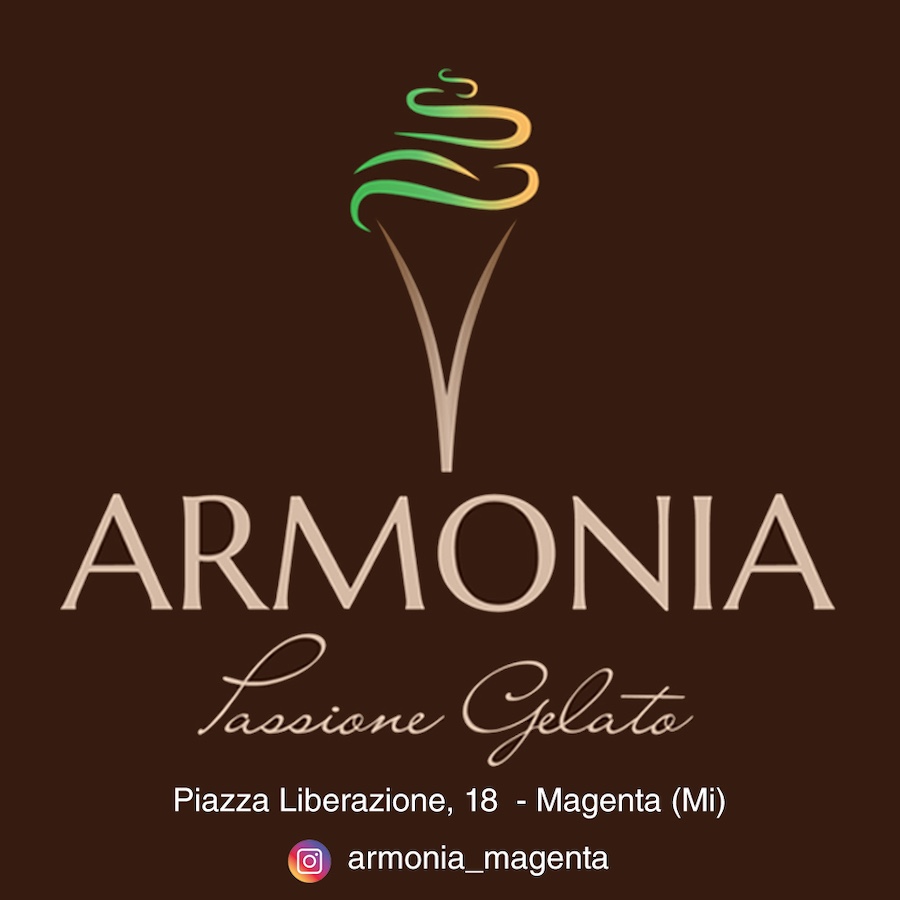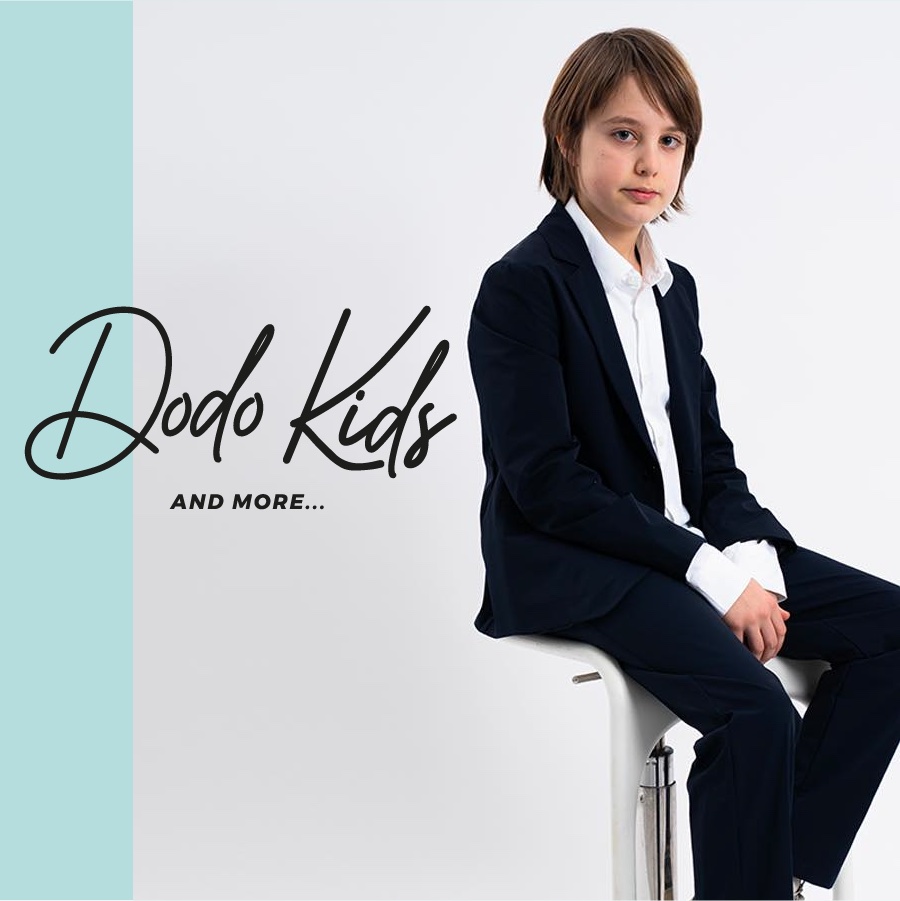MILANO – La morte di Giulia Maria Crespi non deve indurci a dimenticare la duplice natura della sua forte influenza sulla società italiana: se dalla metà degli anni Settanta la sua vita fu legata alla creazione del Fondo per l’Ambiente Italiano e alla creazione delle cascine Orsine di Bereguardo, prima c’è stata quella di azionista del Corriere della Sera, che cederà nel mezzo degli anni di piombo dopo aver causato, con l’incauto approdo del quotidiano principe della borghesia lombarda ed intraprendente, sulle rive che vezzeggiavano l’estremismo di sinistra.
Ed è in ragione di quella temeraria svolta che Indro Montanelli abbandona via Solferino e fonda, nel 1974, il Giornale Nuovo. Con lui altri campioni di un giornalismo autenticamente liberale che rifiutarono di piegarsi ‘all’eskimo in redazione’, come Enzo Bettiza.
Quel Giornale che per anni verrà finanziato, e letteralmente salvato, dai capitali di un giovane editore che rispondeva al nome di Silvio Berlusconi.
E’ lo stesso Montanelli, nei giorni successivi all’attentato e alla gambizzazione subita dalle Brigate Rosse di fronte ai cancelli di via Manin nel 1977, a ricordare come in alcuni salotti milanesi si arrivò addirittura a brindare al suo ferimento.
Erano quelli di Inge Feltrinelli e Gae Aulenti. Erano i salotti colmi di quelle persone appartenenti all’alta borghesia che coccolavano i leader dell’estremismo rosso. Ambienti a cui Giulia Maria Crespi, va detto, fu tutt’altro che estranea. Ambienti culturali cui praticamente nessuno ha mai chiesto di rendere conto, come ci ricorda in modo esemplare Stenio Solinas in un pezzo del 2018 sulla morte di Inge Feltrinelli. Che non ha certamente perso d’attualità, neppure d’una virgola.
Rileggiamolo, ne vale (davvero) la pena. Perché Milano, e l’Italia, sono stati (anche) questo.
F.P.

Poiché siamo un Paese senza più memoria, conviene partire da qui, dal ricordo di ciò che è stato, per dissipare la fumeria d’oppio di un presente edulcorato. E quindi occorre riandare a quel giugno del 1977 in cui, immobilizzato in un letto d’ospedale dopo che le Brigate Rosse gli hanno sparato, Indro Montanelli scrive sul suo diario: «Dal Giornale mi mandano tre sacchi di telegrammi: ne hanno contati quindicimila.
Ma la notizia che in fondo mi fa più piacere è che in due salotti milanesi – quello di Inge Feltrinelli e quello di Gae Aulenti – si è brindato all’attentato contro di me e deprecato solo che me la sia cavata. Ciò dimostra che, anche se non sempre scelgo bene i miei amici, scelgo benissimo i miei nemici».
All’epoca Inge Feltrinelli, morta a 87 anni, ne aveva quasi cinquanta, non era insomma una bambina ingenua né una adolescente sventata. Sei anni prima, quello che era stato suo marito, Giangiacomo Feltrinelli, era saltato in aria mentre stava sabotando un traliccio dell’Enel a Segrate, e insomma i guasti del fanatismo ideologico Inge li aveva vissuti da vicino. Nel suo libro Il terrorismo italiano, Giorgio Bocca osservò allora che rispetto alla frenesia rivoluzionaria che colse Feltrinelli su finire degli anni Sessanta, Inge aveva «troppo buon senso e troppo spessore umano per essere la compagna adatta» di una simile avventura. Giudiziosamente, lasciò infatti il marito alla sua nuova moglie, Sibilla Melega, e se ne restò alla guida della casa editrice che del marito aveva il nome e che negli anni immediatamente a seguire continuò a sfornare libri e libretti sulle rivoluzioni in ogni continente che poi, quando il decennio di piombo finì e il clima generale mutò, la lasciarono sull’orlo del disastro economico. Si salvò dal fallimento perché, naturalmente, era una donna intelligente, dotata di fiuto editoriale e delle giuste conoscenze internazionali, di un catalogo che, alleggerito di tutto il ciarpame terzomondista e no, aveva un suo valore. Si salvò anche perché, come certa parte della borghesia progressista italiana che si era vestita alla comunista in quanto era la tenuta più alla moda, il più glamour dei prét-à porter, al cambio imperioso della nuova stagione ideologico-politica lo aveva riposto nell’armadio, un vintage magari da rindossare, ma sempre con parsimonia e all’insegna romantica e svagata dei «formidabili quegli anni», niente di più, niente sangue sui tessuti da ricordare, che orrore, così poco chic… Ora c’era il business delle librerie e dei punti vendita da cavalcare capitalisticamente. Nelle storie familiari di entrambi, gli elementi in comune sono molti e senza fare del freudismo banale, aiutano a spiegare l’ubriacatura ideologica che in seguito li afferrerà. Erano i rampolli di padri da cui non erano mai stati amati (quello di Inge la respingerà quando lei andrà a trovarlo negli Stati Uniti), avevano un irrisolto complesso di classe e di colpa con quella borghesia da cui provenivano. Nel caso di Feltrinelli, questo complesso raggiungeva il parossismo dovuto alla schiacciante fortuna paterna, prosperata per di più sotto il regime fascista, con, anche qui per soprammercato, un patrigno che era il figlio di quel Luigi Barzini del fascismo supporter e divulgatore. Per Inge c’era il buco nero della Germania nazista e di quell’ufficiale della Wehrmacht in sostituzione paterna, di cui parlerà soltanto in tardissima età, e il decennio dei Cinquanta fatto di cocktail, safari, ricevimenti, buona società.
Ora, sempre per tornare alla memoria, dalla seconda metà degli anni Sessanta, ciò che si andò diffondendo in Italia fu proprio il gusto mimetico del travestimento. Fu una strana epidemia che, come osservò sul tamburo Enzo Bettiza, «non risparmiava le famiglie più in vista, i cui epigoni, sdoppiati, pur continuando a occuparsi di affari e di denaro, sfoderavano in quegli anni un odio patologico contro le proprie origini borghesi». Nel caso di Inge e Giangi (era questo il diminutivo del secondo) c’era l’aggravante dell’editoria, ovvero un rapporto diretto, scriveva ancora Bettiza, «con la fabbrica delle idee e delle opinioni, che dava al loro sinistrismo un lustro intellettuale e uno chic mondano che ne allargava il raggio d’influenza nella società».
Si dirà: sono cose del passato e Inge Schönthal Feltrinelli è stata in seguito anche molto altro, l’ultima «regina dell’editoria internazionale», l’amica di Nadine Gordimer, Doris Lessing e García Márquez, il «ministro degli esteri» del libro, una donna piena di vita, un’incantatrice… Certo, tutto vero, ma questo lo leggerete domani su tutti gli altri giornali. L’altra faccia della medaglia la trovate solo qui. La verità, si sa, è rivoluzionaria.
Stenio Solinas (Il Giornale, 2018)