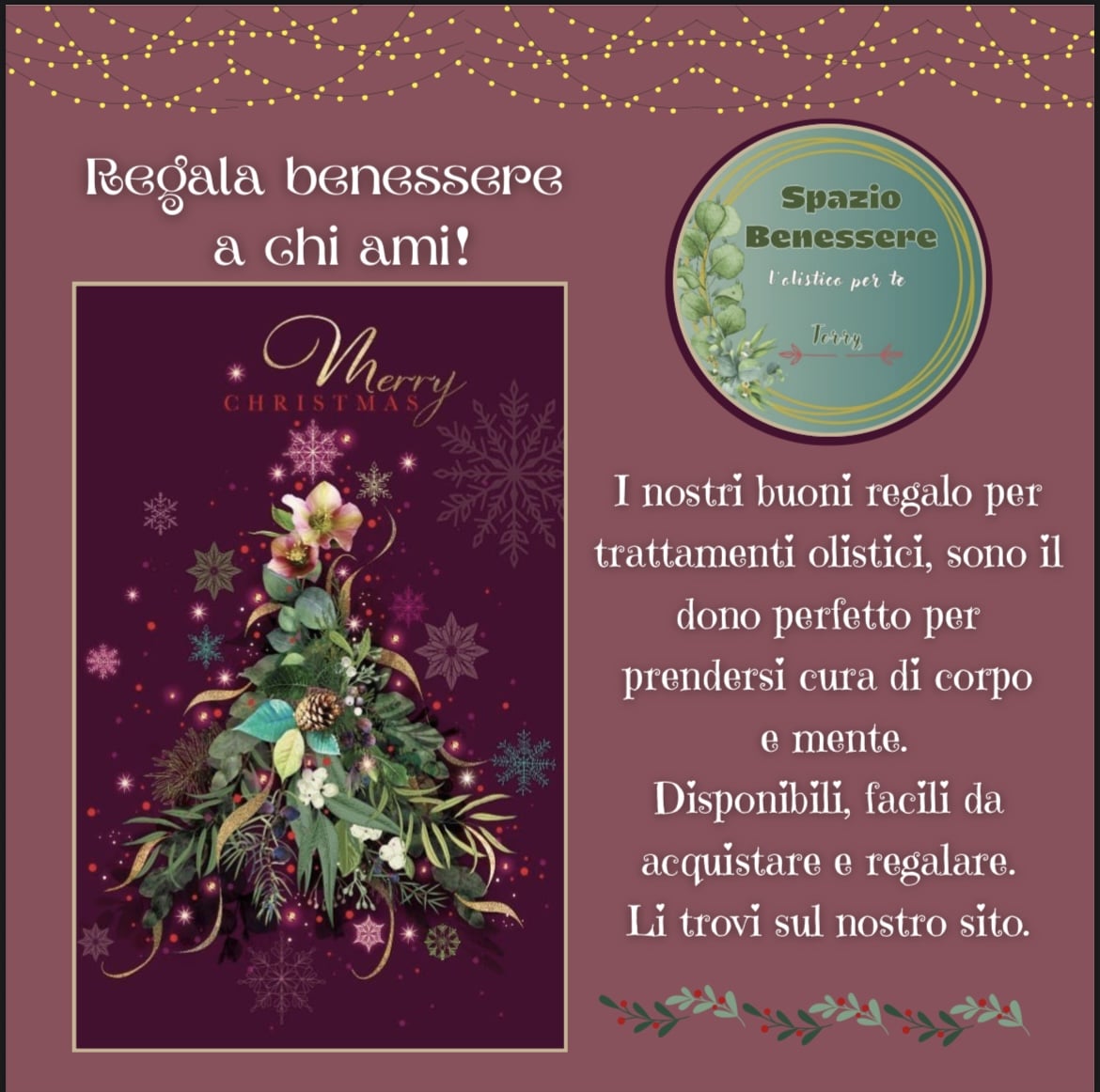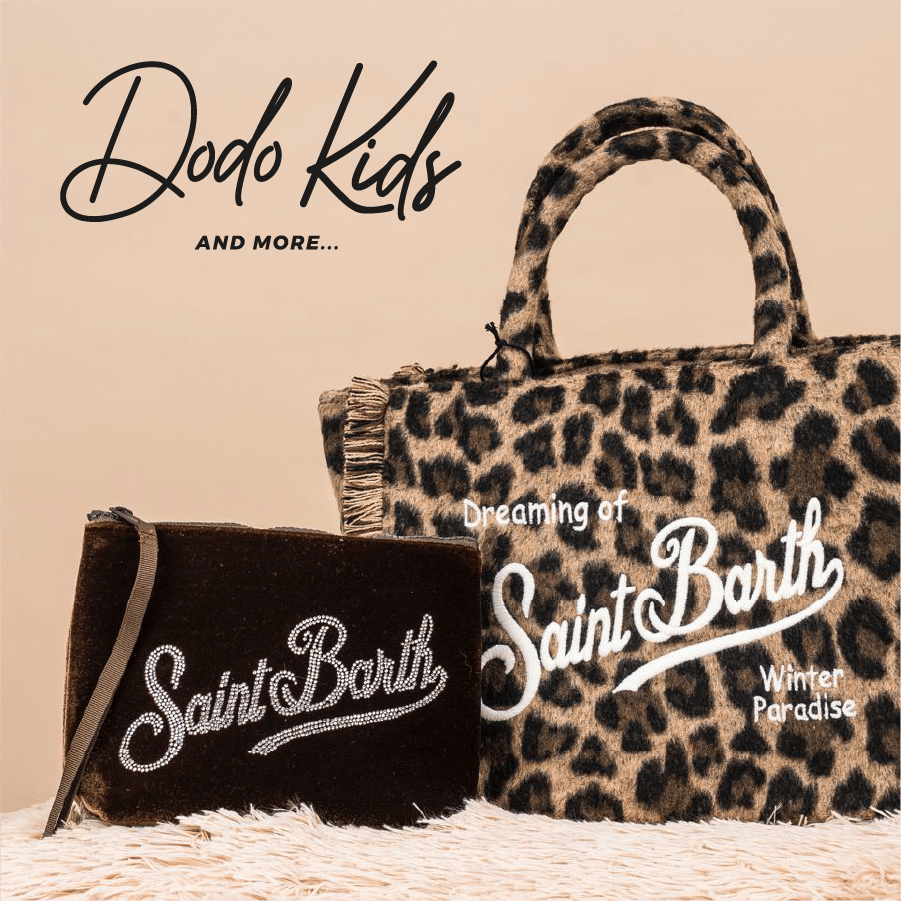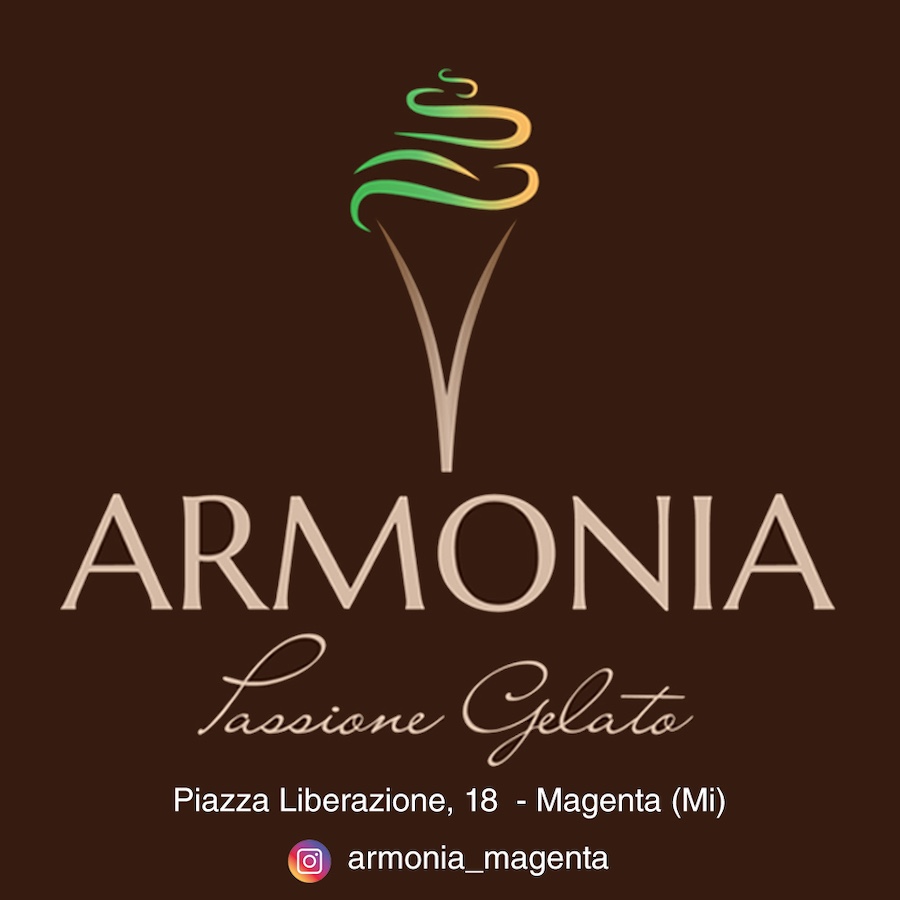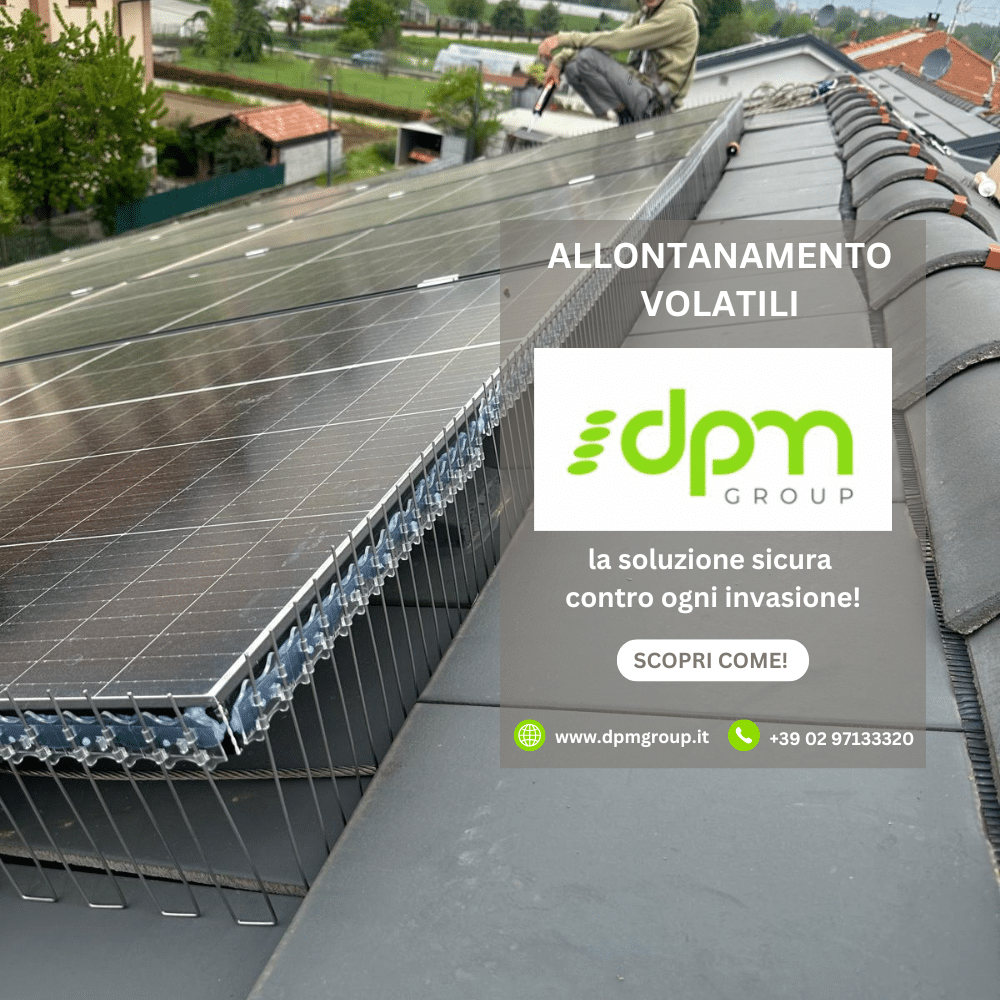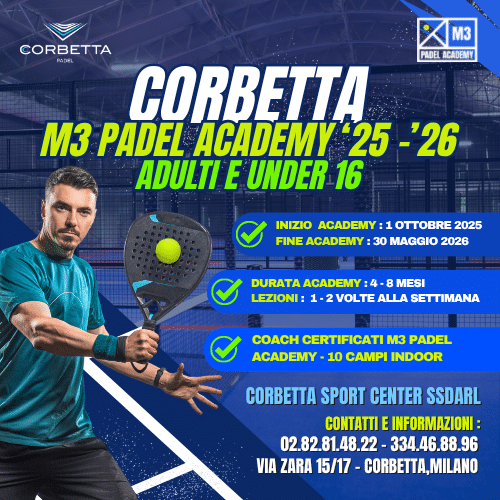“Ammirare le sottane non significa zompar loro addosso”
“Non posso allenare un gruppo di deficienti perennemente con la musica nelle orecchie”
Strani scherzi fa il destino. Ieri sera, alla guida delle rispettive compagini calcistiche, due allenatori dalla riconosciuta competenza hanno avuto l’onore di fronteggiarsi. Da una parte Massimiliano Allegri, sponda Milan, dall’altra Gian Piero Gasperini, sponda Roma. Ad accomunarli, lo si è capito, c’era un’analoga commozione iniziale, un aspetto fondamentale della loro crescita umana e professionale.
Per entrambi, infatti, il maestro può essere considerato Giovanni Galeone, che soltanto qualche ora prima era venuto a mancare all’età di ottantaquattro anni. Un secondo padre per Allegri, che da giocatore maturò calcisticamente proprio nel Pescara dei primi anni Novanta. Quelli di Galeone e della fantasia issata al potere, fatta di interpreti speciali come Bivi, Sliskovic, Pagano e, appunto, lo stesso Massimiliano. Uno che godeva della stima incondizionata dell’allenatore.
Un granitico punto di riferimento, invece, per Gasperini che, seppur non ne abbia mai incrociato la parabola, lo considerava alla stregua di un erede, perché più d’ogni altro depositario della stessa futuristica filosofia calcistica. “Uno dei pochi – disse Galeone in un’intervista – che ha portato avanti le idee che anche noi cercavamo di sviluppare anni fa”. Fratelli di calcio, insomma.
Bravo il destino. Forse, modo migliore per ricordare a chi c’era e, al contempo, per insegnare ai più giovani che negli ultimi anni del calcio nella sua forma ancestrale, quello non inquinato da petrodollari e televisioni, personaggi come il Profeta – come era soprannominato – hanno contribuito a scrivere l’era d’oro del calcio italiano. Perché non di soli almanacchi vive lo sport, con buona pace del bonipertismo e degli araldi della vittoria a ogni costo.
“Non serve vincere se non giochi bene”, era solito ripetere Galeone, mentre i colleghi sparagnini dell’epoca a.S. (avanti Sacchi) strabuzzavano gli occhi, come accade quando ci si approccia a qualcuno il cui sguardo è in grado di spingerlo decisamente più lontano degli altri. Perché, aggiungeva, “vince il più bravo, non il più forte” e ciò spiega molto della personalità sui generis dell’allenatore napoletano.
Con le tre punte come regola imprescindibile e la marcatura rigorosamente a zona, pratica che lui stesso definiva “una rivoluzione culturale più che tattica”, Galeone diede vita a una concezione filosofica della zona nella patria che glorifica il catenaccio. Detestava che i giocatori venissero ridotti a soldatini incapaci di leggere le situazioni di gioco e di adattare la propria postura alla mutata contingenza. Zona, infatti, era per lui prima di tutto la comprensione dello spazio, il sapere sempre dove stare.
Più in generale, fu l’artefice della distinzione epocale – forse nemmeno chiara a tutti anche a distanza di quarant’anni – tra squadre che combattono e squadre che pensano. Come le sue, creature di un calcio intelligente e visionario. Non ha vinto nulla, ha insegnato tantissimo.
Galeone, calciatore modesto in gioventù, intraprese la carriera da allenatore già nel 1975 sulla panchina del Pordenone Calcio, in serie D. La svolta arrivò, ovviamente, a Pescara, dove nella stagione ’86-’87 ottenne la prima storica promozione nella massima serie degli abruzzesi. Se oggi Pescara, dove prestò servizio per sei anni, è in lutto e piange il suo più celebre condottiero, è anche per questo.
Allenerà, tra le altre, anche l’Udinese. Il decimo posto raggiunto dal team friulano nella stagione ’94-’95 sarà il suo migliore piazzamento in Serie A, ma al di là dei numeri, quella squadra sopravvive nell’immaginario collettivo come una delle più spettacolari della sua epoca. Artista chiama artista. Il migliore di tutti, Diego Armando Maradona, ebbe modo di dirgli di persona, dopo averlo incontrato in un ristorante: “Lei deve venire qui e allenare il Napoli”. Non fu mai un sergente. Celebre, a riguardo, era ciò che il rugby chiama “terzo tempo” e che Galeone era solito organizzare alla fine di un allenamento: pizza e champagne per tutti. Creatività. Perché, ripeteva, “è così che si costruisce un gruppo”, e il gruppo lo avrebbe seguito fino all’inferno.
Amante del latino e della letteratura – Calvino, Sartre e Pasolini i suoi modelli di riferimento – ebbe modo di dire, prendendo in prestito una chiosa pasoliniana, che: “il calcio è come la vita, un linguaggio, un codice. Pasolini aveva ragione: in campo si parla una lingua fatta di libertà e intuizione”.
L’uomo al centro, con lo sport che assurge a strepitoso paradigma della vita. Vita che ha edificato partendo da Servola, quartiere operaio e multiculturale di Trieste, che per sua stessa ammissione gli ha dettato uno dei principi poi divenuti cardine della sua esistenza: “Il quartiere mi ha insegnato che nel calcio, come nella vita, esistono tante visioni possibili”.
Durante le riunioni tecniche, era inoltre solito citare scrittori o esporre concetti filosofici, tra il comprensibile stupore dei suoi giocatori. Zico, per esempio, raccontò che Galeone “aveva un modo di spiegare la tattica che sembrava un professore, non un allenatore”. Il perché è presto detto: considerava il calcio una forma d’arte applicata, non soltanto uno sport. Qualcosa per la quale non lo si ringrazierà mai abbastanza.
Fai buon viaggio, Profeta. Insegna agli angeli che la bellezza, nel calcio come nella vita di tutti i giorni, non è mai qualcosa di barattabile