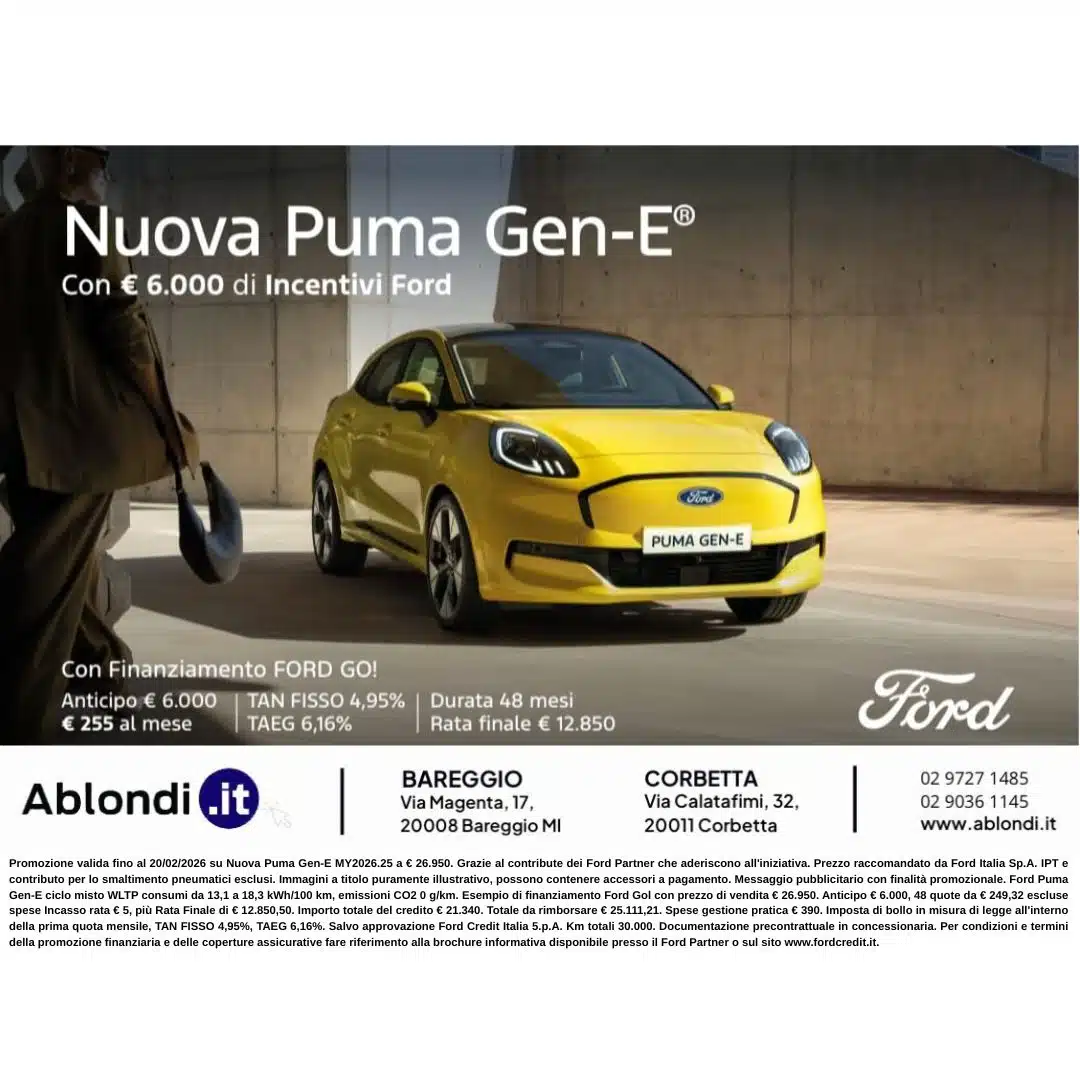RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – “Egregio Direttore, si dice che ognuno abbia diritto ai suoi cinque minuti di celebrità. Ma oggi non bastano più. Non sono un diritto costituzionale, certo, ma sembrano essere diventati una terapia collettiva: la ricerca compulsiva della firma e della forma del successo, anche solo condominiale.
Viviamo nell’epoca dell’“io c’ero”, “io conosco”, “ho un amico”, possibilmente immortalati su Facebook. Un cappello vistoso, una giacca con bottoni d’oro, un saluto di fine anno: tutto va bene, purché la posa sia giusta. I filtri fanno male, ma la fedeltà al proprio idolo social è intoccabile.
Le feste, poi, amplificano le differenze: c’è chi vive a cinque stelle e chi nella stalla — magari pure fredda. Eppure basta un gruppo social per smuovere un intero appartamento provinciale.
Io, per esempio, ho i miei “trenta minuti piace”: sempre gli stessi, per amicizia, per quieto vivere o per pietà. Perché i social sono come la vita: circoli chiusi di affetto affettato, spesso condito di veleno. Il “metti mi piace” è insieme obbligo e divieto. I capibastone di un tempo sono diventati capi‑tastiera: moderati nell’apparenza, efferati nella reazione, seguiti da fedeli pronti a scattare.
“Non mi hai messo mi piace”: e per non ammettere che mancava la connessione, si preferisce la prigione del giudizio.
Arriva il fine anno, poi la Befana, poi un altro evento da caricare sulla piattaforma. Magari ripescando vecchie foto, perché siamo sempre noi “il meglio”. Prima copiavamo i Vanzina e le loro vacanze di Natale; oggi viviamo in un carnevale permanente di pose, filtri e trucchi da Joker.
Ripostiamo, copiamo, imitiamo. Ma ci sentiamo protagonisti. Dai cinque minuti di celebrità siamo passati al “tutti famosi”. Famosi perché abbiamo i “mi piace”, perché abbiamo amici importanti o amanti sotto il computer. Le dipendenze aumentano: oltre alle solite, c’è quella dai social e dalla fama. Una nuova disciplina: la famalogia”.