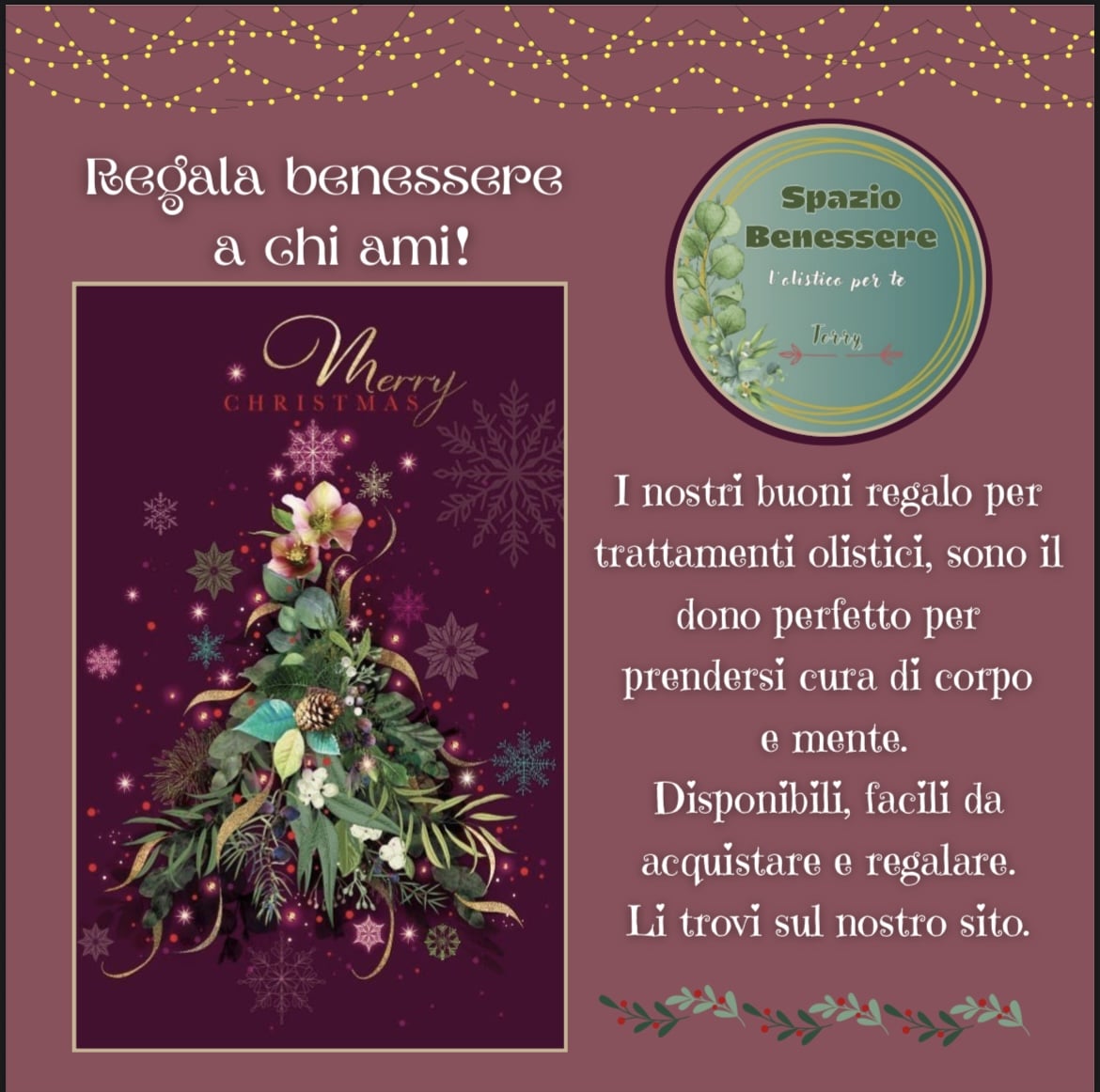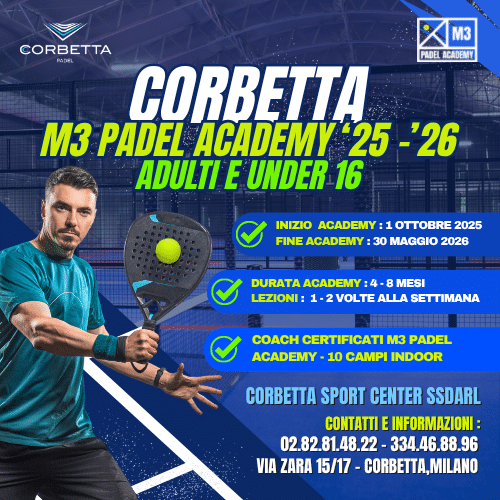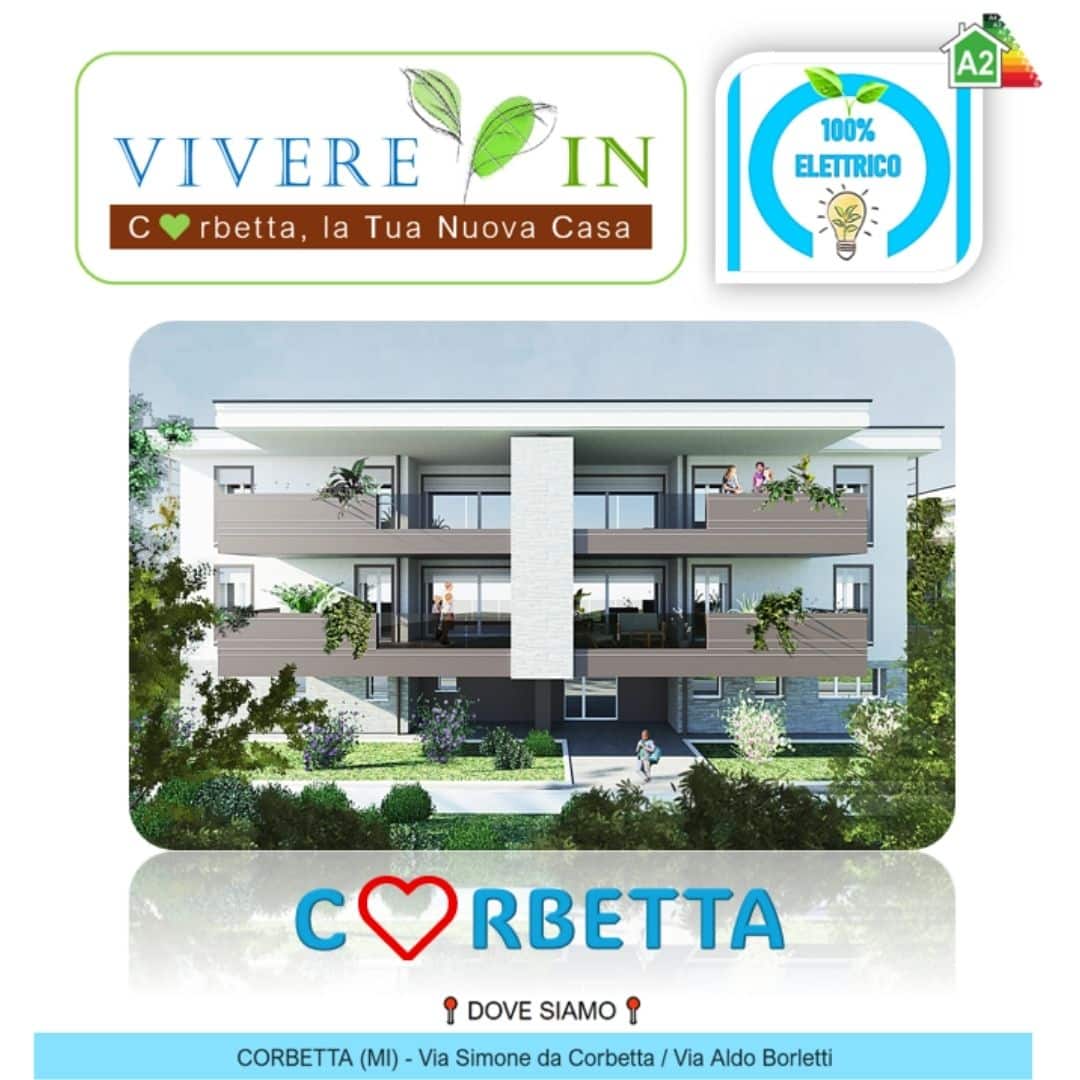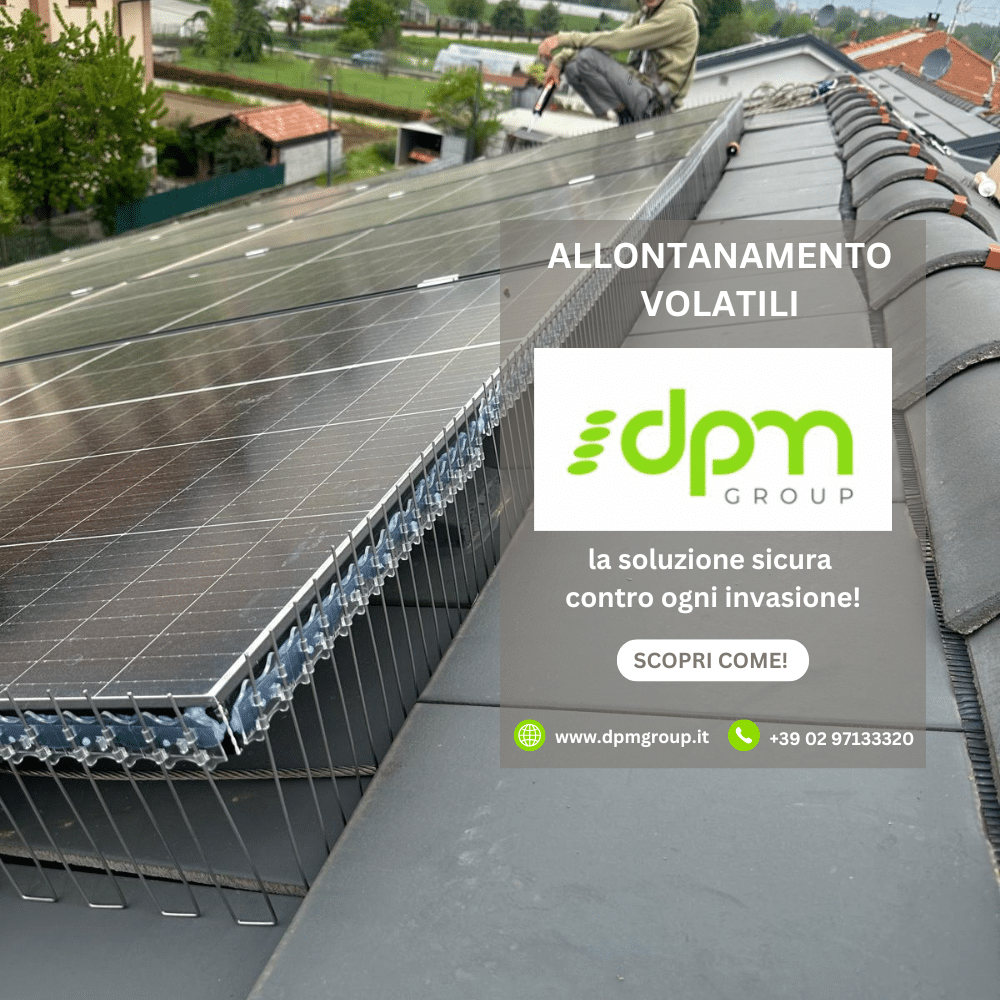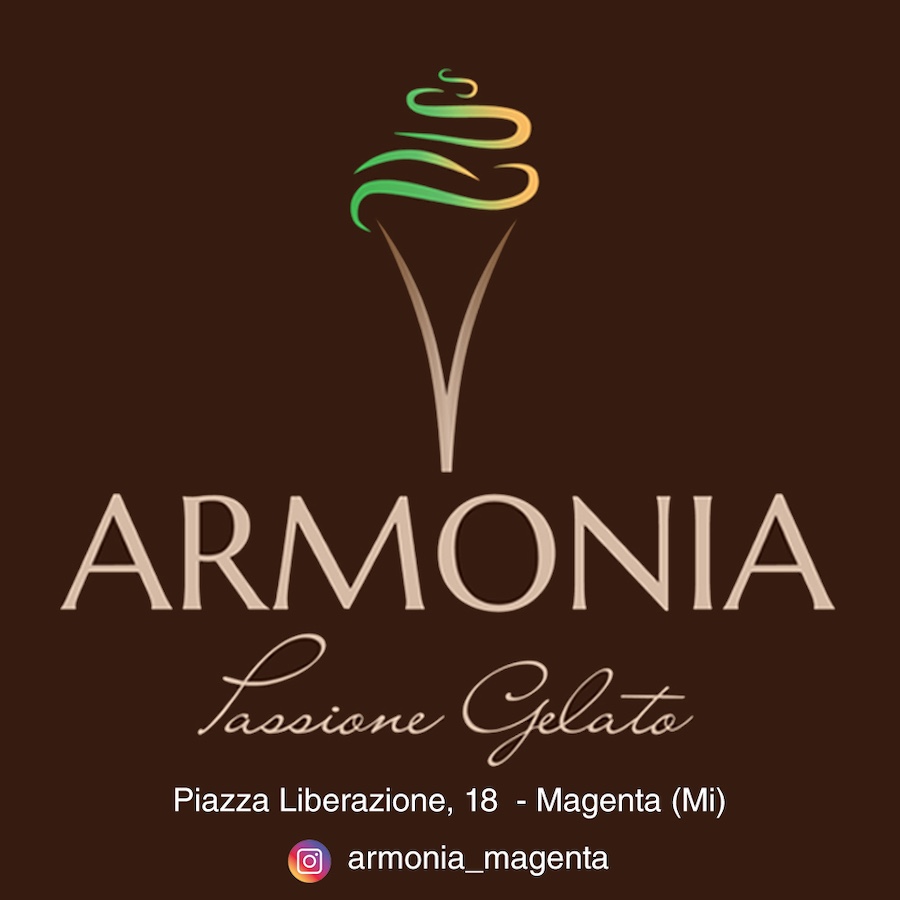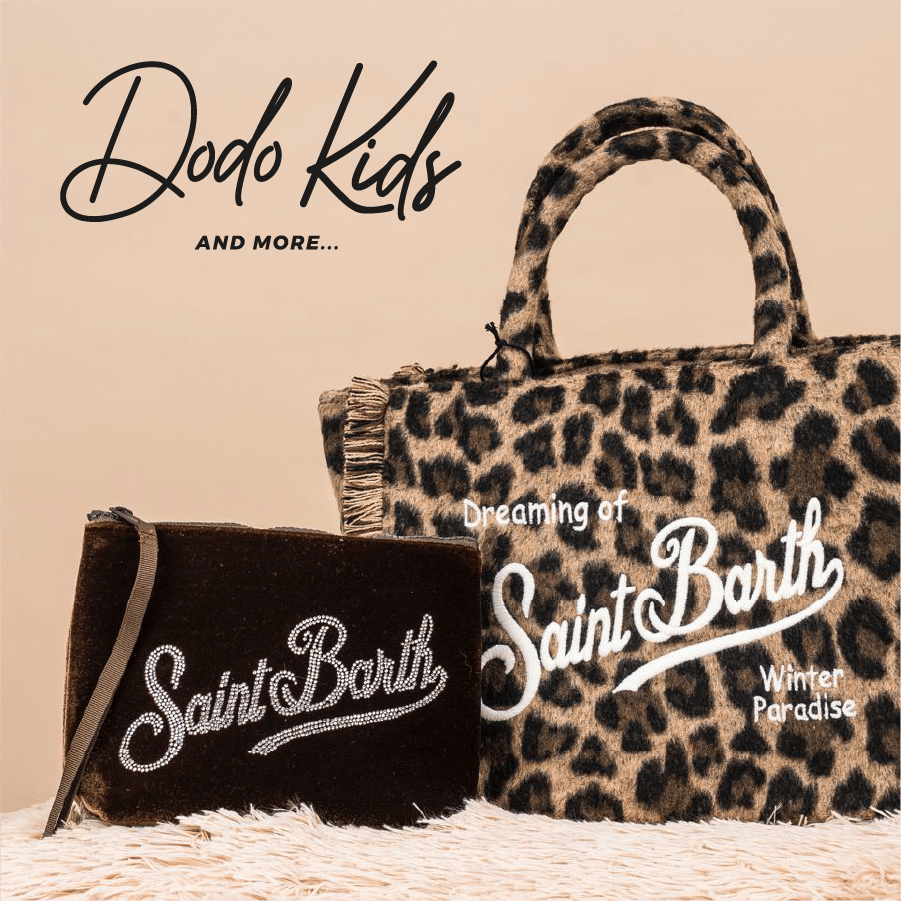Il rugby è l’insieme di tantissime cose. Intanto, per Woody Allen è lo sport delle bestie che viene giocato da uomini. Mica male. Peraltro, esattamente il contrario dell’altro sport con la palla da calciare, il soccer, che, sempre per il grande regista, è disciplina da uomini interpretata da bestie. Concetto, questo dell’umanità, esemplificato alla perfezione anche da un cantastorie di razza come Davide Van De Sfroos che, proprio al gioco della palla ovale impazzita, ha dedicato una canzone indimenticabile e sportivamente struggente dal titolo ‘Grazie ragazzi’, nella quale – testualmente – ci ricorda che “… soltanto chi ha grande rispetto, può incontrare l’avversario di petto, lo sappiamo che i modi son duri, ma (il rugby, ndr) è pur sempre un incontro di cuori”.
Cuore, appunto. Perché, è vero, le regole talvolta cervellotiche non sono tipicamente le più facili da digerire per gli spettatori meno informati, tuttavia c’è un aspetto caratterizzante che non può passare inosservato, nemmeno a chi davanti alla tivù ci è capitato per caso. Paradigma che diventa spirito, spirito che diventa auspicio. Nel rugby, infatti, la squadra che vanta il possesso della palla corre in avanti, con i suoi portatori a fare da ariete, il più veloce possibile ma, la stessa palla, deve sempre essere passata al compagno che sta immediatamente dietro. A pensarci bene, che mondo meraviglioso sarebbe quello capace di applicare alle proprie dinamiche quotidiane lo stesso principio inclusivo, quindi senza che nessuno sia relegato a rimanere indietro? Le tipiche ondate del rugby, la marea, l’orda arrembante di quindici uomini che cercano di varcare la linea di meta, quale azzeccata metafora del vivere comune, se solo quest’ultimo significasse remare tutti dalla stessa parte, come fanno sul prato gli uomini di campo intrisi di fango e sudore.
In un match può succedere che, a seguito di un’irregolarità, l’arbitro ordini la ripresa del gioco con quella che gli inglesi chiamano ‘scrum’, la mischia ordinata. Otto giocatori per ciascuna squadra che si posizionano a formare due schieramenti contrapposti, spalla a spalla, al fine di impossessarsi della palla. Tre linee, come quelle posizionare a presidio dei confini in tempo di guerra. I piloni ai lati del tallonatore formano la prima, gente tozza con quadricipiti grossi come ciminiere e baricentro basso, roccaforti inamovibili. Due seconde linee, invece, si posizionano a quinconce rispetto a chi gli sta davanti e, infine, tre terze linee fanno lo stesso alle loro spalle. Uomini alti come grattacieli, questi ultimi, un po’ puntelli e un po’ stantuffi. Uno sforzo bestiale. Tra gli otto è incastro perfetto, un Tetris di corpi. Moderna testuggine romana che è archetipo di coordinamento collettivo; unisono che è la differenza scientifica tra l’avanzare e il soccombere. “Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni”, direbbe Carlo Marx, perché, ancora una volta, il gioco del rugby ben si presta ad essere metafora di una società che sarebbe decisamente migliore se tutti fossimo almeno un po’ rugbisti nell’animo, quindi pronti a sacrificarci per chi ci sta a fianco. Scrum, del resto, è darsi una mano per quanto se ne ha in corpo: nei bicipiti, nella testa, nel cuore. Dove solo i più ciechi scorgono la sola forza bruta.
Di similitudini che fanno, anzi dovrebbero fare, della vita un’infinita partita di rugby se ne potrebbero trovare ancora molte, con la giusta dose di fantasia. La touche, per esempio, esercizio complicatissimo che porta alla conquista del cielo, manco a dirlo, al culmine di uno sforzo collettivo: c’è chi solleva e chi è scelto per essere sollevato affinché recuperi la palla per il bene comune. L’immagine di questi ascensori umani ci rammenta che il contesto sociale sarebbe assai più equo se in alto ci si potesse andare per merito, non solo per classe di provenienza. Come quella volta in cui – e accadde davvero – che a impadronirsi dello spazio per primo nella storia del genere umano fu il figlio di un umile carpentiere e non il più ricco del pianeta Terra come invece succede oggi. La touche, o assalto al cielo, l’istantanea di una possibilità concessa a chiunque, senza distinzioni.
I tempi canonici di una partita di rugby sono ovviamente due, durano quaranta minuti, sono estenuanti perché effettivi. Non c’è melina che tenga, si soffrono tutti quanti, uno per uno. Poi, ad un certo punto, il cronometro si colora di rosso e ciò vuole semplicemente dire che manca l’ultima azione prima della doccia. E di quello che gli aficionados italiani chiamano ‘Terzo tempo’, e i francesi ‘Troisième mi-temps’, forse la tradizione più significativa e che antica lo è di sicuro, dacché le sue tracce si perdono già nell’Ottocento. Il fischio finale, allora, è spartiacque: prima rivali, duri e neanche poco, poi amici. La squadra ospitante organizza la festa, che nei campi di periferia è lo scoppiettio di una griglia, alla quale partecipano giocatori, familiari e tifosi. Insieme, senza più differenze. Pioggia di birra e socializzazione, un processo marginale nella società individualista che pare avere strappato il sopravvento; quella della supremazia del personale sul collettivo, con tutte le conseguenze del caso. Il rugby, a tutela di sé, dall’egocentrismo in tutte le sue forme se ne sta alla larga. Gli altri, bontà loro, un po’ meno.
Insomma, il rugby quale esperienza pedagogica. Perché c’è sempre da imparare qualcosa di nuovo dal groviglio solo apparentemente casuale di uomini che si immolano per lasciare in eredità al compagno la migliore situazione possibile, sempre a proposito di azzeccate metafore. Esperienza d’amore, anche, che noi fuori dal campo, se spesso fatichiamo a capire, finiamo sempre per invidiare. Pertanto, l’augurio per il nuovo anno alle porte è quello di essere tutti più rugbisti. Almeno un po’. Con un minimo di emulazione ci si regalerebbe un anno migliore di quello che l’ha preceduto: bello come una meta e intenso come l’abbraccio che ne fa immancabilmente seguito. Buon 2024 a tutti.