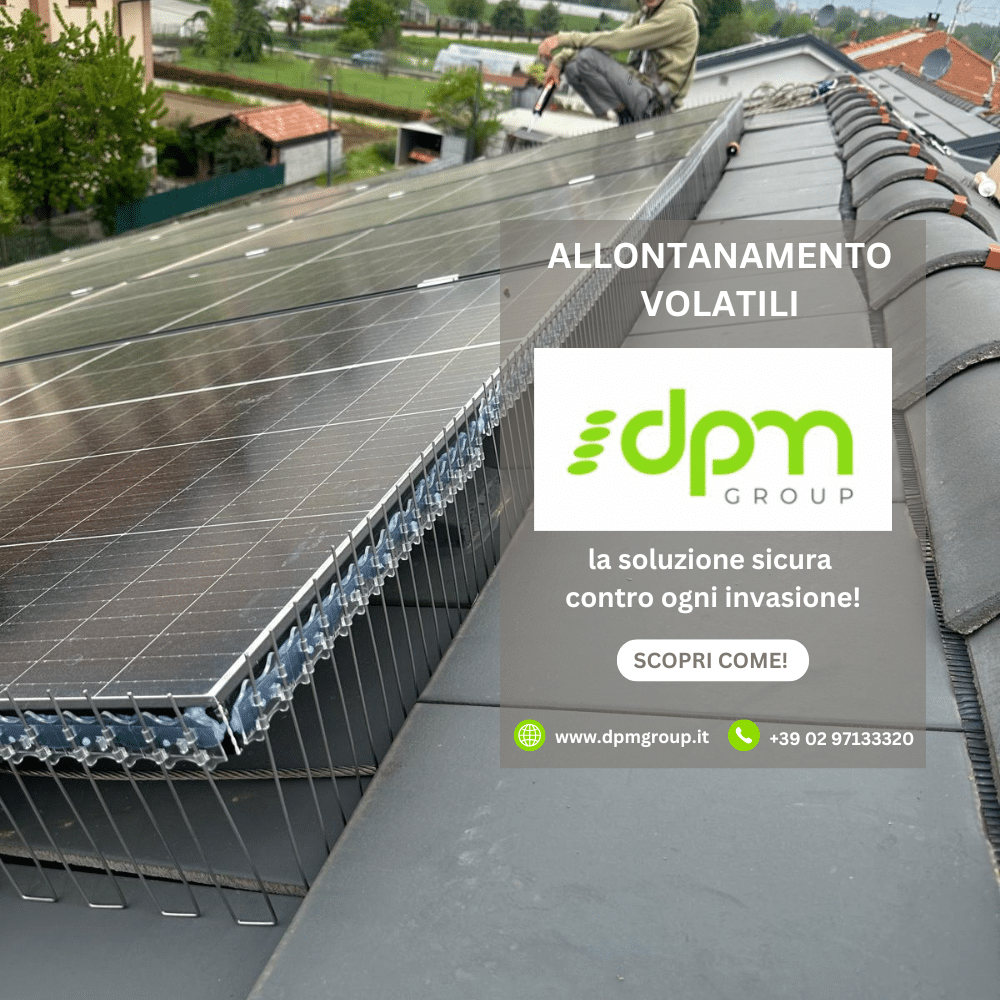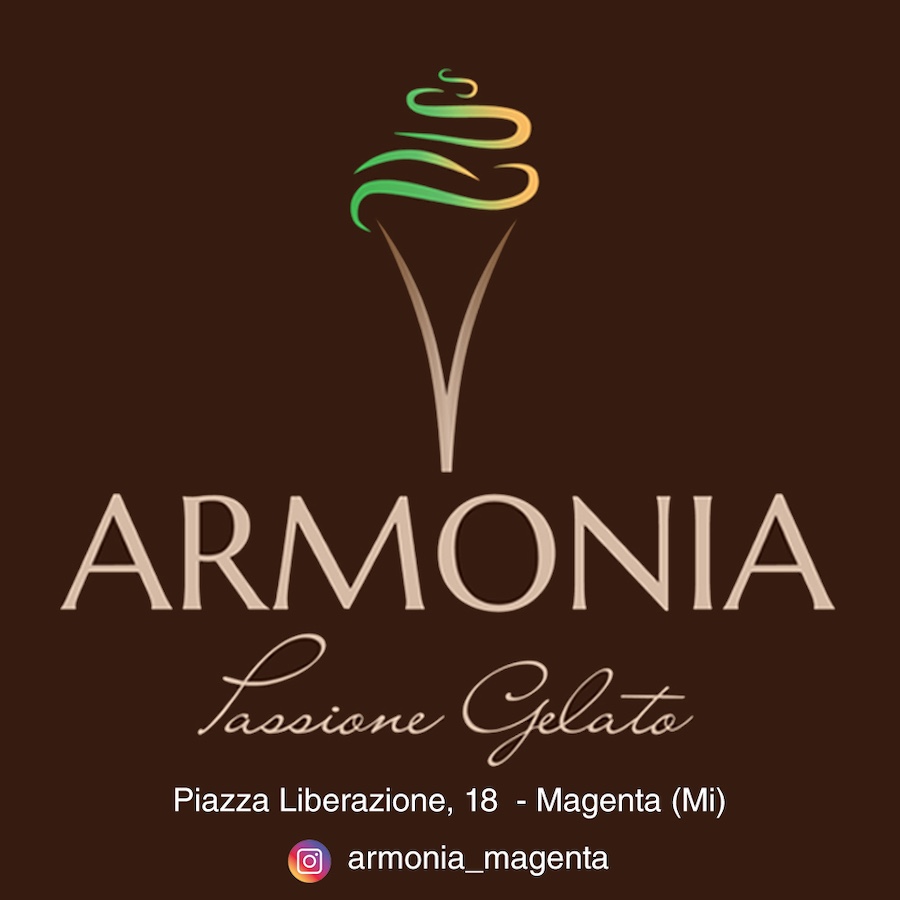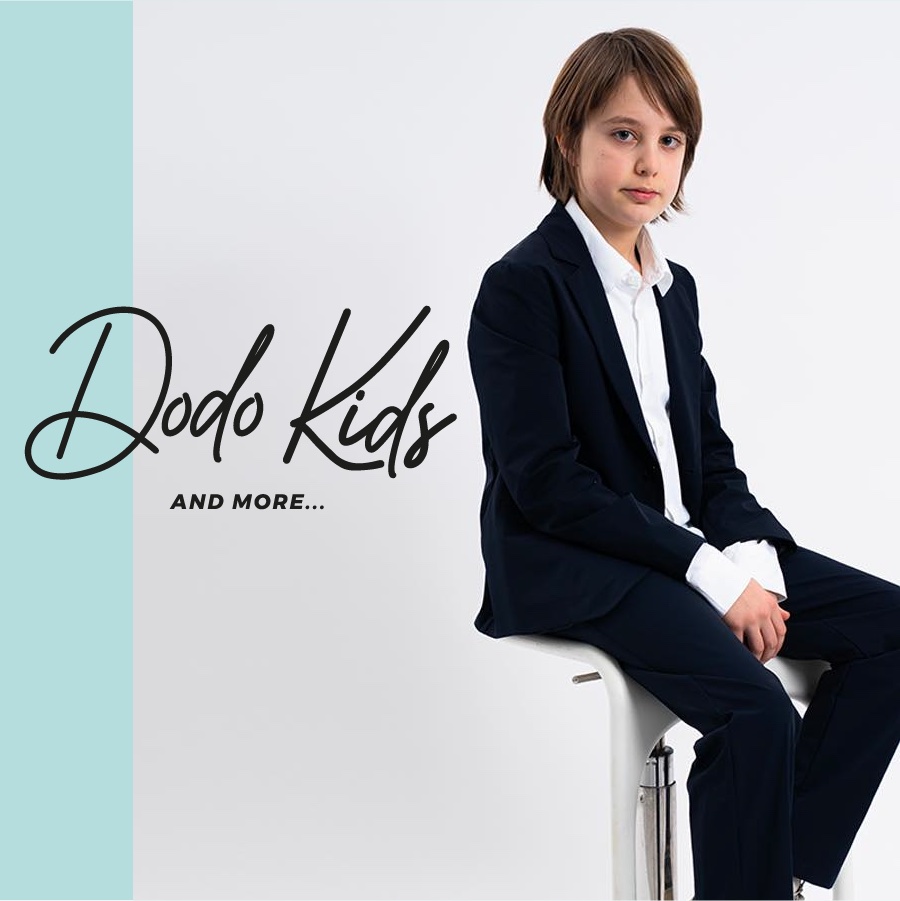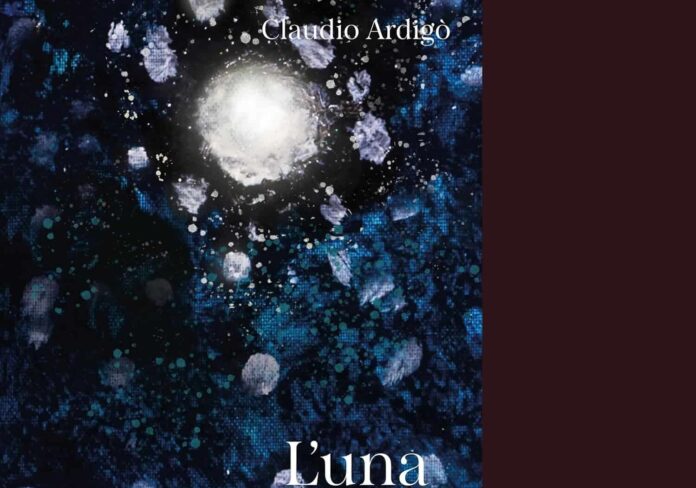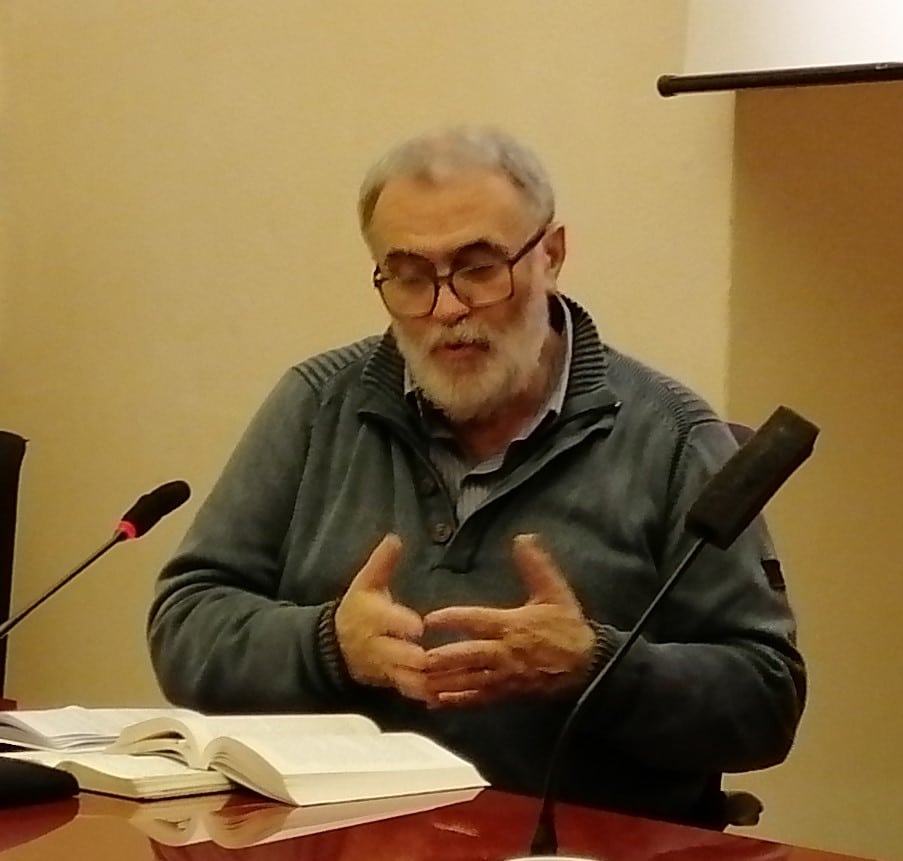Cremonese sin nel midollo, so che lei è stimato nella sua città per l’impegno in ambito sociale e politico, ma a più ampio raggio, per la sua passione per la narrativa; è, infatti, uno degli organizzatori della Fiera del Libro di Cremona, inoltre collabora nelle vesti di editor con diverse case editrici e, come giurato, in vari premi letterari tra cui i prestigiosi Campiello e Bancarella. Non posso quindi esimermi dal chiederle da dove viene tutta questa passione che la occupa non poco.
La mia passione per la lettura è lontana nel tempo. Mi ricordo che in seconda elementare si faceva la cresima e la comunione nello stesso giorno: era un momento importante perché era la prima tappa di una crescita che avrebbe portato all’età adulta. Era l’occasione in cui eri al centro dell’attenzione forse per la prima volta nella vita. Ricordo con piacere i padrini che, pur essendo contadini, fecero dei sacrifici per rendere quella giornata indimenticabile. Mi lasciarono un ricordo concreto tant’è vero che arrivò il mio primo orologio. Ma quello che colpì di più la mia fantasia e la mia attenzione fu un regalo di una cugina di mia madre… un libro: “Il principe e il povero” di Mark Twain.
Non vedevo l’ora di rimanere solo per leggerlo. Credo che sia il libro che ho letto e riletto più volte in assoluto nella mia vita e ho ancora quella copia. Cesare Pavese ha scritto che quando noi leggiamo un romanzo, cerchiamo la parte che più ci rappresenta. Quel libro mi rappresentava, mi immedesimavo in uno dei personaggi; o meglio, vorrei esagerare, sembrava la rappresentazione della mia vita di quel tempo. Ho capito che leggere significava entrare in un mondo in cui si poteva star bene, in cui la fantasia poteva essere la giusta contrapposizione alle difficoltà e alle restrizioni di quel tempo. Andavo a cercare i libri che erano in una piccola biblioteca dell’oratorio, li leggevo e li rileggevo, credo che sia in quel tempo che è nata la mia passione per la lettura. Ricordo che alle scuole elementari mi chiedevano spesso “cosa farai da grande”, e la mia risposta era sempre la stessa: il bibliotecario. Da adulto mi ha sempre colpito una frase dell’argentino Borges, che in una intervista ha detto: “Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto, io sono orgoglioso di quello che ho letto”. Questa frase è sempre stata un mantra nella mia vita, in quella che è diventata una professione o meglio l’epilogo naturale di una passione.
Come nasce l’idea di organizzare una Fiera del Libro in una città in cui le kermesse sono musicali e le fiere riguardano prevalentemente il settore agricolo e zootecnico?
La Fiera del Libro di Cremona è nata da un’idea delle librerie indipendenti della città, lontano nel tempo. Pur facendo svariate ricerche non ho mai trovato una data di inizio della manifestazione, ma ricordo di aver comprato il primo libro di Borges in una bancarella alla fiera del libro nel 1972, pertanto ho ritenuto per comodità, per affetto e nostalgia, di considerare questo l’anno d’inizio della fiera di Cremona. L’idea di mettere bancarelle di libri in una zona di passaggio, quale la galleria 25 Aprile e parte del giardino pubblico della città a mio avviso era geniale, essendo il punto d’incontro di vie centrali della città e con diversi aspetti interessanti.
Dava la possibilità alle librerie indipendenti (non esistevano ancora le librerie di catena Mondadori, Feltrinelli, Giunti, Libraccio o altre), di mettere su appositi tavoli a fianco delle ultime uscite, oltre ai Best Seller del momento, altri libri a poco prezzo, assolutamente nuovi ma fuori commercio. Con pochi soldi si potevano comperare prime edizioni di romanzi importanti, ma anche scoprire nuovi autori.
Allora il libraio era un po’ come l’attuale farmacista: ti consigliava un autore o un determinato romanzo in base al tuo stato d’animo, all’umore o alle emozioni che vivevi in quel momento. Credo che in quegli anni ho lasciato una piccola fortuna in libri di cui diverse copie conservo ancora gelosamente. Nel 2008 il portavoce delle librerie indipendenti che organizzava la fiera sulla falsariga del Festival della letteratura di Mantova cominciò a proporre presentazioni di autori.
Fu in quegli anni che cominciarono casualmente le mie prime presentazioni. Quel libraio si era accorto con quanto entusiasmo e trasporto parlavo di libri e autori e mi chiese se potevo collaborare con lui a presentare romanzi che la fiera proponeva. Da quel 2008 non mi sono più fermato, e dal 2010 ho cominciato a collaborare anche nella scelta degli autori da presentare facendo da anello di congiunzione con l’amministrazione comunale che permise alle librerie di non pagare più il suolo pubblico occupato, proprio per l’attività culturale che proponevano. Allora le presentazioni erano solo al sabato e alla domenica ed erano di un autore solo, spesse volte di autori cremonesi, anche se non mancarono nomi di rilievo.
Dal 2020 quando è mancata questa persona a causa del Covid, ho preso in mano la situazione sullo stimolo e l’insistenza degli altri librai e ho cercato di fare una rassegna che potesse soddisfare le esigenze dei lettori cremonesi. Oggi la fiera del libro ha due appuntamenti, uno primaverile da metà marzo fino a metà maggio e l’altra autunnale da metà ottobre all’8 di dicembre. Molti sono stati gli autori che hanno presentato i loro lavori alla fiera del libro e con diversi di loro è nato un rapporto di stima, di fiducia e amicizia reciproco che ha consolidato nel tempo un rapporto di mutuo aiuto: quando ho bisogno e mi mancano degli autori per completare le presentazioni so a chi rivolgermi e nello stesso tempo ho davvero tante richieste di autori che vogliono ritornare a Cremona. Normalmente le presentazioni primaverili sono intorno alle 40. Qualcuna di più nel periodo autunnale per il semplice fatto che tante volte, oltre al sabato e alla domenica, presentiamo autori cremonesi al venerdì.
Resta gratificante presentare certi autori non solo per il sottoscritto, ma anche per la cittadinanza; a volte le persone mi fermano per strada e mi chiedono di presentare quell’autore o quella scrittrice, naturalmente se tutto è fattibile cerco di ascoltare le loro richieste. Mi piace pensare che Cremona non venga ricordata solo come la città della musica o dei violini, ma anche e mi scuso per la presunzione, per questa piccola e modesta fiera che, pur essendo condotta in modo artigianale, dà un buon risultato di ascolto e partecipazione. Attualmente stiamo perfezionando un patto sulla lettura in modo che quando si svolgono le presentazioni non ci siano in concomitanza altri eventi letterari. Credo che questo possa fare la differenza sugli autori che andremo a presentare e che valorizzi sia le librerie indipendenti sia quelle di catena che ormai sono radicate fortemente sul territorio.
Lei ha presentato autori noti e meno noti, dando così spazio anche agli esordienti, di solito un po’ snobbati dalla maggior parte delle manifestazioni letterarie. Ci può dire il motivo di questa apertura e magari raccontare qualche aneddoto?
Le richieste per la fiera del libro degli autori cremonesi sono davvero tante e mi sembra corretto presentarli nella nostra città. Aneddoti ce ne sono stati diversi, mi piace pensare che Giuseppe Lupo, un autore da sempre Marsilio, sia stato… sdoganato dalla Fiera del libro di Cremona. Lo presentammo ad aprile del 2011, allora era un perfetto sconosciuto e fece una delle prime presentazioni proprio a Cremona. Quell’anno il romanzo che presentammo si intitolava “L’ultima sposa di Palmira” e risultò finalista al premio Campiello. Ricordo l’euforia di Giuseppe quando ci sentimmo per questo traguardo, che mi disse: “la vostra fiera mi ha cambiato la vita”. Molti altri autori allora poco conosciuti sono venuti da noi a presentare i loro romanzi prima di aver successo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Rosa Ventrella, Federico Baccamo, Nicoletta Bortolotti, Livio Gamberini, Gastone Breccia, Alessandro Bertante, Enrico Pandiani, Paola Barbato, Fabio Genovesi, Guido Conti e molti altri.
È grazie a questi autori che sono stato scelto come giurato a premi importanti, quali il Campiello e, per merito delle librerie indipendenti, al premio Bancarella. Un anno presentammo un libro sulla carriera di Francesco Moser “Ho osato vincere” della Mondadori; poche settimane dopo fui contattato da un dirigente di questa casa editrice presente alla fiera quel giorno che chiese la mia disponibilità per fare da giurato al Bancarella Sport, inutile dire che accettai all’istante.
Ci chiarisce cosa vuol dire per lei essere un critico letterario e cosa deve fare un buon critico per esserlo veramente?
Una domanda che mi mette un po’ a disagio, soprattutto quando mi si chiede cosa deve fare una persona per essere un buon critico letterario. Non sta me dire se sono più o meno bravo, è certo che come tutto quello che facciamo ci sono delle presentazioni che vengono particolarmente bene e altre che nonostante l’impegno non vengono come avresti desiderato. Credo che alla base di tutto ci deve essere senz’altro quell’onestà culturale che esuli da eventuali rapporti professionali. Cerco di spiegarmi meglio. Se ho delle collaborazioni con alcune case editrici non devo per forza essere costretto a presentare autori di queste case quando magari quello che mi si propone non mi soddisfa, e conoscendo il territorio cremonese probabilmente non è così interessante.
Pertanto, credo che sia importante saper dire “no” a certe richieste. Ritengo sia oltremodo importante non lasciarsi condizionare dai social o dalla sbandierata vincita o partecipazione a premi letterari, poi nelle altre domande toccheremo anche questo argomento. Non è detto che un finalista a un premio letterario sia sempre una garanzia per una presentazione vincente. Credo di più alla sensibilità e alla conoscenza dei gusti letterari delle persone che mi seguono e che mi convincono a fare certe scelte. Penso sia importante non lasciarsi condizionare dal mondo ambiguo e spesso non trasparente di agenti letterari o falsi editori che sbandierano conoscenze e capacità, ma che alla resa dei fatti non sono professionali. Per me essere un critico letterario vuol dire andare ad ascoltare le presentazioni degli altri per capire e confrontarsi con la visione di chi fa il tuo stesso mestiere e condivide la tua stessa passione. Vuol dire leggere molto, studiare, partecipare a festival letterari, proprio per vivere questo mondo che per comodità, chiamo letteratura. Ma vuol dire anche mettersi in gioco, a volte completamente, scrivendo in modo onesto e ponderato cercando di valorizzare un autore, magari alla prima uscita di un romanzo, ma vuol dire anche essere in grado in modo cosciente, lineare e corretto di valutare il romanzo più venduto in quel momento, se questi non soddisfa le mie esigenze o le mie aspettative.
Parliamo ora un po’ dei premi letterari. Se si cerca in internet alla voce Premi letterari, appaiono lunghi elenchi e, ad onor del vero, non è facile districarsi e capire quelli a cui vale la pena di partecipare, quindi, visto che è un addetto ai lavori, le chiedo qual è il metro per capirlo ed anche se reputa che nella scelta tra finalisti e vincitori vince davvero sempre il miglior testo.
Il mondo dei premi letterari è complesso e di difficile interpretazione per chi non è dentro alla macchina di questa attività. Ho grandi dubbi su alcuni premi letterari importanti. Se analizzo certi romanzi finalisti degli ultimi anni e faccio un confronto con altri di 15 o 20 anni fa, mi accorgo che nemmeno il vincitore merita di essere nella cinquina di questi premi. Purtroppo ho toccato con mano, e riprendo le parole di autori finalisti che mi dicono: “Tanto sanno già chi vince… tanto sanno già chi vincerà”. Ricordo che ero stato chiamato nel 2023 alla presentazione dei finalisti di quello che ritengo sia uno dei premi letterari più importanti in Italia: Il Premio Strega. Ricordo che quando arrivava un finalista in questo salone del Mudec, un fotografo si alzava e andava a immortalarlo. A un certo punto arriva un autore, e subito almeno una decina di fotografi sono andati a fotografarlo e il mio primo pensiero è stato: questo sarà l’autore che vincerà; infatti fu così.
In un’altra circostanza ero giurato in un altro premio importante e al mio fianco una persona mi chiese per chi avessi votato. Glielo dissi e gli feci la stessa domanda. L’autore che aveva ricevuto il suo voto era famoso per i suoi romanzi storici, così mi venne spontaneo chiedergli se fosse appassionato di questo genere. Mi rispose che il romanzo non lo aveva nemmeno letto, ma aveva avuto pressioni e aiuti economici dalla casa editrice di quest’autore e che alla fine aveva pensato bene di votarlo. Sono stato anche giurato in un premio dove mi si chiese di votare un determinato scrittore, tra l’altro molto famoso, ma non solo rifiutai, ma votai un altro autore dandone apertamente le motivazioni. Non sono più stato selezionato per essere giurato in quel premio letterario, credo che questo non sia un dispetto, ma un punto di forza che caratterizza il mio modo di comportarmi.
Credo ci siano serie di premi letterari inutili, soprattutto quelli indicati dalle case editrici a pagamento. Mi sembrano semplicemente delle gratificazioni a chi in definitiva paga per stamparsi un libro. Non li considero veri premi letterari ma una strategia della casa editrice per mantenere alto il numero delle persone che possono stampare con loro un romanzo. Ho visto persone che si sono abbattute perché non sono state finaliste a premi letterari, come ho visto persone che hanno cambiato atteggiamento in modo radicale dopo aver raggiunto un simile obiettivo. Posso dire che a volte anche la scelta dei finalisti a certi premi non è sempre così limpida, ma gli interessi economici che gravitano attorno a questi eventi sono così evidenti che a volte mi domando se ha senso continuare a organizzare certi premi. Se si arriva in finale a un premio letterario anche importante, non è detto che automaticamente sia un buon romanzo. In questo mondo esiste troppo autostima, molti si ritengono Pasolini, Pavese, Sciascia, la Morante o la Fallaci, ma non è proprio così. Dico spesso agli autori: “siate voi stessi e scrivete anche per il piacere di scrivere, poi tutto il resto verrà di conseguenza”, ma il primo consiglio che vorrei dare è di scrivere per il piacere di farlo.
Oggidì ci sono un buon numero di persone che hanno velleità letterarie e quindi frequentano costose scuole di scrittura creativa, una formula inventata negli anni Trenta del secolo scorso dal pedagogista statunitense John Dewey e poi esportata anche in Europa e quindi da noi. Taluni sostengono che questi corsi hanno omologato l’arte di scrivere appiattendo la creatività personale e soprattutto la cifra stilistica che un autore dovrebbe avere per farsi riconoscere dagli altri scrittori. Qual è la sua opinione in merito?
È triste ammetterlo, ma le scuole di scrittura a mio avviso hanno rovinato il mondo letterario e della scrittura in Italia. Quando trovo in cinque righe sette punti mi arrabbio, perché questo non è scrivere, questo, passatemi il termine scontato, abusato e già sentito: è lo specchio del linguaggio moderno e la scrittura di oggi risente di tutto questo; testi che rappresentano una serie di parole proprio come quando mandiamo un messaggio, ma questa non è letteratura. Questa è comunicazione.
Credo ci sia una notevole differenza. Chissà cosa penserebbe oggi Giovannino Guareschi che diceva che l’arte tutta italiana sta nella capacità di raccontare e scrivere storie. L’ho sempre creduto e ci credo ancora, e sono convinto che questo non è il modo di fare letteratura. Mi spiace essere così radicale nel mio giudizio, ma è la verità: non esistono più l’immaginazione e la fantasia. Se penso poi ai dialoghi, mi accorgo che oggi sono davvero pochi i veri scrittori. Capisco che sia una parte difficile, ma per imparare è necessario studiare, leggere e rileggere gli autori che hanno questo talento. Si è persa anche la capacità di valorizzare un testo attraverso i dialoghi. Provate anche a pensare alla musicalità di un racconto o di un romanzo, essa esiste sempre meno; è un peccato, è una caratteristica che va scomparendo, e questo è un altro elemento che mi rattrista.
E la punteggiatura? Si usa troppo il punto, si usa poco e male la virgola, il punto e virgola va scomparendo. Credo che un bravo scrittore debba prendere in mano un manuale di punteggiatura e scoprire come usarla correttamente.
Le ultime statistiche dicono che in Italia la vendita di libri, rispetto al 2024, è calata del 3,6% sia per quanto riguarda i romanzi che la saggistica con una perdita di 15,9 milioni di euro: ha pensato a quali potrebbero essere le cause di questa disaffezione?
Siamo uno dei popoli in Europa che legge di meno; mi sono sempre domandato il perché, quando tutti i giorni si stampano non so quante copie di libri. Ma allora tutti questi libri chi li legge o meglio chi li compera? Io che faccio diverse presentazioni mi accorgo che la vendita dei libri è sempre più in calo. Prendiamo i nostri vicini di casa, i francesi. A marzo ho presentato a Modena un autore che qualche anno fa è stato finalista allo Strega: 64 persone presenti, libri venduti 4; lo stesso autore a una presentazione in Francia mi ha detto di aver firmato più di 300 libri, ed era lo stesso romanzo; certo era una platea con un numero maggiore di persone, ma domandiamoci lo stesso il perché. Vado spesso a fiere o festival letterari e tante volte per curiosità mi fermo a guardare quanti libri vende un autore. In un contesto letterario importante, un autore Rizzoli, quindi di una casa editrice famosa, i presenti erano una cinquantina e io sono stato uno di quelli che ha acquistato il libro, e poiché mi piace quest’autore mi sono fermato per capire quanti libri potesse teoricamente vendere… insomma, insieme al mio ha venduto quattro copie e vi posso garantire che è un veramente un ottimo autore. Un giorno in un convegno, parlando proprio della difficoltà di vendere libri e di leggere, mi è arrivata una risposta stranissima: “…se in Italia siamo agli ultimi posti nelle vendite insieme alla Spagna, è perché noi abbiamo il sole”. Se questa risposta mi ha fatto in parte sorridere, è però anche vero che mi sembra l’alibi comodo di chi non ha argomentazioni concrete per controbattere. In una presentazione all’università di Padova ricordo che aveva fatto scalpore una mia frase che in parte dà continuità a questo discorso: “viviamo in un tempo dove ci sono troppi libri e pochi scrittori, molti poeti e poca poesia”; la provocazione credo sia evidente, ci sono troppi libri mediocri che davvero non vale la pena di leggere e ne soffre tutto il mercato letterario.
Recentemente ha pubblicato una raccolta di poesie intitolata “L’una” che è stata molto elogiata dai lettori. Cosa l’ha spinta a indossare i panni del poeta?
Credo di essere una curiosa anomalia. Sono il primo a dire che quando una persona scrive non è vero che scrive solo per se stessa, ma scrive per lasciare una testimonianza agli altri, evidentemente predico bene ma razzolo male. Ho sempre scritto poesie da quando avevo quattordici, quindici anni, e adesso che sono vicino ai settanta mi sono accorto che le ho sempre tenute per me; infatti ho decine di Moleskine pieni di poesie. Sono sempre state pochissime le persone che le hanno lette, proprio per una mia scelta personale. Ho sempre pensato che avesse ragione Benedetto Croce quando disse che si può scrivere poesie fino a diciotto anni, poi o sei un poeta o sei un cretino e siccome so di non essere un poeta per non fare la figura del cretino, non ho mai voluto pubblicare o sono sempre stato restio.
L’Una in verità è la mia terza silloge poetica. La prima raccolta fu Amanti di Carta frutto di un’uscita curiosa. Un’autrice aveva scritto un libro a mio avviso bellissimo, e io insistevo affinché lo pubblicasse, ma essendo autobiografico lei non voleva saperne, ma le mie insistenze furono così forti che alla fine indispettita disse: “lo pubblico se tu lo fai con le tue poesie”, lei era stata la prima a cui ho fatto conoscere quello che scrivevo. Pensavo che alla pubblicazione del suo romanzo dimenticasse la mia promessa, purtroppo non fu così e uscì questa raccolta in modo frettoloso, tanto che ho sempre pensato fosse uno sbaglio e oggi ne sono più che convinto.
In un secondo tempo una casa editrice con cui avevo una collaborazione professionale mi chiese di pubblicare le mie poesie ma, a fronte dell’esperienza precedente negativa, dissi praticamente sempre di no. Poi una poetessa mi chiese di scrivere a quattro mani un libro ed io accettai perché la condizione era oltremodo curiosa: il libro era destinato solo al mercato dell’America Latina, quindi in spagnolo. Quella raccolta aveva come titolo Amore all’Infinito.
L’Una, pur restando sempre del parere che non sono un poeta, è una raccolta di cinquantaquattro poesie dove in quasi tutte c’è la parola Luna. Luna non è solo un astro ma è un punto di riferimento, una metafora, è donna, scrittrice, moglie, figlia, sorella, sono tutte quelle persone con cui ho fatto un pezzo di strada insieme o se volete, è un gioco, un divertimento dove cerco di mascherare le persone dietro l’astro. È uscito un lavoro credo interessante e unico nel suo genere in cui sfido le persone a riconoscersi. Accetto tutte le critiche inimmaginabili. Quelle le merito tutte.
La modestia, l’onestà e il coraggio delle opinioni non mancano certo a Claudio Ardigò di cui, a questo punto, non posso che suggerire la lettura di L’Una, dove potrete scoprire di più su di lui e sul suo sentire poetico.
I miei romanzi li trovate nelle librerie e nei bookshop on line
Luciana Benotto