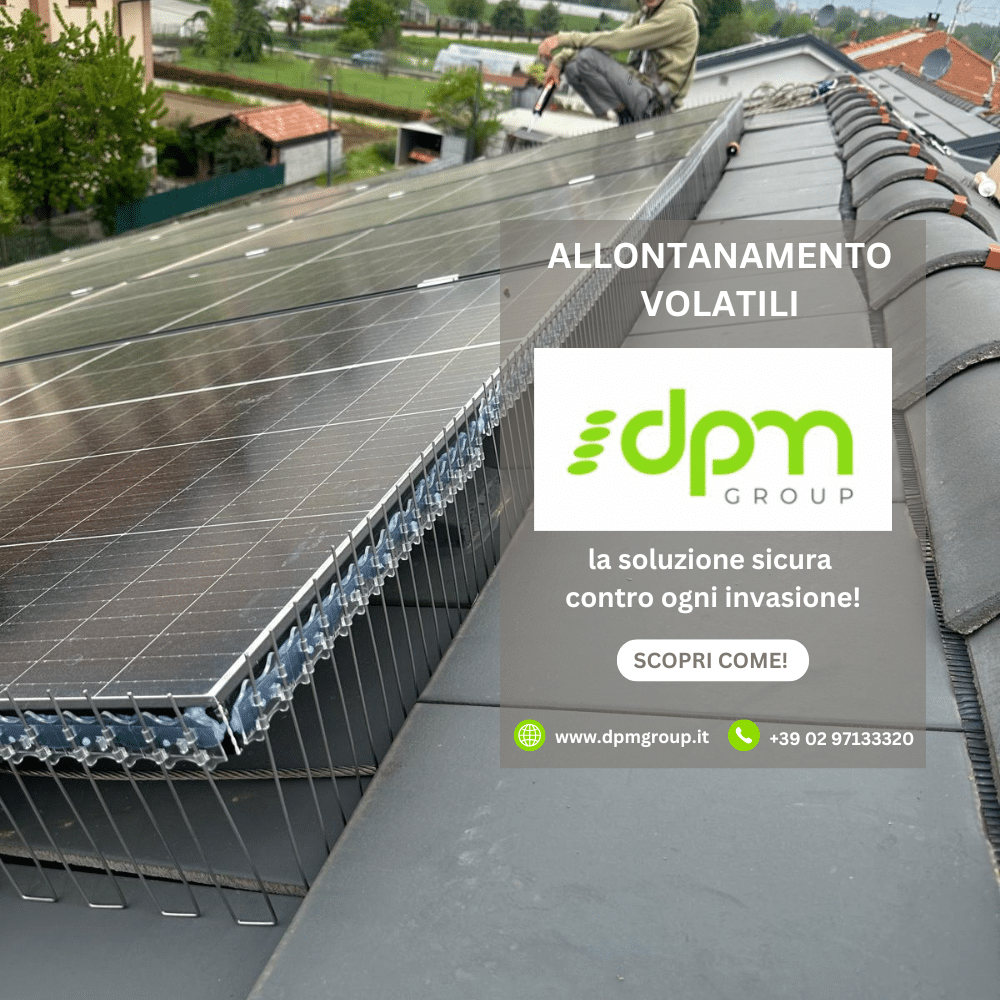Di recente l’iconica Fran Lebowitz è stata a Milano. Assieme a lei c’era pure Camilla Garavaglia, che c’ha scritto sopra un altrettanto iconico pezzo. Periglioso, ma alla fine il retrogusto è quello dei tortellini alla panna. Però nella versione di Massimo Bottura.. Ergo, leggete. Ne vale la pena.
Questo è l’articolo che non avrei mai voluto scrivere, e per tre diverse ragioni.
La prima: è passata una settimana e quattro ore dallo spettacolo, un po’ tardi per essere giustificato dal novecentesco dovere di cronaca. Poi: ne ha già scritto, tra gli altri – ma non so mica se ce ne sono altri, io ho letto solo lei – Guia Soncini, e già dal momento in cui l’ho vista fluttuare via dal teatro, con Christian Rocca, in un abito forse bianco e azzurro (un Miuccio? Non saprei, la fantasia dell’abito richiamava un po’ le porcellane Ming e un po’ le tazze del prosciutto Ferrarini, sono così poco avvezza ai lussi che non saprei fare distinguo) ho capito che non avrei mai potuto scrivere un articolo sul tema “Fran Lebowitz a Milano” perché tanto lo avrebbe scritto già lei. E che serve allora che ne scriva anche io.

Però. Sono ormai 13 mesi, li conto come gli stagionatori del parmigiano, che Ticino Notizie (leggasi, Fabrizio Provera) mi ripete: “eddai, scrivi un articolo per noi sul tema x”. E se sono abbastanza pigra per rifiutare cinque volte non sono abbastanza arrogante da rifiutare una sesta.
Perciò eccomi qui, con tutte le matite temperate e il candelabro acceso – prima lezione di procrastinazione: non vorrai mica metterti a scrivere con le matite non temperate e senza tutte le candele di casa correttamente accese? – a raccontare lo scorso venerdì al teatro degli Arcimboldi.
Scena 1- Faccio conto che sappiate chi sia Fran Lebowitz, e senza uso di preterizioni. La scrittrice che non scrive, la protagonista della serie Pretend it’s a city, la battutista che parla e ti fa esclamare “cazzo, questa me la rivendo”.
Non che io sia titolata a parlare di Lebowitz: sono talmente tanto inetta in fluency che la pronuncio Laibowitz, senza una ragione fonetica al mondo. Ma ho acquistato il biglietto per la serata mesi fa, in quattordicesima fila, e porto con me l’amica V vendendole la serata come regalo di compleanno. “Fidati” le dico “ sarà una serata storica. L’Arcimboldi sarà the place to be, quella sera, io ne so di queste cose”.
E come me devono averla pensata anche tutti gli intellettuali della Milano-non voto Pdchevolgarità- votereiBoninomadisperdoilvoto- peròSalachegransindaco che si sono radunati qui per l’occasione. Tutti insieme non riempiamo il teatro, che invece in occasione del noiosissimo musical sulla Divina Commedia era sold out, ma d’altra parte a riempire l’Arcimboldi in quell’occasione c’era mia madre, posto in balconata con sbarra a coprire la vista, due ore a domandarmi “chi è quello con la toga?” per validare un consumo culturale riconosciuto persino al paese. Insomma: Divina Commedia riassunta male e cantata così così: pienone. Fran Lebowitz: diversi posti vuoti. Poi uno dice: radical chic.

Scena 2- Arrivo con amica V in pigiama con bordo di piume, shopper del New Yorker e Roger Vivier d’ordinanza. Lei ha mocassini e trench, bravissima: siamo perfette per mescolarci con gli indigeni. Temiamo però di essere smascherate: per sembrare vere newyorchesi ci manca il berretto five panels e la solita fluency, ma ci mimetizziamo con i madrelingua occupando i nostri posti in fila 14 e stando ben mute in attesa che tutto inizi.
Scena 3- Tutto inizia e io annuisco freneticamente su ciascuna frase che riesco a intendere, ridendo con aria saputa quando il pubblico ride. Capisco il 40% in purezza di ciò che viene detto, il 20% lo intuisco ricordando la raccolta di scritti di Lebowitz “La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire” e il resto lo ricostruisco assemblando ciò che l’amica V capisce grazie alla sua fluency. Arriviamo, insieme, ad un onestissimo 90%. Su Trump e Biden ci siamo, sulla natura “così naturale” anche, sull’Oklahoma che è fatto di niente pure. Ridiamo molto quando Fran racconta di aver corretto un energumeno che in un parco pubblico di notte declina “mouse” al plurale come “mouses” e non come “mice”, e lei lo corregge anteponendo la grammatica alla paura di essere aggredita.

Annuisco ancora più freneticamente quando racconta uno degli aneddoti più divertenti. Quello in cui un passeggero muore in aereo nella tratta tra Roma e Parigi e il suo compagno di posto si rifiuta di sedere vicino a un cadavere: Fran si offre per fare a cambio e la battuta è già visibile a distanza come la terra ai marinai, dice “il morto è stato il miglior compagno di viaggio di sempre” e io annuisco freneticamente, dicevo, perché per due ore ho avuto accanto il peggior spettatore dell’Arcimboldi di sempre. Quello americano, ma di stanza a Milano, che tiene le gambe spalancate rubandomi spazio e batte le mani e dice “oh, yeah!” a ogni frase e urla, impreca, mentre tutti lo fissano disgustati ma silenti nel più grande covo d’intellettuali di sempre.
Scena 4- Mi imbarazzo molto durante lo spazio lasciato alle domande del pubblico, io che mai oserei pensare a una domanda per il terrore di essere banale (lo sarei stata), e mi incanto di fronte a una ragazza che si impegola su una domanda che parte da Pirandello e arriva non si sa bene dove. Sudo, un po’ mi muovo sulla poltrona a disagio, l’americano del posto accanto grida “oh, COME ON!” spingendomi a solidalizzare con la ragazza.
Scena 5- Chiedo scusa a V per essere stata così pezzente da aver acquistato un biglietto in 14esima fila e non in quinta, dove saremmo state sedute a fianco di Alessandro Cattelan (o a qualcuno che gli somigliava molto) invece che accanto a uno che ho davvero voluto morto per tutto lo spettacolo.
Scena 6- Rientro in provincia, le Roger Vivier sul sedile posteriore e le ballerine ai piedi per non ciancicare la frizione. Ascolto Sam Fragoso intervistare Lebowitz in “Talk Easy” mentre i cartelli mi deviano dall’A4 verso strade inesplorate (ma comunque a pagamento). Allenando la fluency, per la prossima volta che ricapita. Sperando ricapiti.
Camila Garavaglia