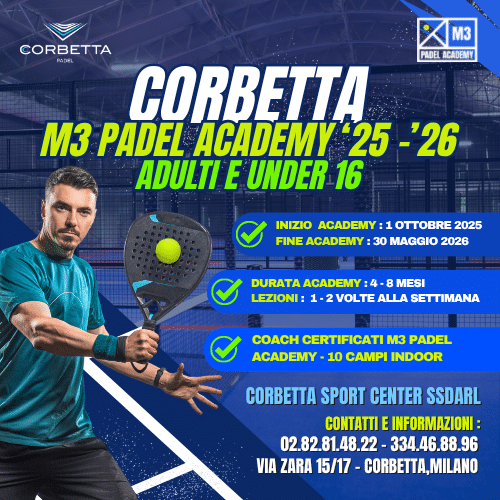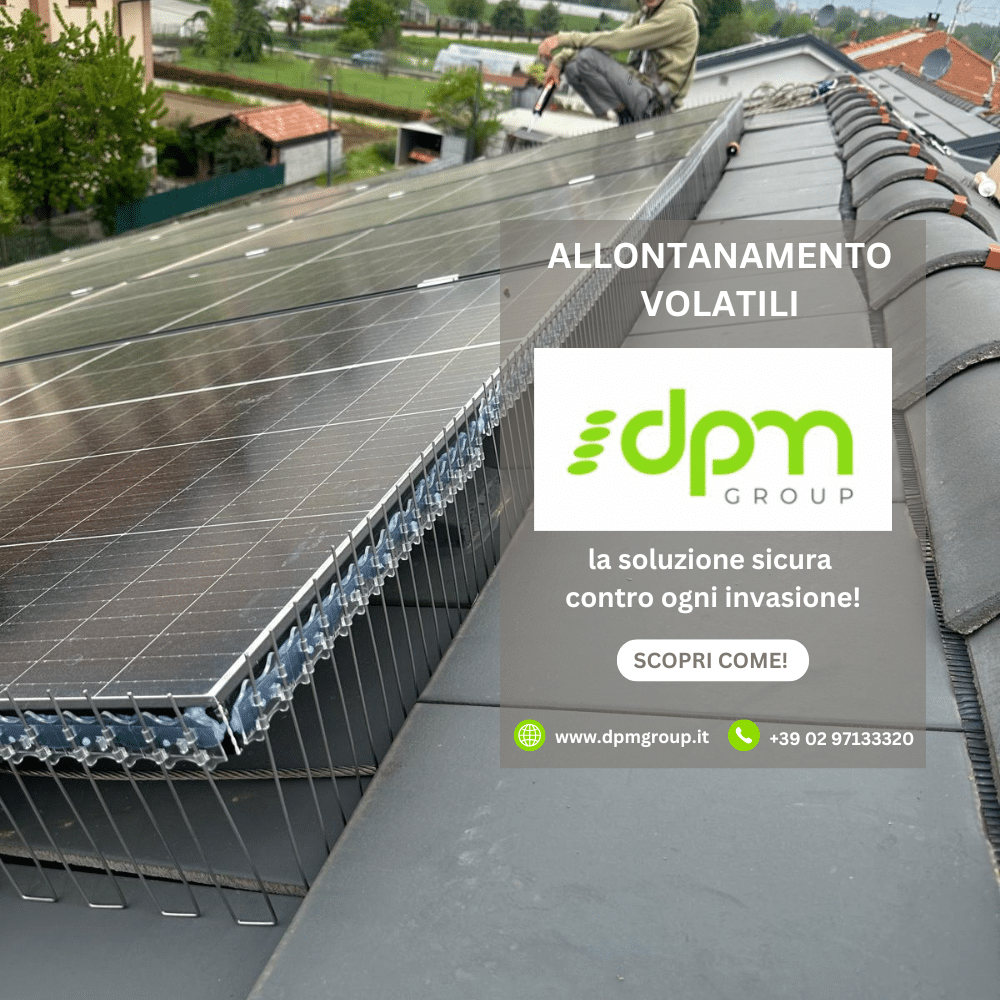Questa storia potrebbe essere davvero iniziata a Trinidad, l’angolo di mondo disperso nei Caraibi. Mezzo secolo fa, l’isola che ha subito le colonizzazioni di mezza Europa, tanto per cambiare, non è che se la passasse bene: povera, anzi poverissima nella sua quasi totalità degli autoctoni. Povertà, del resto succede sempre, che fa rima con protesta, quella dei giovani che si scoprono inchiodati ad un presente deficitario con la prospettiva di un futuro, se possibile, anche peggiore. E tra i giovani isolani di discendenza africana prende piede innanzitutto uno stile che in fretta si traduce anche in musica per soddisfare un’impellente esigenza comunicativa: il Calypso. Il termine pare derivi da ‘kaiso’ che per gli africani sta geneticamente ad indicare qualcosa di ben fatto. Peraltro, Calipso è anche la dea greca del mare e vorrà pur significare qualcosa.
La base è ovviamente multiculturale, perché alle percussioni tipiche dell’Africa si sommano le influenze stilistiche dei conquistatori, il risultato è policromia. Musica che piace al popolo, perché fatta dal popolo per il popolo al quale tutto è imposto con brutalità, e decisamente meno ai padroni coloniali che, infatti, mal digeriscono le liriche taglienti di cantanti che prendono costantemente di mira le storture sociali, l’odio, il razzismo e la prevaricazione dei pochi sui molti; al punto che non è insolito salti fuori una legge che provi a mettere un bavaglio al caleidoscopico dissenso dei cantori calypsonian. Gente di cultura e fantasia, che inventa parole, conia locuzioni, detta la tendenza. Insomma, crea appartenenza. Vocabolo che, insieme a identità, traduce il sentimento che accomuna chi ha nel sangue le molecole della rivolta.
Il Calypso è progenitore di un sacco di cose, sempre per restare ancorati al pianeta musica. Le jam della musica rap, le famose battle nel cerchio, dove due rapper si sfidano a colpi di rime palleggiando il microfono, tanto ricordano il ‘picong’ del calypso, quando, al ritmo sincopato dei tamburi, i duellanti metaforicamente si colpiscono a vicenda con rime di scherno bonario. Non solo. Chi dal 1969 in poi si è definito uno Skinhead con cognizione di causa variabile o, qualche anno più tardi a partire dall’anno di gloria 1977 un Punk, ecco che, magari senza rendersene conto, ha lo stesso molto da spartire con quegli albori incendiari che si perdono nelle piantagioni di canna da zucchero che nella Trinidad strattonata per la maglia dallo sciovinismo europeo si susseguivano a perdita d’occhio.
Ciò, perché la musica dei Rude boy – quelli di strada, con tre bottoni sulla giacca e le scarpe di pelle lucida come specchi – quindi Rocksteady e Ska, che a loro volta anticiperanno Oi! e Punk, ha un padre. Mezzo cubano e mezzo giamaicano, con i mari dei Caraibi che ritornano nella nostra storia come un romantico leitmotiv. Si chiama Laurel Aitken e nella città simbolo di Kingston, Giamaica, degradata e pericolosa nei sobborghi al contempo pregni di vitalità, comincia a farsi conoscere cantando proprio il Calypso anche se inizialmente a beneficio dei turisti borghesi da navi da crociera. Dalla sua inesausta creatività nasce il Boogie Shuffle giamaicano, il Blue Beat per intenderci, quando ancora il termine Ska è ancora lontano dall’essere universalmente compreso. Genesi, quella dello Ska, che farà seguito alla sua dipartita con direzione Regno Unito, insieme ad una moltitudine dei ragazzi rudi di cui sopra, proletari e incazzati, dove la sua inarrestabile parabola musicale avrà quale primo risultato imperituro una pietra miliare come “Ska with Laurel”, titolo che da solo precorre ciò che accadrà poi.
Ai suoi concerti, più in generale, succede qualcosa di parecchio interessante. Sotto al palco si mescolano, attratte come poli antitetici di una calamita, due sottoculture: quella dei Mods, i modernisti che ontologicamente detestano tutto ciò che ha segnato la vita dei loro antenati dalla quale fuggono a gambe levate, e, appunto, quella dei Rude Boy in arrivo dalla Giamaica, peraltro, da poco indipendente. Li accomuna la provenienza sociale, quella working class dalla quale i giovani tentano di evadere per lenire l’alienazione di un sistema economico che velocemente assume i connotati di un tritacarne, nel quale a farne le spese sono gli ultimi, sempre più ultimi ed emarginati, con la classe dominante sempre più dominante. Perché cinquant’anni più tardi, lo abbiamo a un palmo di naso, tutto cambia ma tutto resta uguale. La frequentazione è esplosiva. Londra, prima che il ’77 significhi Punk e odio per la Regina, vede, appunto, l’incontro delle due subculture che abbiamo compreso essere diverse ma sospinte dall’identica propulsione sociale.
La mescolanza algebrica Mods più Rude Boys significa Hard-Mod, senza troppi giri di parole la nascita del movimento Skinhead. Un cerchio che si chiude e abbraccia le spiagge assolate di Trinidad, il caos malavitoso di Kingston e la suburbia londinese Che sarà thatcheriana. Anno 1969, il punto zero. Dalle atmosfere calde dei calypsonian, accompagnate da sarcasmo lirico e tamburi festaioli, alla ferocia della triade chitarra-basso-batteria, odio di classe divampante, riff taglienti come spade, voci ruvide come carta vetrata che arringano la folla e sottofondo di cori da stadio: la musica Oi! si impossessa delle strade. Il mondo, ben presto, fa la conoscenza di Pursey con i suoi Sham 69, gente che segna un passo nuovo senza dimenticare perché e come è giunta fino a lì. Il resto è storia più o meno recente.
Mensi, voce degli iconici Angelic Upstarts, da qualche anno ci ha lasciato ma la sua strenua difesa del proletariato resiste immutata nei pezzi ascoltati fino allo sfinimento che odorano di socialismo e contrattacco e il suo esempio è servito da ispirazione ad una moltitudine di artisti che ancora oggi hanno il pregio di pensare che un altro mondo, possibilmente più equo, possa ancora essere possibile. Il motivo di questo lungo e nostalgico back in the days è che tra questi, per restare orgogliosamente all’interno dei nostri confini, i Bull Brigade che impreziosiranno il palco del Gerusco, i capisaldi della cultura punk e skin hanno scelto di non perderli mai di vista. La loro bussola segna sempre la stessa direzione, è la resistenza delle periferie che non si placa o, per dirla come loro, il fuoco che non si è ancora spento.
Chiosa finale che si articola su due inviti. Il primo è quello di perdere qualche ora del nostro tempo per leggere ‘Spirit of ’69 – la bibbia skinhead’. Libro vergato diverse decadi fa da George Marshall, uno di quelli che c’era, che è necessario per fare chiarezza su un tema socio-politico complesso e caratterizzante ma troppo spesso liquidato dal pensiero egemone come ciò che realmente non è. Non diremo cosa, ma intendono proprio quella robaccia lì. Il secondo, ovviamente, è di farsi trovare duri e incazzati sotto al palco del Gerusco dove, almeno per una sera, Robecco si traveste da periferia urbana di una metropoli che ingloba anime differenti, con i suoi suoni, la sua rabbia, i suoi colori. Quelli della strada.