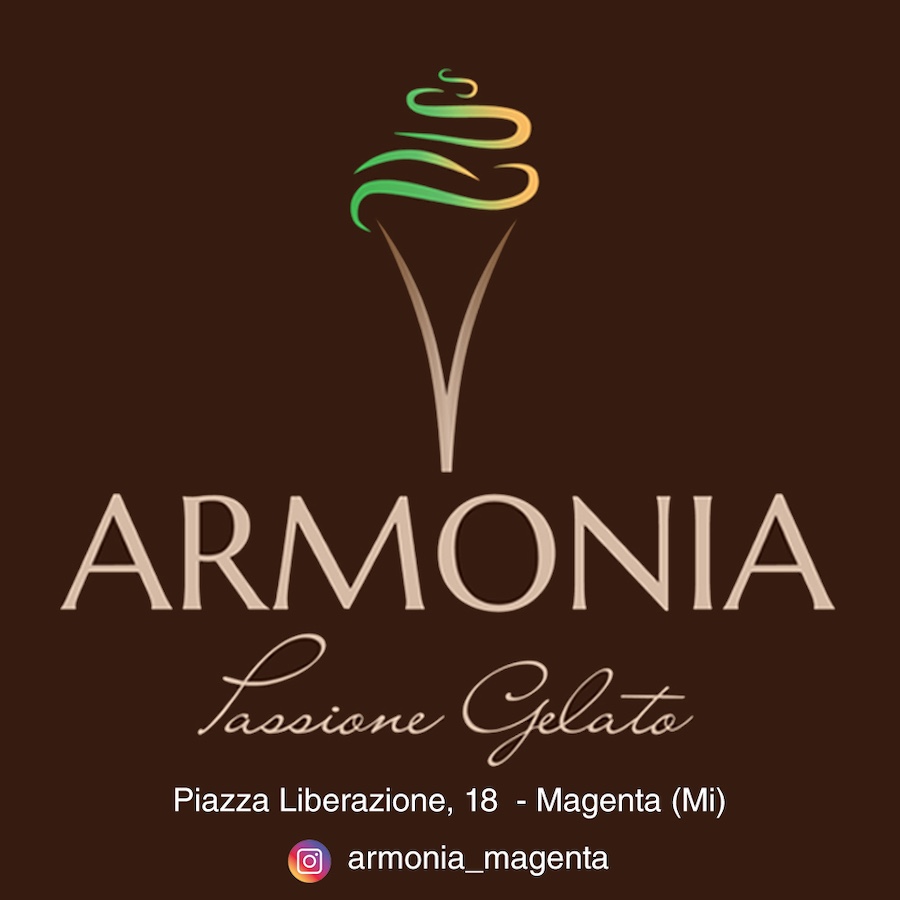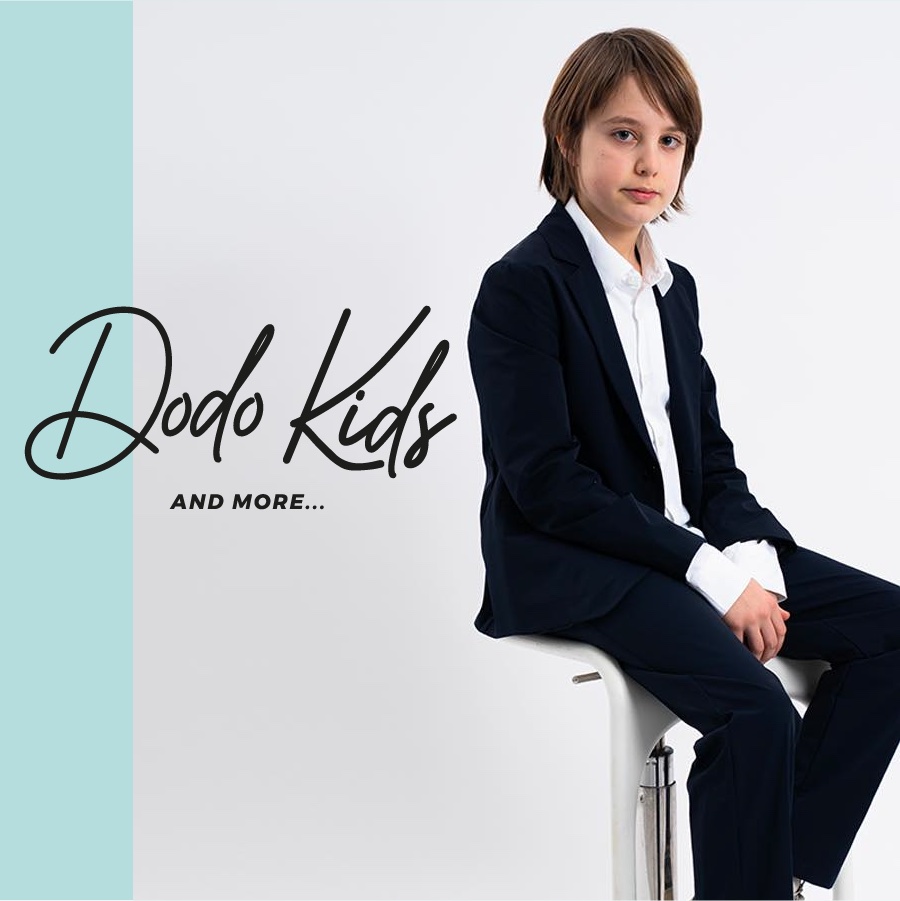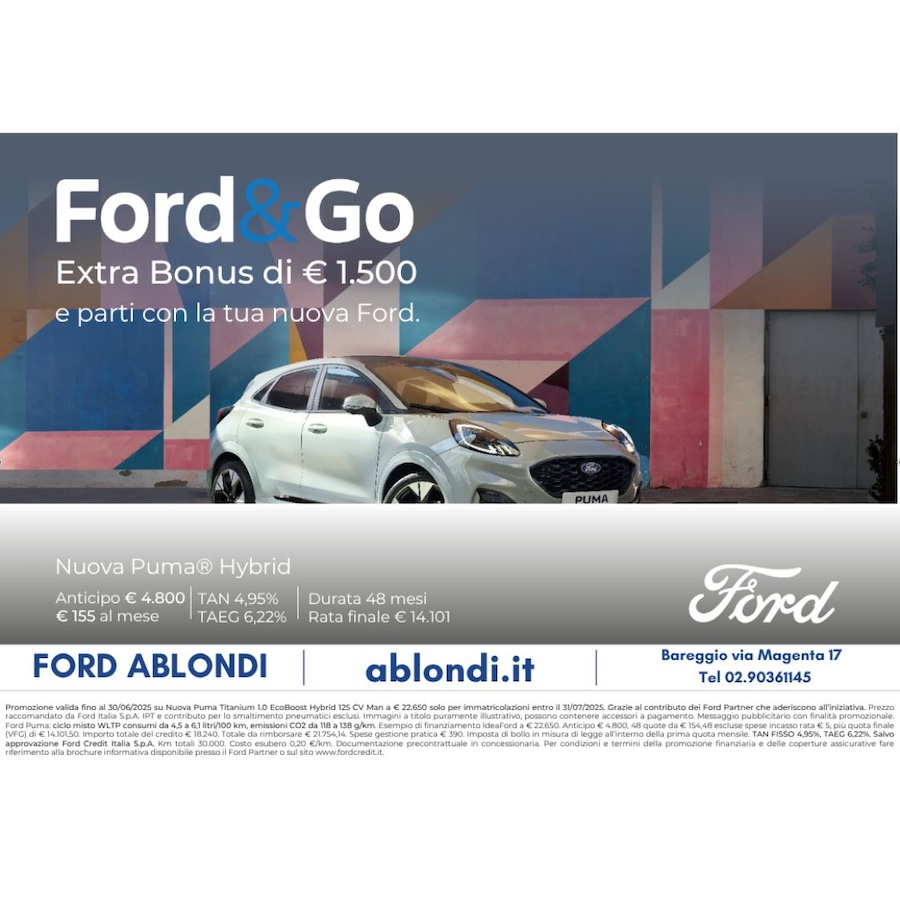Francesco Oppi si è caricato da anni l’eredità di papà Daniele e conduce con passione e coraggio l’attività culturale ed artistica al Guado di Malvaglio, in una bellissima casa adagiata lungo il Naviglio. E’ appassionato al reale ed alla vita di comunità. E’ un uomo e un padre. E da uomo, e da padre, ha scritto di getto e rabbia parole che crediamo valgano la pena di essere lette sul caso di Abbiategrasso.
“Dagli all’assassino! Buttiamo via la chiave! È ora di finirla! Siete tutti buonisti! Questa scuola va protetta, è tutta colpa dei genitori! Noi siamo dalla parte giusta, SEMPRE!”
Che orrore. Una società zoppa, monca, lobotomizzata, arrogante e sicumerica. Figlia d’una comunità incapace di esserlo e di esercitare autocritica (altro che sinistri!), che non accoglie per principio. Comunità incapaci di accogliere persino i figli. Comunità dedite alla ricerca spasmodica dell’intelligenza artificiale, in quanto prive di quella naturale.
La nostra (farcita di fatti malamente – e inutilmente – comunicati) si manifesta come una società senza coscienza, senza contezza di sé. Senza l’orgoglio del proprio “turgido” passato e delle proprie immense potenzialità. Un’accozzaglia di controllati incontrollabili senza progetto, senza condivisione, senza Poesia…
Un mezza società di inetti che è capace solo di “PUNIRE!” o “CONTROLLARE” oppure di finire, parallelamente, al sesto raggio… Povero Beccaria… pensare che paradosso, essendo tra i nostri grandi Padri!
Oggi, ora, sono tutti attaccati alla “nera”… al coltello da Rambo, a ruoli fasulli, a parole sussurrate da serpenti, infine a menzogne.
E’ nostro figlio, come gli altri, quel ragazzo di sedici anni! Se lo aiutiamo (ma davvero, non con dolosi, impreparati “assistenti”) aiutiamo noi stessi. Se non pensate sia giusto farlo, io vi dico con tutto il cuore: vergognatevi; e se non siete capaci di farlo (e non è un buon segno) sparite per sempre, pennivendoli disperati o chiunque voi siate. Tanto siete il nulla che produce il vuoto.
Non metto volti perché voglio ricordarvi il vostro.
Guardatevi in faccia se potete. E magari sorridetevi, se ne avete il coraggio. Ricordate, gli estremi si toccano e la società del CONTROLLO, in quanto società della MALFIDENZA, sfocerà inevitabilmente nella società del CAOS.
di Francesco Oppi

DEI DELITTI E DELLE PENE
La portata rivoluzionaria del saggio di Beccaria Dei delitti e delle pene (1764) è giustificata dal fatto che questo scritto getta alcune basi fondamentali del diritto moderno. Dei delitti e delle pene nasce all’interno del clima dell’Accademia dei Pugni, su espressa indicazione di Pietro Verri, che mette ampiamente mano alla prima stesura sia correggendola sia modificandone l’assetto. L’ordinamento finale dell’opera sarà ulteriormente modificato da André Morrellet (1727-1819), in occasione della traduzione francese due anni dopo la prima pubblicazione.
L’opera, sull’onda di quei principi filosofici ed etici riscontrabili in Montesquieu e Rousseau, si sviluppa come un’articolata riflessione sulla natura e i principi della punizione inferta dalla legge a chi abbia commesso qualche reato: Beccaria tematizza quindi non sul rapporto causale tra “delitto” e “pena”, ma sulla natura filosofica e sul concetto stesso di “pena” all’interno di una società umana. Beccaria ritiene infatti che la vita associata sia rivolta al conseguimento della felicità del maggior numero di aderenti al “contratto sociale” e che le leggi siano la condizione fondante di questo patto; dati questi presupposti è evidente che le peneservano a rafforzare e garantire queste stesse leggi, ed è sulle pene e sulla loro applicazione che si concentra quindi l’opera di Beccaria. Scrive così nell’introduzione all’opera:
Le leggi, che pur sono o dovrebbon esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista: la massima felicità divisa nel maggior numero.
Le pene sono dunque finalizzate sia adimpedire al colpevole di infrangere nuovamente le leggi, sia a distogliere gli altri cittadini dal commettere colpe analoghe. Le pene vanno allora scelte proporzionatamente al delitto commesso e devono riuscire a lasciare un’impressione indelebile negli uomini senza però essere eccessivamente tormentose o inutilmente severe per chi le ha violate. Il tema si lega strettamente al decadimento della giustizia al tempo dell’autore, ancora legata all’arretrata legislazione di Giustiniano (il Corpus iuris civilis del VI secolo d.C.) e alla sua revisione per mano di Carlo V (1500-1558). La proposta riformistica di Beccaria vuole abolire abusi ed arbitri dipendenti, nell’amministrazione della giustizia, dalla ristretta mentalità aristocratica dei detentori del potere; secondo la prospettiva “illuminata” dell’autore una gestione più moderna del problema giudiziario non potrà che favorire, oltre che la tutela dei diritti individuali, anche il progresso dell’intera società (come nel caso delle osservazioni sulla segretezza dei processi o sul fatto che il sistema giudiziario presupponga la colpevolezza e non l’innocenza dell’imputato).