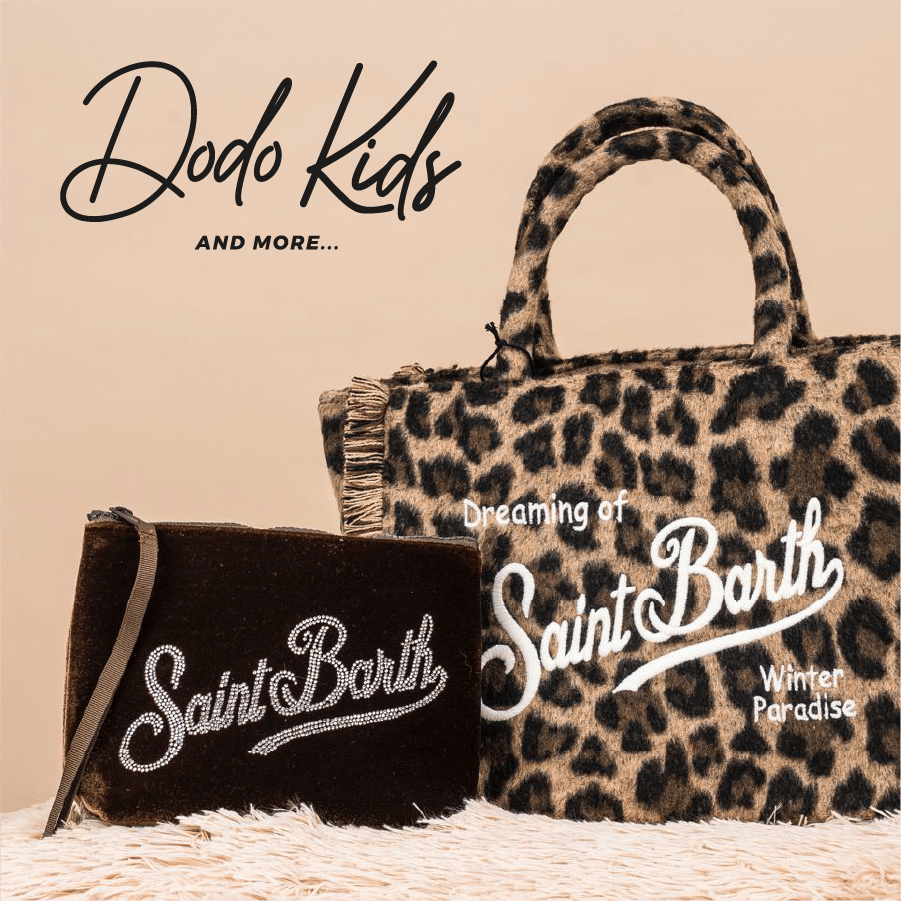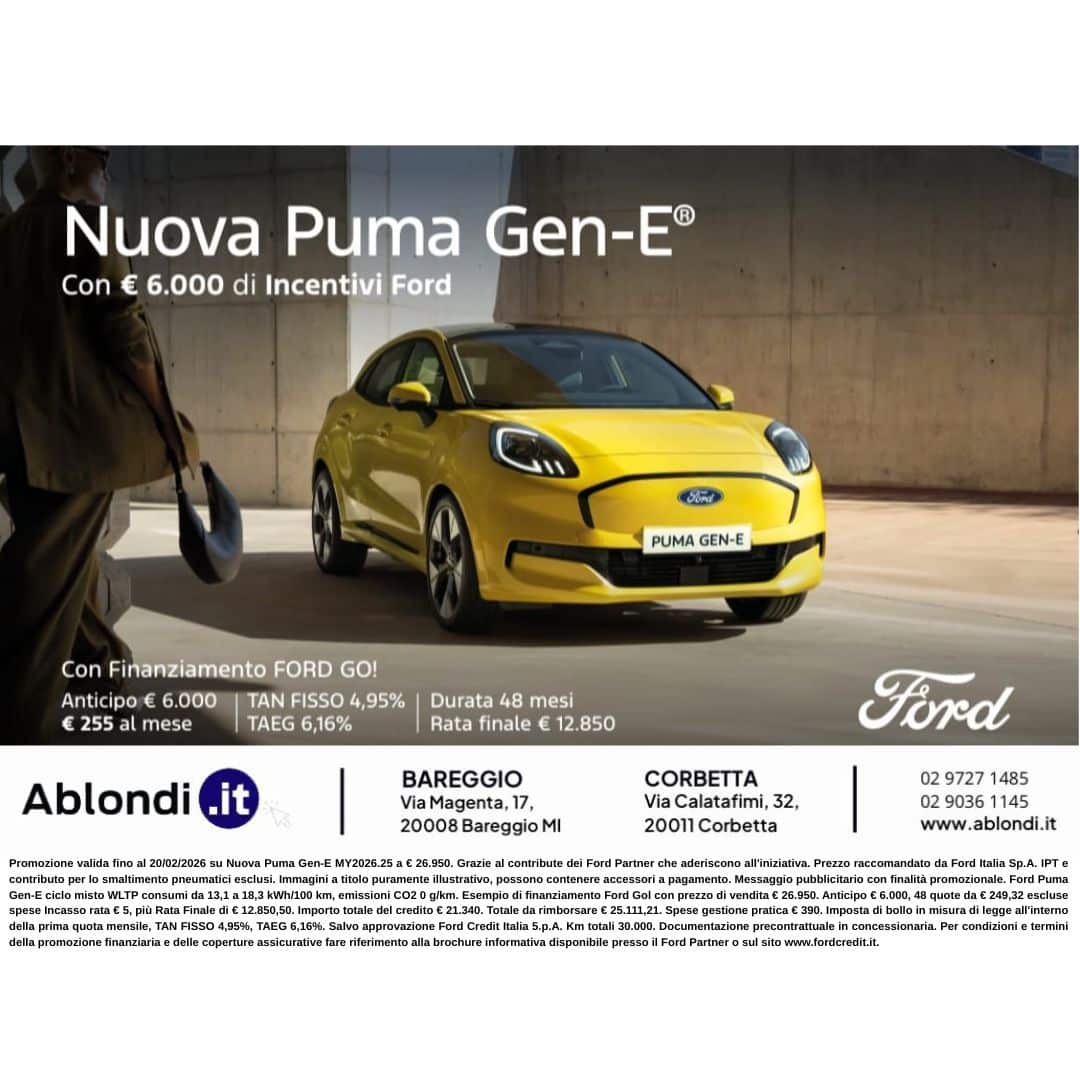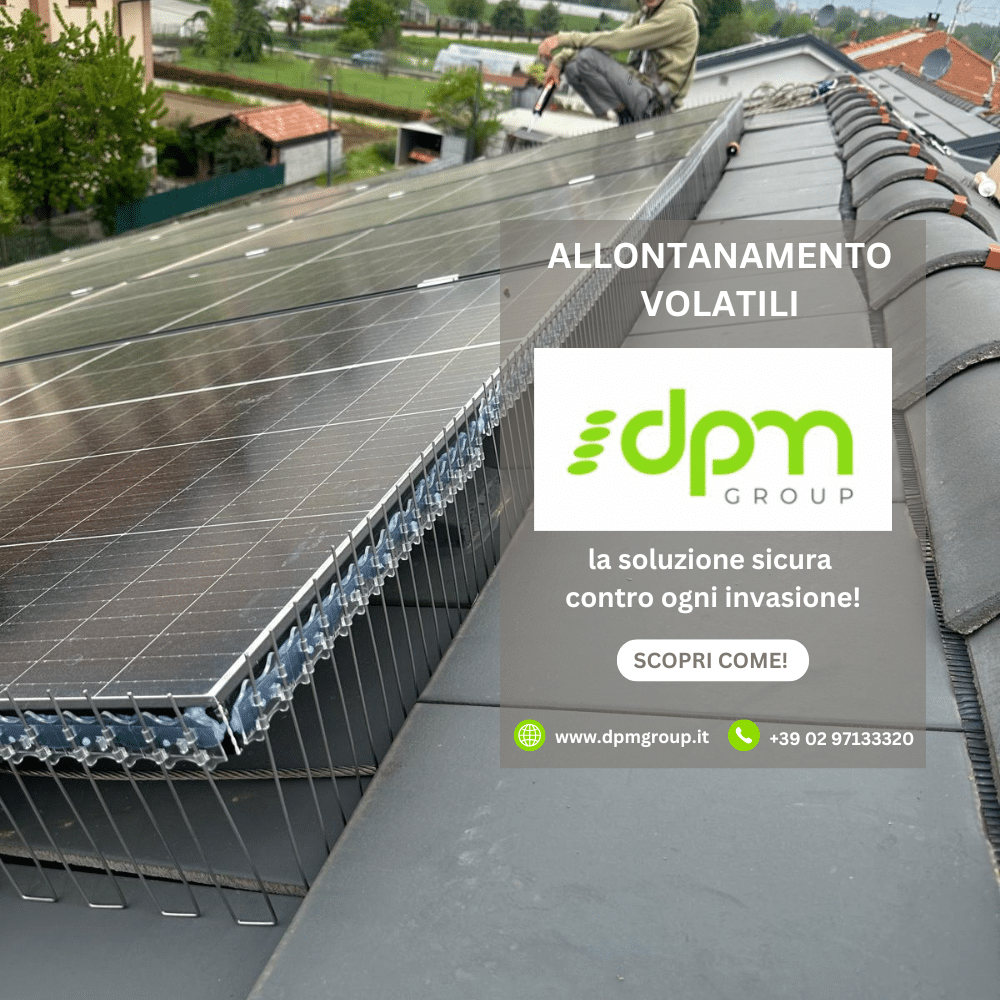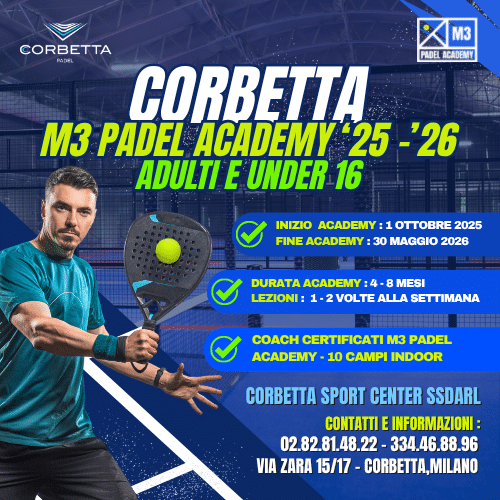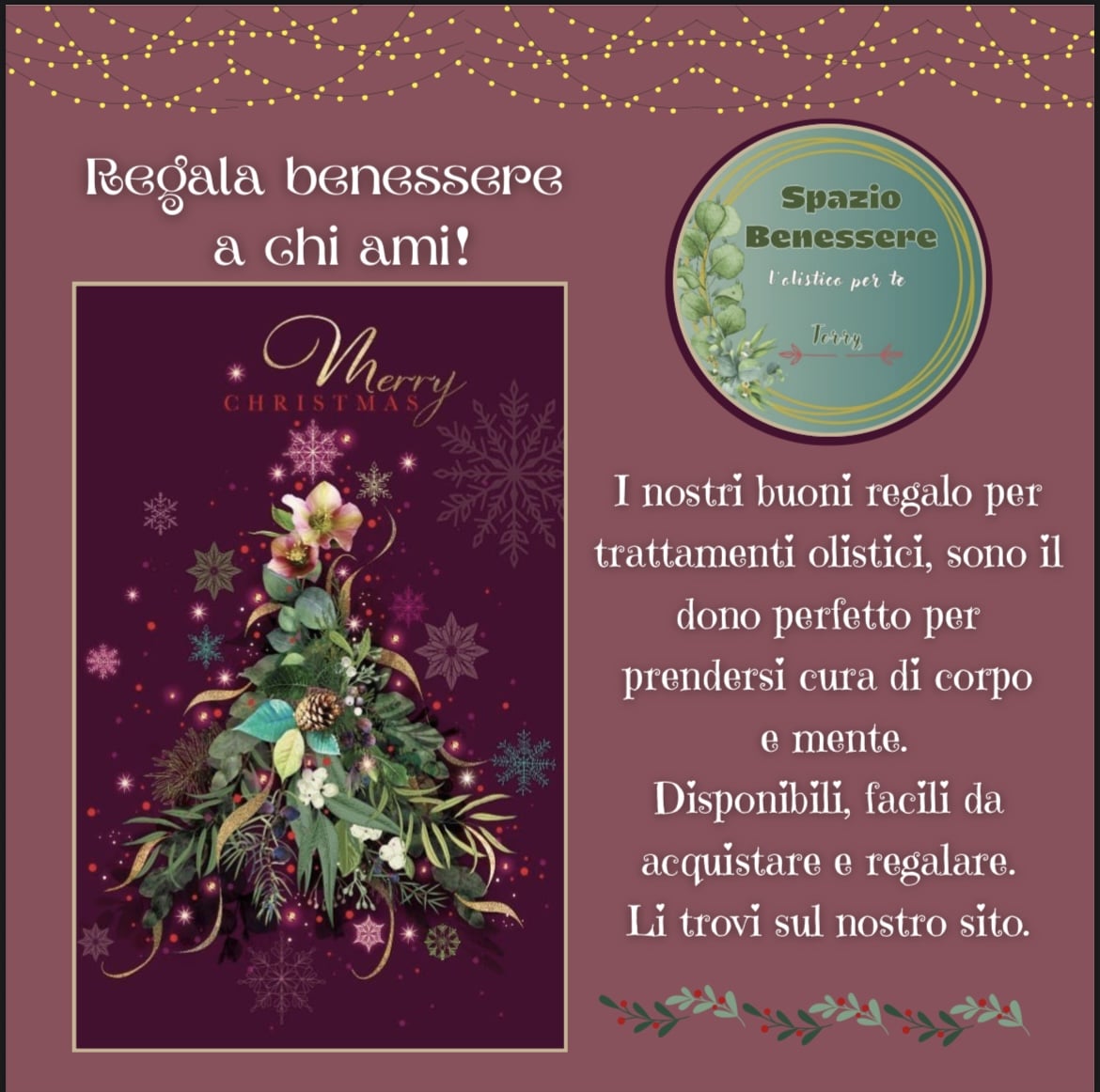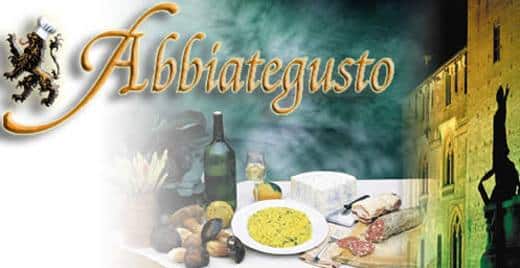De mortuis nihil nisi bonum (o De mortuis nil nisi bonum dicendum est), che tradotta significa “dei morti niente si dica se non il bene”, è una locuzione proveniente da Vita e opinioni di filosofi eminenti di Diogene Laerzio, che la attribuisce a Chilone.
La frase, originariamente in greco (τὸν τεθνηκóτα μὴ κακολογεῖν), fu tradotta in latino nel 1432 dal teologo Ambrogio Traversari. Si usa spesso in riferimento a discorsi su persone morte di recente, anche per non urtare i sentimenti delle persone vicine al defunto.
In generale va interpretata nel senso che la pietra tombale chiude tutte le polemiche e le dicerie nei confronti della persona morta. Un segno di rispetto ma anche di quella pietas tanto cara ai latini nei confronti dei defunti.
Nel caso della morte di Arcangelo Ceretti, 75 anni, già sindaco, carismatico personaggio dalla indiscussa centralità politica nella Seconda Repubblica di Bià, si può serenamente asserire che le centinaia e centinaia di messaggi di cordoglio che circolano da ieri, giorno in cui s’è diffusa la notizia della sua morte dopo mesi di malattia, siano e sono del tutto giustificati.
Al netto e al lordo degli errori e delle imperfezioni, Ceretti è stato uno dei personaggi più apprezzati nella città del Leone, che conquistò non essendone nativo (cosa tutt’altro che facile per un NON biegrassin, direbbe Luigi Balocchi). Sindaco della nascente post repubblica dei partiti, l’ascesa di Ceretti comincia molto prima del 1994, anno della vittoria elettoale: studente di Medicina a Pavia, cresce negli anni Settanta da giovane di sinistra nella stagione in cui il Pci di Berlinguer e il movimentismo della sinistra extraparlamentare (che a Bià trova terra feconda: i Mola, i Lazzaroni, gli Scotti, persino un giovane Paolo Mereghetti, futuro critico cinematografico del Corriere) contribuiscono a creare una futura classe dirigente.
Come sempre è il nostro Miglior Fabbro, Emanuele Torreggiani, a distillare in poche parole l’intima essenza dell’uomo Ceretti: “Lo conobbi. Era una persona perbene. Non solo, era capace di vedere la realtà delle cose e di trovare una soluzione mediale alle criticità”.
Il medico, lui, sceglie di dedicarsi all’uomo- l’altro da sè- nella fase terminale della vita terrena: la vecchiaia. E’ quel contatto empatico, quel legame indissolubile che riesce a creare negli anni con le persone, che cementano la leadership regnante su Abbiategrasso dal 1994 al 2002: otto anni e due consigliature, di 4 anni anziché 5 (legge d’allora)ma senza le forche caudine del Patto di Stabilità. Le giunte Ceretti stravolgono e danno una scossa alla città: oltre 50 miliardi di opere pubbliche nei suoi anni, con a fianco i pretoriani (Adolfo Lazzaroni, Nunzia Fontana, Marco Ferrario), molti di più se si considerano le decine spese per l’Annunciata inaugurata nel 2007 ma concepita molto prima.
Ceretti, Sandro Mola e Alberto Fossati furono un tridente di indiscussa levatura, prima di tutto intellettuale. La qualità abbondava anche nelle file avversarie (i Bardazzi, l’allora giovane Piero Bonasegale, la saga degli Albetti), sono passati pochi lustri ma a livello locale del circo di nani e ballerine di formichiana memoria sono rimasti soltanto i nani. Ceretti fu l’unico sindaco capace di bissare la vittoria dal 1994 a oggi, assieme a Cesare Nai. Ma l’impronta lasciata fu profonda.
Abbiategrasso passa da 24 a 32mila abitanti, si costruisce parecchio e gli oneri di urbanizzazione entrano copiosi nelle casse del Comune (anche 8, 10 milioni l’anno), le periferie crescono e non sempre nel segno della Bellezza architettonica, ma è successo quasi ovunque.
Di certo l’uomo che veniva dalla stagione del Pci voleva e riesce a dare un’impronta, una visione, un pensiero.
Vivere la Nebbia e la cultura sono le armi con le quali, gramscianamente, la sinistra abbiatense conquista prima le casematte del potere culturale, poi le urne. Una lezione (la contesa delle parole e delle idee) che il mio centrodestra dopo decenni fa ancora fatica a introiettare. Leggasi l’elogio di Gramsci a firma di Alessandri Giuli in un recente saggio.
Due i colpi di genio della stagione Ceretti, il cui vero uomo d’azione, collegamento tra pensiero e azione, sodale e pretoriano, fu Adolfo Lazzaroni: la Fondazione Abbiatense ed Abbiategusto. Con la prima, autentico coup de theatre frutto anche della cerettiana capacità di farsi apprezzare a destra e altrove (Ombretta Colli in Gaber che da presidente della Provincia di Milano viene in piazza Castello ed elogia Abbiategrasso, ‘città più bella della Provincia’; il rapporto con Milena Bertani, già assessore regionale e presidente del Parco Ticino), realizza un autentico braccio armato del Comune, poi seppellito dai gangli mostruosi della burocrazia e dalla incapacità, forse, di farla prosperare. Eppure Ceretti fu capace di feconda interlocuzione con la Lombardia di Formigoni, che fa affluire decine di milioni di euro per Annunciata e Palazzo Stampa. Si infrange il sogno dell’università ma nasce Abbiategusto, geniale trasposizione del diritto al piacere e al godimento individuale di marxiana memoria, che i già compagni Ceretti e Lazzaroni portano ad Abbiategrasso nei primi anni 2000, mettendo in pratica quello che Marcello Dell’Utri spiega a Leonardo Notte nella splendida serie 1992 (‘Notte, le vostre idee le abbiamo realizzate noi, io e Berlusconi, con le televisioni’).
Con Abbiategusto (quello vero, non quello di oggi: altri tempi, altri uomini, anche altri budget ma soprattutto altro pensiero), Ceretti,e poi Fossati Albetti Arrara e Nai, senza mai spezzarne la continuità (prova di saggezza), tramutano Abbiategrasso in una sorta di comune hippie del gusto, con gente da ogni dove, d’Italia e del mondo, e i grandi Ezio e Renata Santin che portano ad Abbiategrasso il gotha della cucina italiana. Nel 2008 arriva un quasi sconosciuto Enrico Bartolini, oggi assiso sul trono di 14 stelle Michelin.
Ceretti e Lazzaroni si godono lo spettacolo, ebbri di gioia per aver realizzato le rivoluzionarie ed aitanti speranze giovanili. La rottura del 2007, personale prima che politica e interna al centrosinistra, è consequentia naturalis rerum della permanenza (con l’avvento di Alberto Fossati, mente sopraffina ma cattolico democratico alieno al movimentismo extra parlamentare che era brodo di coltura dei suoi contendenti interni) di due anime diverse e di spiccata personalità: i cerettiani e i fossatiani. Differenti per etica ed estetica. Il 20% del Cantiere nel 2007 spiana la strada a Roberto Albetti ed al centrodestra, ma soprattutto spezza oltre dieci anni di unità a sinistra, di pas d’ennemi a gauche, che scava un solco profondo, tanto che nella ricongiunta pacifica parentesi Arrara appare chiaro che qualcosa si è rotto per sempre.
Arcangelo Ceretti fu uomo capace di dialogo con l’avversario. Imberbe cronista tra gli ultimi arrivati, e meno influente di tutti, molte lune fa il Medico, che conosce l’Uomo, stabilisce col giornalista più schierato a destra nella storia dell’Est Ticino una simpatica entente cordiale. Mi ha sempre dato del lei, benché gli fossi molto inferiore di età e lignaggio, e sapeva toccare le corde giuste anche in modo estremamente ironico (‘Provera, nel suo essere così di destra lei non si è ancora accorto della signorina XXXXXXXXX, che ha un bellissimo culo..Stia più attento’), ma è anche colui il quale a cavallo tra la sua seconda Amministrazione e quella Fossati inventa il servizio di Comunicazione Istituzionale affidandolo alla bravura di Roberta Nencini, che di fatto lo crea da zero.
Uomo schiettamente di sinistra, laico e di parte, di radicate convinzioni, Arcangelo Ceretti era un Uomo attento e aperto a chi la pensava in modo diametralmente opposto: abbiamo testimonianza diretta del momento in cui un esponente isituzionale di primo piano proveniente dalla storia del Msi, e arrivato in Parlamento, ebbe la necessità di un intervento medico professionale dell’ex sindaco per ragioni strettamente familiari: Ceretti (ormai in congedo dalla politica) espletò e al meglio tutto quanto occorse, senza chiedere per sè nulla, benché si trattasse di una prestazione avente un costo ben maggiore di una semplice visita. L’uomo era così.
La Fondazione Golgi, la ricerca sull’Alzheimer (sfida del Millennio, per la scienza medica e il mondo della ricerca), sono forse il lascito più importante che Arcangelo Ceretti idealmente consegna alla città che lo accolse, lo issò a sindaco e gli volle sempre un gran bene. Più che una sterile titolazione di aule o sale, la politica e la società civile cerchi, e trovi, una via per dedicargli qualcosa di più grande.
Sarebbe il modo migliore per tributare il giusto, dovuto omaggio a un politico che (prendo a nolo le parole coniate da Alberto Fossati, suo successore con cui la rotta di collisione fu fragorosa, ma molto era quello che li univa) ha cercato di fare di Abbiategrasso ‘una città di provincia che non fosse provinciale’. Dacché il provincialismo era, rimane e temiamo rimarrà la zavorra più pesante di Abbiategrasso, ubertosa e seduta su una copiosa ricchezza che col tempo sta venendo meno, col rischio di impedire una Visione, un Pensiero, capace di guardare oltre. Visione e Pensiero: le parole, i mantra, del cerettismo.
Che Dio Padre Onnipotente, Dottore, possa illuminare la sua mente e la sua generosità di laico, ma che nell’intimo del cuore e dell’intelligenza feconda non può che avvertire che il Mistero della morte apre ad un qualcosa di Altro. Se per caso fosse interrogato da Qualcuno di importante, chieda Lui e Loro perdono per me, che quel culo l’ho guardato e rimirato. Aveva ragione Lei, del resto.. Lei era un Uomo capace di capire, e cogliere, la specificità, la grandezza, la debolezza e le miserie degli altri uomini. E di non giudicarle, che è la più grande delle lezioni. Riposi in pace.
Fabrizio Provera
ps la bellissima foto in bianco e nero viene dallo sterminato archivio di Gian Passoni
Insomma, i Ceretti boys sognarono forse una rivoluzione mai davvero compiuta: ma col Processo al Gorgonzola nel castello Visconteo, la presentazione dei libri sulla storia di Carlin Petrini e Slow Food, con le cene all’Annunciata che qualche zotico miope non voleva (la prima con Roberto Albetti), quanto meno quella a tavola (e dintorni) l’hanno davvero realizzata nei minimi dettagli. Rivoluzione del gusto, diritto al piacere: battaglie vinte.