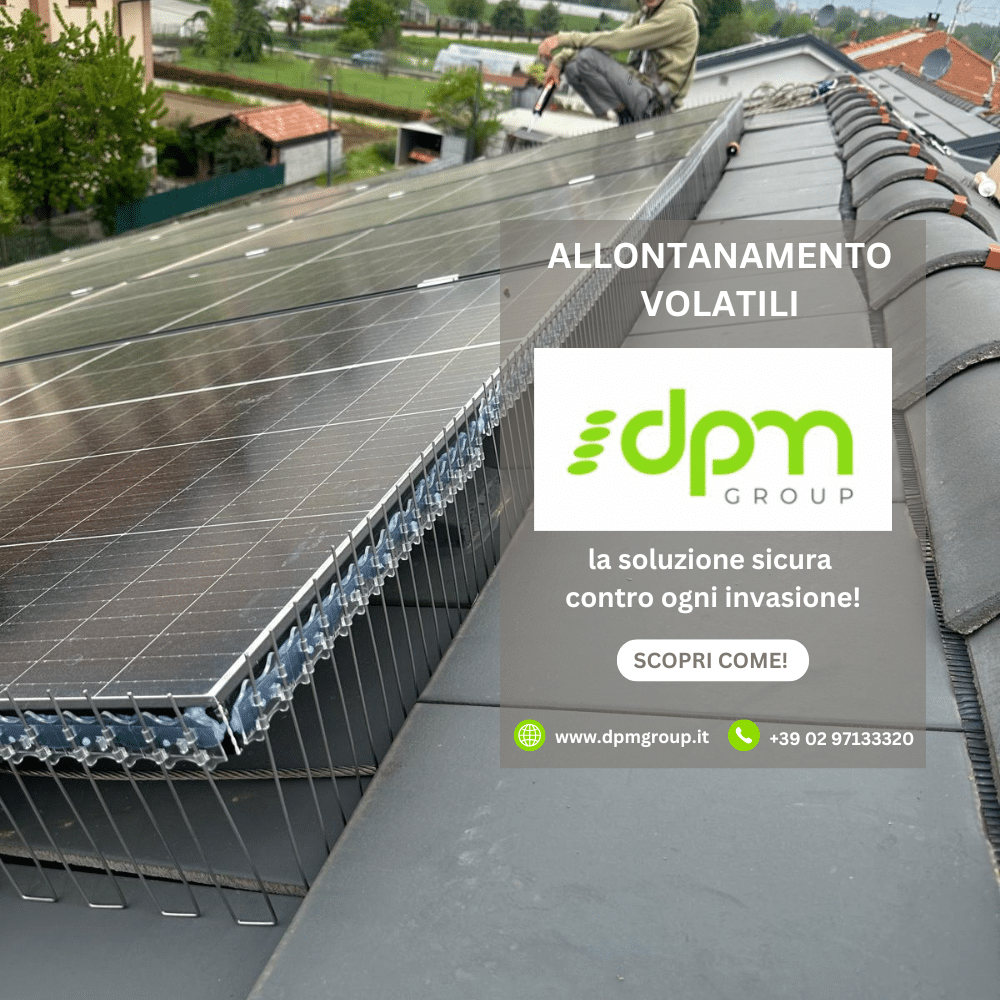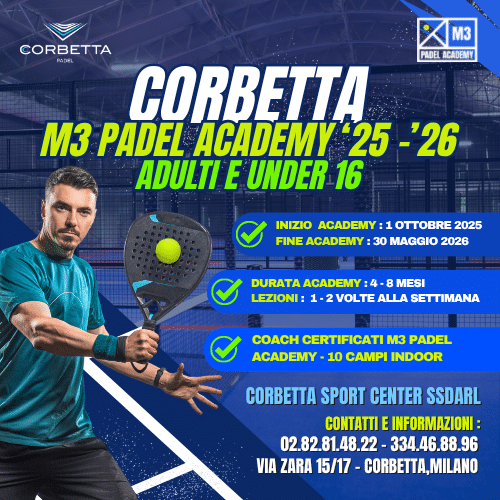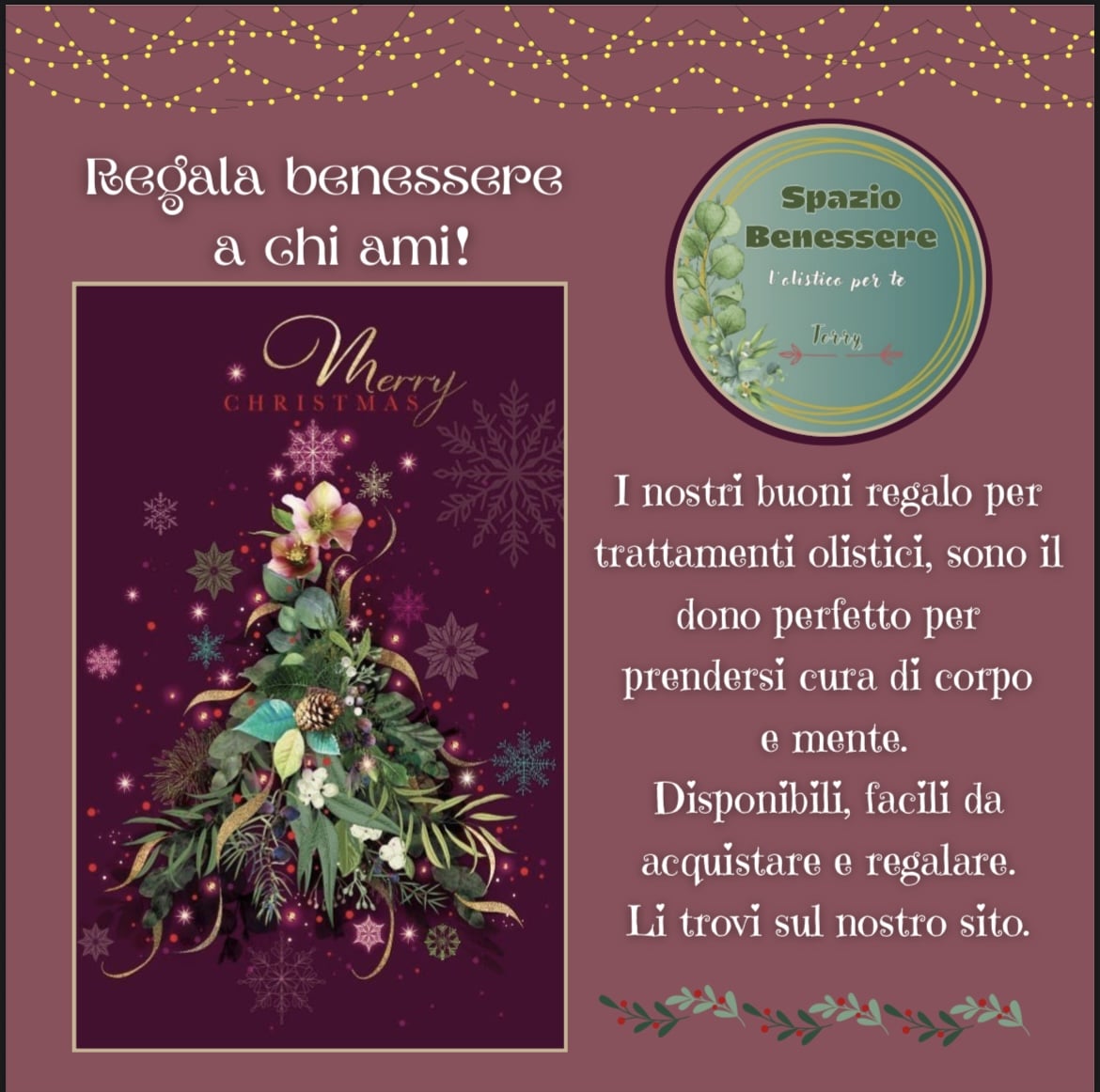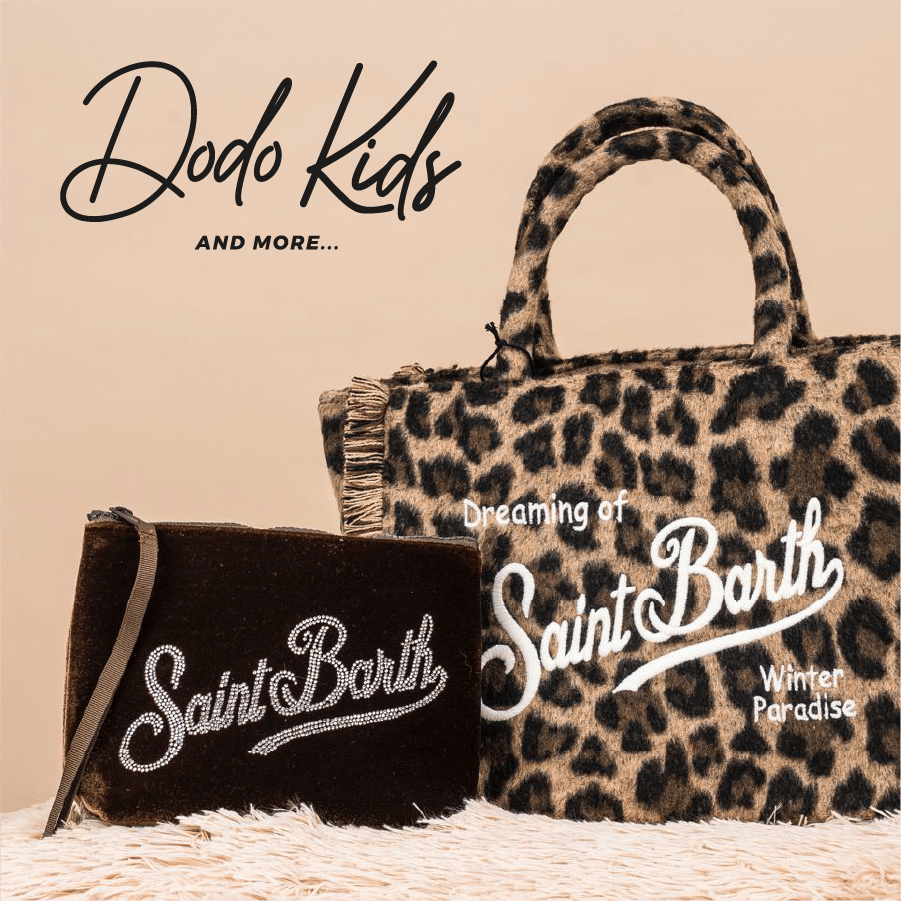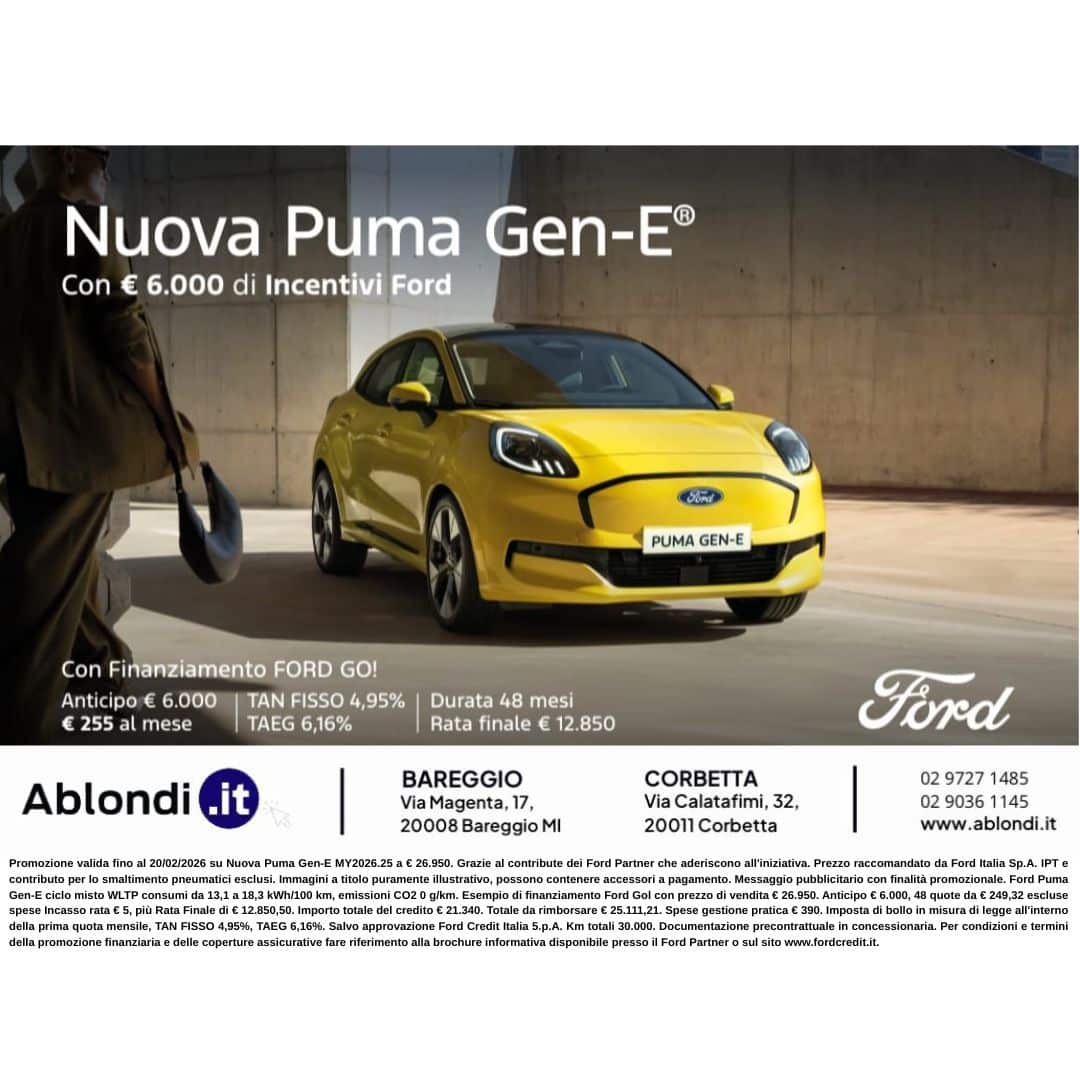Il concerto di sabato 1 marzo nella stagione di Classica musicale di Magenta.
Scintillante l’esecuzione al pianoforte di Andrea Molteni, vibrante la direzione di Ernesto Colombo.
Siamo nel cuore della stagione musicale in corso al Teatro Lirico di Magenta. Una stagione, questa 2024/2025, partita davvero “Mahler” con l’impegnativa quanto sublime Sinfonia n 9 in Re maggiore; sbarcata poi per una sosta, come in qualcheduna delle “ville di delizia” che caratterizzano il nostro territorio sul Naviglio Grande, con gli “Archetti virtuosi”; ed eccoci al primo di marzo con una immersione sonora nella “barriera corallina” delle composizioni del grande autore amburghese.
La stagione è dedicata alla riflessione sul “tempo”, come sappiamo. Il tempo dell’essere umano, il tempo del cosmo, il tempo della storia della nostra gloriosa musica classica, i tempi delle partiture. Il tempo come un mare musicale tutto da esplorare e da cui cogliere meraviglie.
In fondo, volendo semplificare, Johannes Brahms non fa che questo. Compositore tardo romantico, coevo di autori che già trasformano il materiale sonoro classico (basti pensare a Wagner), l’amburghese riesce con mirabile arte ad intessere la struttura classica con trame innovative, accenti espressivi liberi in un ordito tradizionale sempre molto delineato.
Spazio ai soli degli strumenti delle sezioni orchestrali (i legni, i timpani, gli archi) i quali si propongono sia come voci a levarsi qua e là nel dipanarsi delle partiture d’insieme sia come voci introduttive dei temi (in genere due) che l’orchestra andrà a sviluppare.
Il tutto nella proposta di due differenti composizioni. La serata si apre infatti con il Concerto n. 2 (1881) per pianoforte ed orchestra op. 83. Un concerto di intensità e ricchezza straordinarie; potente negli accenti, pieno di grazia nei momenti sospesi di lirismo.
Una struttura mobile, varia, ricca e, vorremmo suggerire, autocosciente. Quattro tempi (anziché i tre canonici) per dar vita ad Allegri (appassionati o graziosi), all’Andante di rara bellezza; intensità, ritmica, originalità. Assoli di corno, violoncello e, certamente, il pianoforte.
Riconosciuto come una delle opere più impegnative di tutti i tempi per il pianoforte solista, questo concerto possiede un tale spessore da sembrare già esso una sinfonia, come rilevano gli studiosi.
Brahms mantiene la libertà espressiva delle sezioni orchestrali in una sorta di duetti con il pianoforte, di richiami e di risposte. Il compositore dimostra di saper innovare e coinvolgere pur nella forma virtuosistica e classica che non intende disconoscere ma irrorare di nuova linfa espressiva.
Il pubblico del Teatro Lirico di Magenta ha la fortuna di poter ascoltare esecuzioni mirabili e giovani musicisti tra i migliori e richiesti a livello internazionale. Andrea Molteni è certamente tra questi e lo ha dimostrato a suon di note in questo travolgente e felice concerto brahmsiano. Movimento, tensione e luminosità, le mani del pianista fanno sembrare facile qualunque intreccio virtuosistico; “facile” nel senso di brillante, scorrevole, accattivante, ricco di espressione.
Lo stesso vale per l’insieme delle orchestre.
L’autore di Amburgo pare abbia “riflettuto” per oltre venti anni prima di pubblicare questa composizione. Il peso dei grandi prima di lui, l’Olimpo della composizione sinfonica “classica” e romantica (Mozart, Beethoven): come porsi di fronte alla perfezione ed alla maestosità ?
Alla fine questa prima sinfonia (1876) “sbanca” nella storia della musica, andando a raccogliere e reinterpretare proprio quelle caratteristiche senza tempo (al punto che venne chiamata “la decima di Beethoven”, definizione in verità fuorviante).
Classici quattro movimenti, anche in questo caso (come nel concerto per pianoforte) con qualche variazione (“licenza d’autore”) nei contenuti di ciascuno. Variazioni e citazioni : a nessuno sarà sfuggito l’incipit della imponente “Quinta” beethoveniana proposto sin in apertura da timpani ed archi. Non male per “uno” (Brahms) che non si azzardava a confrontarsi con quei “fratelli maggiori” ! Citazione, omaggio, dichiarazione stilistica e tematica di appartenenza.
Ritmi appassionati, accenti drammatici, energici ed epici sempre modulati da momenti di lirismo virtuoso e mai pedante.
La meraviglia dei soli, in particolare nel secondo movimento con l’andante introdotto dalla soavità dell’oboe (a qualcuno piace l’oboe!), del duetto di clarino e violino solisti.
Ecco come si innova rimanendo nel solco di chi ha forgiato e reso sublime la forma sinfonica.
Non possiamo qui descrivere nei dettagli i movimenti, invitiamo all’ascolto.
Possiamo solo ribadire quanto l’opportunità che la Città di Magenta e l’associazione Totem offrono al pubblico del Teatro Lirico di godere di tanta bellezza e nel contempo conoscere la musica classica (in quanto classica… sempre giovane!) è da cogliere ad occhi chiusi (ed orecchie aperte).
Un pensiero al maestro Lorenzo Passerini il quale, pur impossibilitato a dirigere il concerto, ha voluto presenziare, salutare ed illustrare il cartellone. Da parte sua saluti alle orchestre, al pubblico ed il ringraziamento al maestro Ernesto Colombo co-direttore della Orchestra Vivaldi, per aver accettato l’onere della sostituzione. Un onere risolto brillantemente. Al maestro Passerini ed alla di lui famiglia l’affetto e l’augurio per un felice superamento del momento difficile. Lo aspettiamo sempre sul podio del Teatro Lirico.
La stagione intanto corre e settimana prossima, venerdì 14 marzo, ospiteremo l’Orchestra del Conservatorio “Cantelli” di Novara diretta dal maestro Nicola Paszkowski.
Mentre sabato 12 aprile, chiusura con “Bach & Bruckner” , di nuovo con il maestro Colombo e “le nostre” due orchestre Città di Magenta e Vivaldi.
Eh sì… il tempo scorre, scandisce, sospende, porta lontano ma a volte ritorna. Poi, sarà di nuovo Pasqua.
Alessandra Branca
Foto Luciano Milan- Ph per Totem Magenta