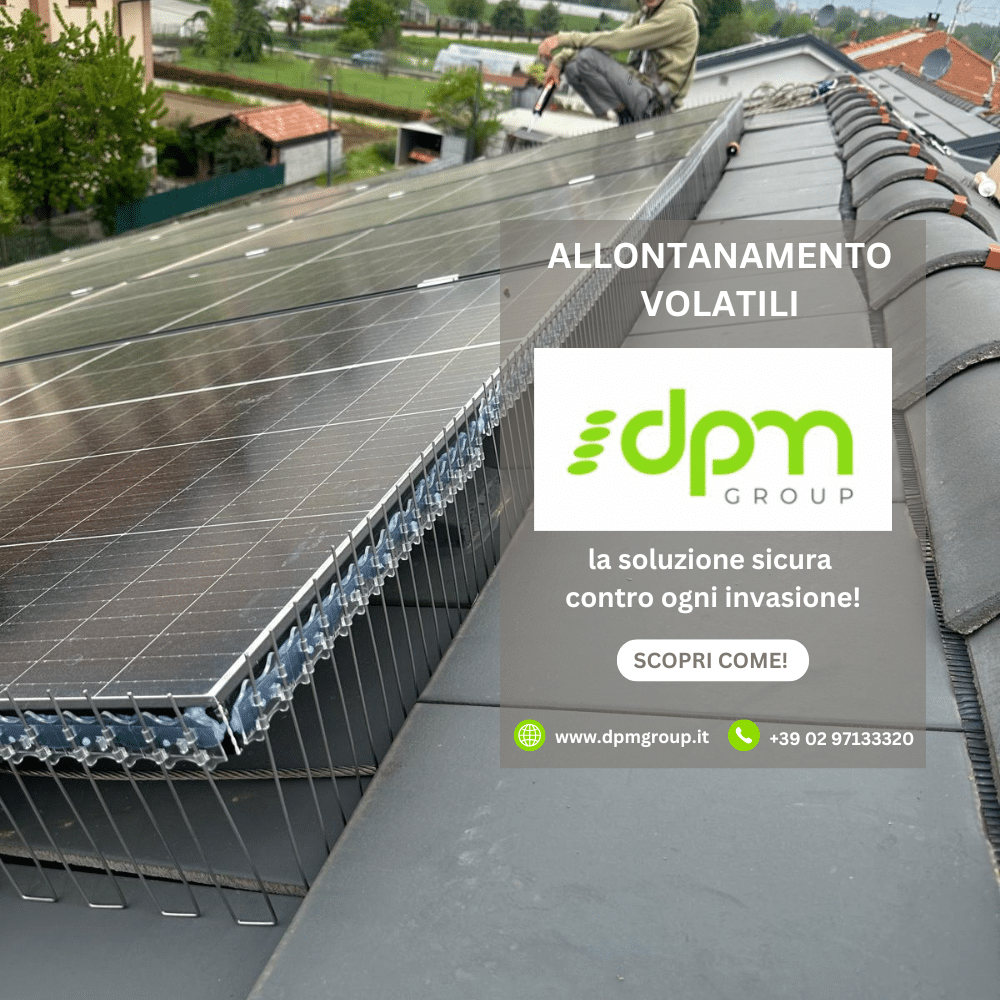I Championships in gonnella parlano ceco nel segno della tradizione di una scuola che, passano le generazioni, non finisce mai di sfornare talenti. Barbora Krejcikova, classe 1995 da Brno, ha quindi avuto la meglio di una combattiva Jasmine Paolini, che paga ad un carissimo prezzo quel doppio fallo sciagurato con il quale ha ceduto il break, poi decisivo, nel settimo gioco del terzo set e, ancor di più, l’aver giocato con troppa circospezione l’ultimo game dell’incontro, con l’avversaria comprensibilmente attanagliata dalla pressione e, pertanto, in vena di concederle chance di raddrizzare la baracca in zona Cesarini. Un paio di punti male interpretati che gridano vendetta, insomma. Peccato, ma pur sempre il migliore risultato della storia di Wimbledon per un’azzurra.
Tornando a Barbora, la neo campionessa Slam, oltre che di un bellissimo tennis è depositaria di una storia che per gli appassionati di vecchia data non può certo passare sottotraccia. Ad allenarla, quando ancora non era la giocatrice di oggi ma poco più di un prospetto grezzo da trasformare in campionessa, fu una delle tenniste dal gioco più gentile e romantico che si ricordi a memoria d’uomo. Un angelo che troppo presto ci ha lasciati: Jana Novotna. Un cerchio meraviglioso oggi si chiude. Sul campo che Jana seppe trasformare in uno spaccato di paradiso del tennis, a sollevare lo stesso trofeo è, quindi, la sua ultima intuizione. Lo sport regala sempre pagine che non possono lasciare indifferenti.
Sono già passati sette anni da quel 19 novembre che, per i suoi tanti estimatori, non è che il triste ricordo della morte di Jana. Non aveva compiuto nemmeno mezzo secolo di vita quando un male, che con la rassegnazione del caso siamo soliti chiamare incurabile, se l’è portata via. Un male bastardo e pure democratico nel trattare tutti in eguale maniera, artisti compresi; uomini e donne un po’ speciali, proprio come lei, che non fanno eccezione. La cui profusione della bellezza senza soluzione di continuità, se proprio il mondo non l’ha salvato come ebbe modo di intendere Dostoevskij, l’ha reso un posto più degno d’essere vissuto. Nata anch’essa a Brno, ma nella Cecoslovacchia che purtroppo non c’è più, Jana di professione ha fatto la tennista ma tanta era la quantità di talento che le passava per le mani che siamo certi avrebbe potuto primeggiare in qualunque manifestazione d’arte avesse deciso di fare propria. La danza classica, per esempio, lei che di bianco vestita disegnava sul ground di Wimbledon, il tempio laico dello sport che è evoluzione della pallacorda e che spesso dimentica di esserlo, le linee di una ballerina del Bolshoi. Oppure la pittura, ambito nel quale ci piace immaginarla esponente della corrente degli impressionisti, seduta al tavolino del Café Guerbois di Parigi che ‘en plain air’, come si diceva allora di chi creava a contatto con il cielo, sapeva trasformare tubetti colorati in capolavori senza tempo. E, ancora, il canto. Quello, insieme malinconico e felice, di Aretha Franklin, la regina del soul.
Anima, appunto. Perché Jana fu guidata da un’anima probabilmente troppo gentile per un mondo via via più cattivo.
Fortunatamente, per i fruitori di una certa idea di tennis, Jana ha scelto di dedicare il suo tempo al nostro ecosistema preferito e, noi che per anagrafica siamo transitati dall’adolescenza all’età adulta sfiorando McEnroe, l’imperitura stella polare se si scomoda la bellezza, per poi attraversare le parabole luminescenti di Edberg e Sampras fino a farci rapire in via definitiva da Federer, nella nota esperienza religiosa teorizzata dal compianto David Foster Wallace, le dobbiamo davvero tanto e ne saremo per sempre debitori. E chi se ne importa se il suo palmares fu ricco ma non ricchissimo come doti tecniche da prima della classe, forse senza eguali nella secolare storia del gioco, avrebbero potuto garantire. Perché, a certi livelli di grazia, il ‘come’ soppianta senza appello il ‘quanto’ e l’universo tennis è questo un distinguo concettuale che riesce ancora a fare. Se vincere è l’unica cosa che conta, ma solo nell’immediato, raccontare storie affascinanti che per protagoniste hanno la racchetta e i misteri di una disciplina tanto complessa, invece, è per sempre come solo i diamanti.
Esponente, come detto, di una scuola capace di regalare giocatrici accomunati dalla gestualità pulita, quella che dà del tu alla pallina secondo i crismi impressi nei manuali teorici della disciplina, con la sua forma interpretativa riconoscibile tra mille altre ha rappresentato il doloroso canto del cigno di una categoria di atlete inesorabilmente destinate all’estinzione, perché, da lì a poco, soppiantate dalle cyborg del famigerato corri tanto e tira forte di concezione bollettieriana. Evenienza nefasta, almeno a parere di chi scrive, resa possibile dagli attrezzi moderni letali alla stregua di un bazooka che è alla portata di tutti, all’omologazione con annesso rallentamento delle superfici di gioco e da una scientificità tutta nuova nella preparazione del corpo sempre più asintotico alla macchina e i suoi traguardi alla scienza esatta. La glaciazione dello sport, per genesi, archetipo di eleganza che fu prerogativa di Suzanne Lenglen e poi di Martina Navratilova e delle rare mosche bianche che hanno provato a darle coraggiosamente un seguito.
Docente di spicco dell’università del serve-and-volley, Jana – il Pat Rafter in gonnella, per ovvie ragioni attitudinali, nonché guerriera fragile di romantiche battaglie donchisciottesche e strappalacrime – ha corso il rischio di non vincere mai quel benedetto torneo di Wimbledon che sembrava ogni volta potesse essere suo, prima di finire inesorabilmente ad impreziosire la bacheca delle altre. I Championships, gergo che descrive senza ambiguità l’obiettivo di ciascun bambino che per la prima volta nella vita imbraccia una racchetta, un candido vestito che, sebbene fosse sempre cucito su misura per lei dal miglior sarto londinese, trovava ogni volta il modo di farle difetto. Una spiegazzatura qua, un filo tirato là e, così, appuntamento con la leggenda rimandato a chissà quando. Colpa, lo si dice per amor di verità, più di sé stessa e dei fantasmi che ne deturpavano mente e spirito che del dritto atomico di Steffi Graf o del senso euclideo di Martina Hingis; donne senz’altro più scaltre di lei nel capitalizzare le doti elargite dalla benevolenza di Madre Natura.
Lacrime, quindi. Tante, quelle versate da Jana, cristallo fragile di un contesto spesso crudele, sulla spalla della duchessa di Kent al termine dell’ennesima apparizione sublime ma senza lieto fine in Church Road. Tante, quelle che noi aficionados pregni di nostalgia abbiamo soffocato implorando gli dèi del gioco affinché le concedessero un’altra possibilità. Una ancora, per il solo privilegio di vederla finalmente sorridere. Finimmo per essere ascoltati, a riprova, o almeno è quello che ci piace pensare, che la bellezza sia virtù non circoscrivibile al solo Pianeta Terra e che, appunto, sappia pizzicare corde ultraterrene. Oltre ad essere un concetto, forse l’unico, scevro dalle inviolabili leggi del tempo. E così, il suo primo cerchio, con il destino al eletto a giudice supremo, si chiuse in un pomeriggio d’estate dell’anno 1998, quando Jana, ormai trentenne ed avviata a diventare la più grande giocatrice di sempre a non aver mai vinto una prova del Grande Slam, al terzo tentativo sul campo centrale più famoso del tennis, iscrisse il nome sull’albo dell’immortalità sportiva e, in maniera più tangibile, sulla targa del circolo più iconico al mondo.
Altre lacrime, quali leitmotiv di un’esistenza terribilmente breve, ma di gioia, per una volta. Con la sensazione epidermica che lo sport, qualora dotato di pensiero proprio, mai avrebbe potuto sopportare una simile lacuna, più a tutela di sé e della propria reputazione che a scoprirsi riconoscente anche quando dovrebbe. Insomma, quello fu davvero un giorno indimenticabile.
Nessuno muore in Terra finché vive nel cuore di chi resta, recita l’adagio di un autore rimasto volutamente anonimo. Jana, l’ultima carezza prima dei mortai, comunque non corre questo rischio. Voltaire si sbagliava dicendo che non è dato sapere dove incontrare gli angeli, se nell’aria, nel vuoto o nei pianeti, e solo perché Dio non vuole riconoscere all’uomo questa possibilità. Infatti, un angelo dal cuore grande e la sensibilità straripante è passato proprio di qua, sul microcosmo tennistico, e lo abbiamo riconosciuto senza esitazioni. Un amore a prima vista, il nostro, giusto il tempo di una volée di rovescio e ci siamo sentiti parte di una narrazione bellissima. Un racconto che la meritevole Barbora Krejcikova, pur nel dispiacere per la sconfitta della piccola grande Jasmine, oggi ci ha consentito di rispolverare e non poteva farci regalo più gradito.
A Jana, ovunque si trovi.