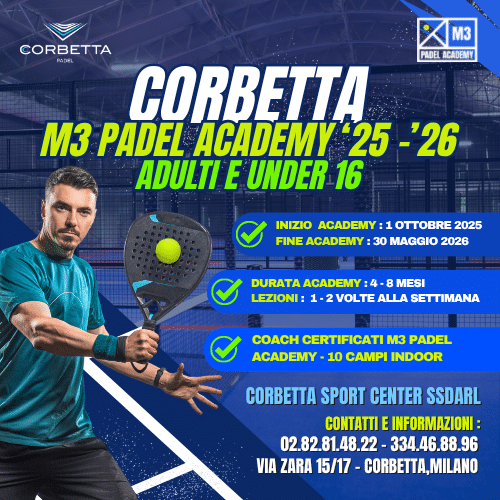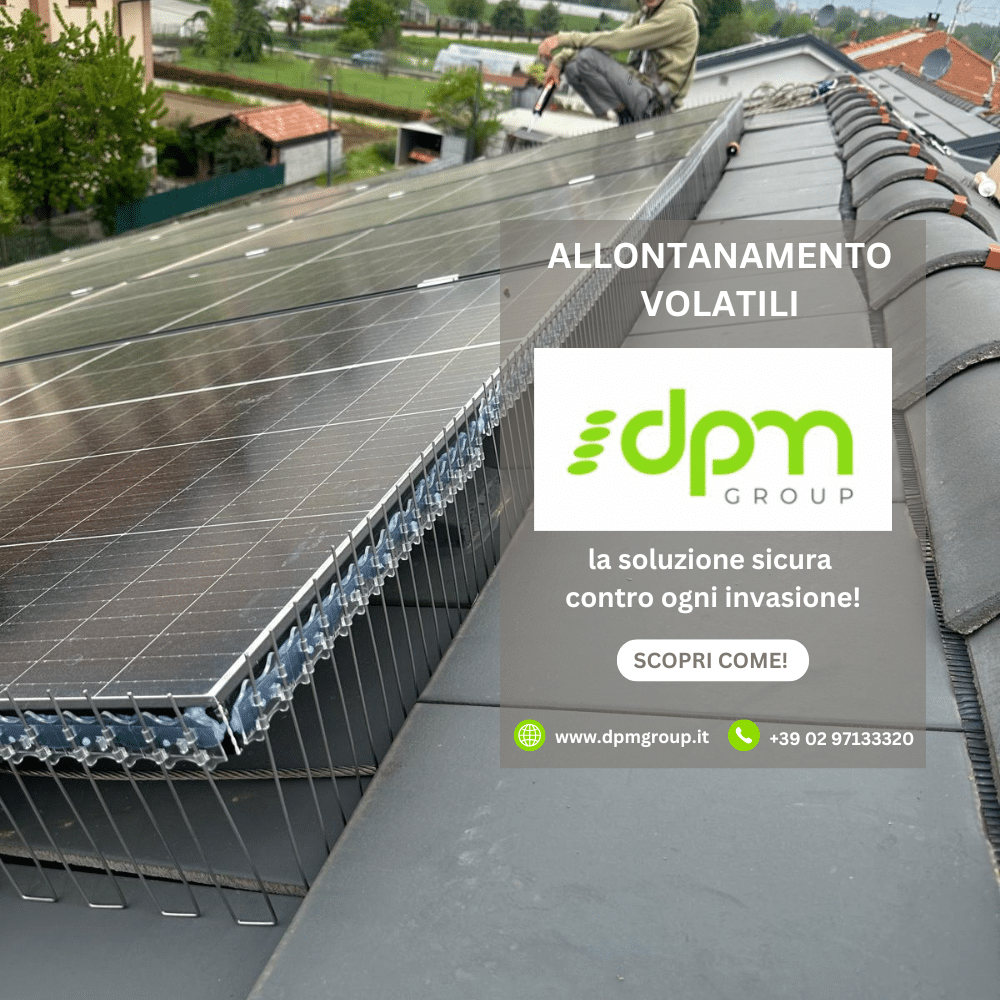Questa domenica, l’Italia farà visita all’Irlanda e, trattandosi di rugby, la notizia non è certo delle migliori. O meglio, sfidare i più bravi al mondo è sempre un accadimento meraviglioso ma il rischio di prendere un’imbarcata solenne è incombente. Come questa squadra di marziani non abbia vinto l’ultimo mondiale è un mistero spiegabile solo dalla maledizione che, puntuale come le tasse, ogni quattro anni si abbatte sui verdi nell’occasione più importante, frantumando le legittime ambizioni di gloria di un popolo intero che si nutre di mete e placcaggi. Una delle tante e strane storie che lo sport è in grado di raccontare. Disfatta a parte, perché di quello di è trattato, in questo momento storico nessuno gioca bene a rugby quanto loro e la rullata inferta alla Francia all’esordio del Sei Nazioni, per giunta a domicilio, vale più di troppi discorsi.
Insomma, nel weekend ci tocca alzare il culo dal campo base e prendere di petto l’Everest. Ad essere pignoli, sarebbe stato molto più funzionale al nostro piano di crescita procrastinare la sfida per provare a dare un seguito, contro un avversario meno terribile, alla buonissima prova disputata contro gli inglesi lo scorso sabato. Ma il calendario non si tocca e, pertanto, l’obiettivo è quello di non fare troppo male al nostro morale in previsione del proseguo del torneo e, al contempo, di dimostrare, per quanto ci sarà consentito dalla presenza di fenomeni che non regaleranno nulla, di essere una squadra dalle giuste credenziali per il contesto.
Nell’attesa che il nostro allenatore metta a punto il quindici titolare e la composizione della panchina, si spera di pote contare sul rientro di Capuozzo e di ben supplire al forfait di una garanzia come Negri, il pensiero va ad un irlandese che purtroppo domenica non ci sarà: Jonathan Jeremiah Sexton, detto Johnny. Niente di grave, intendiamoci, ha semplicemente detto basta, la sua carriera si è chiusa per comprensibili questioni anagrafiche. Orgoglio di un popolo intero che respira rugby in ogni angolo di strada e mediano d’apertura come se ne sono visti pochi nella storia secolare della disciplina, Sexton, ormai quasi quarantenne, ha infatti appeso gli scarpini al chiodo proprio alla conclusione dell’ultimo mondiale.
Una lunga carriera, la sua, da tremila punti a referto di cui un migliaio in nazionale e di vittorie a ripetizione. In una squadra che più competitiva non si può come quella irlandese, è stato titolare inamovibile dal 2009 fino al match di commiato tanto da far dire ad un giornalista dell’Equipe che essere un mediano d’apertura in Irlanda, anche bravo, è un po’ come commerciare vino in Arabia Saudita, una vita senza prospettive. Mani educatissime nel passare l’ovale in qualunque situazione di gioco e di pressione e piede destro che lo è altrettanto, Johnny ha viaggiato con percentuali di trasformazione spesso sopra all’ottanta per cento, tra gli infiniti trucchi di un illusionista come lui ha sempre svettato una particolarità che lo ha reso unico. Sexton, la cui comprensione istantanea del gioco anticipò la scoperta dell’intelligenza artificiale, utilizzava i primi scampoli di partita per fare la radiografia delle qualità difensive dei suoi avversari e una volta individuata la falla individuale o collettiva, perché tutti ce l’hanno, dirigeva le operazioni affinché il coro dei suoi compagni potesse andare a punire proprio quella debolezza riscontrata, chirurgicamente. Così, ogni suo passaggio finiva per attivare il compagno che, in quel frangente e in quello spazio, aveva le maggiori possibilità di incidere. Insomma, Johnny altro non era che la palla giusta al momento giusto. Abbacinante definizione di talento, fare sembrare facili le azioni più complesse, e di intelligenza tattica.
Nativo di Dublino e orgoglioso di esserlo, è sempre l’Equipe che, come sovente accade, trova la metafora più azzeccata. Per il rotocalco d’oltralpe, quindi, l’importanza di uno come lui era tale che se avesse dato un colpo di tosse ad ammalarsi sarebbe stata tutta l’Irlanda. Per una vita intera, quindi, due le certezze: l’emozione struggente dell’Ireland’s Call – inno vergato dalla penna di Phil Coulter che unisce sotto lo stesso tetto le due facce dell’Irlanda, ricordando che tutti gli isolani, spalla a spalla, rispondono sempre presente alla chiamata della nazione – e che il collettivo di strumentisti con lo shamrock sul cuore avrebbe avuto per guida Sexton. Con la sua bacchetta a strutturare armoniosamente il suono d’insieme, dal colore verde dei prati. Appunto, come un direttore d’orchestra a teatro.
Per noi, che Sexton sta al rugby come Iniesta sta al soccer, domenica sarà strana, dopo tanti anni, la sensazione di cercare sul campo la maglia irlandese numero dieci per poi scoprire che ad indossarla non sarà lui. Perché, se è vero che è prima di tutto il rugby a fare grandi i suoi interpreti più che il viceversa, è altresì lapalissiano che nel contesto di una una disciplina meravigliosa ci sono campioni più campioni di altri. Parlando di Johnny, in definitiva, è stato davvero un privilegio quello di aver goduto della sua parabola sportiva, appagante come solo una Guinnes tracannata in Temple Bar sotto il cielo di Dublino.