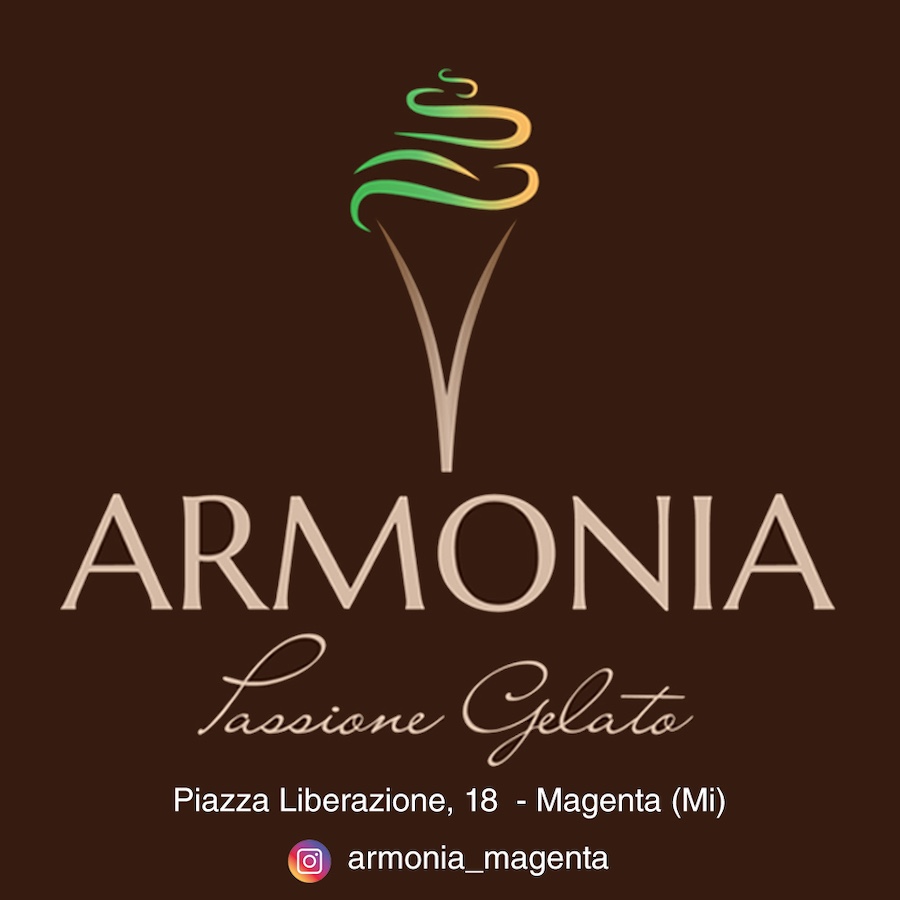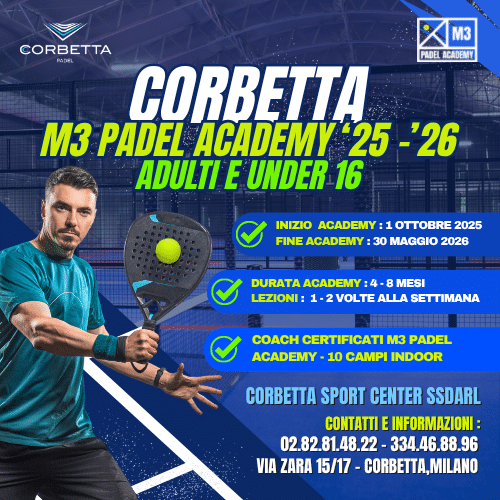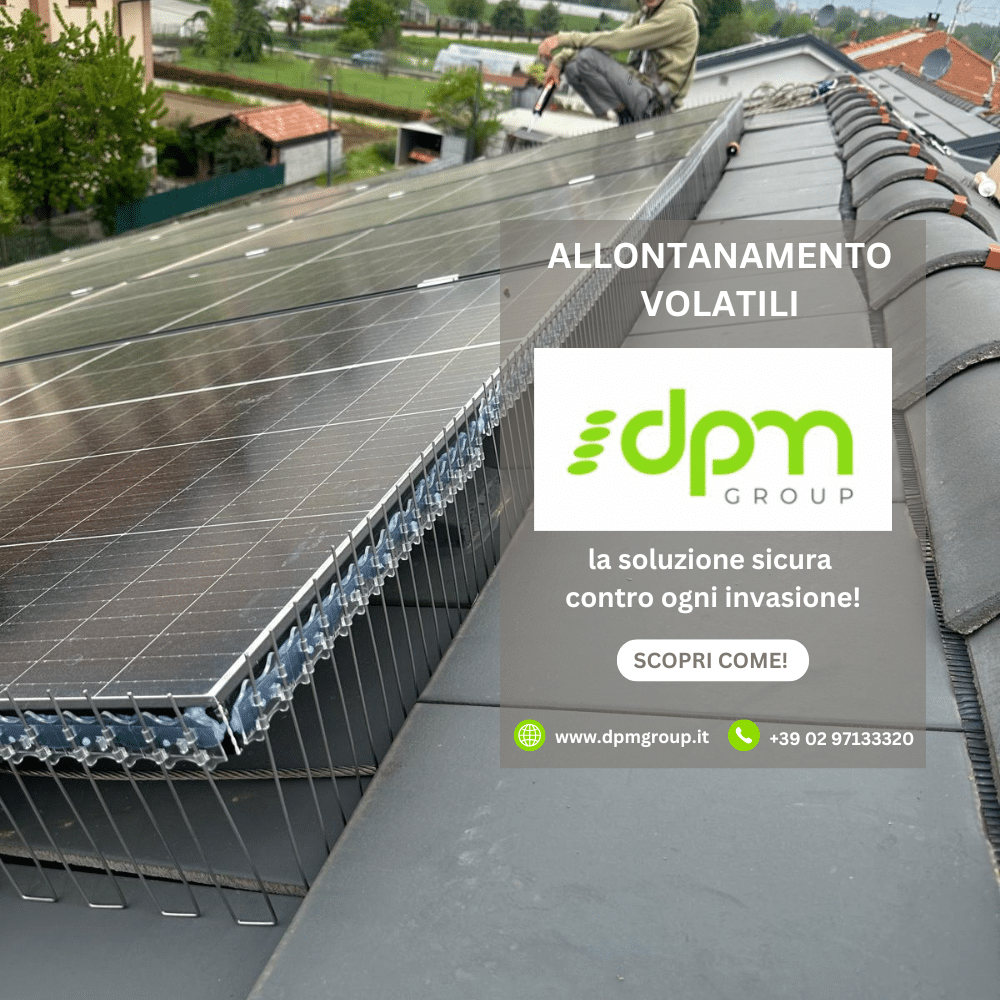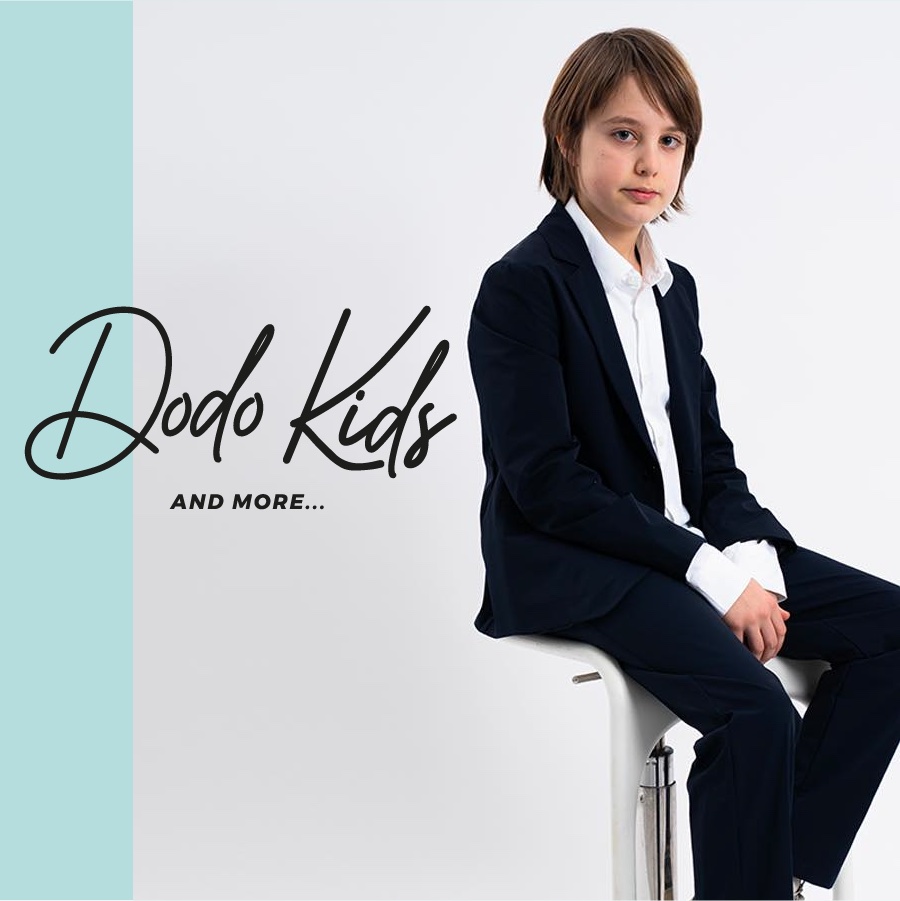E’ successo a Magenta, con la testa del Bambino distrutta; a Robecco anni fa, con l’incendio del presepe galleggiante sul Naviglio; in molte altre parti d’Italia, dove ormai non ci si ferma neppure più davanti ai simboli sacri. E’ successo stanotte (presumibilmente) ad Abbiategrasso, dove uno o più imbecilli hanno vandalizzato il presepe installato come da tradizione in piazza Marconi, di fronte al municipio, dove ogni anno viene posizionato anche il tradizionale albero.
Ne ha dato notizia con un post su Facebook l’assessore Valter Bertani, il cui sdegno è stato poi condiviso sui social da decine e decine di persone, tra cui il consigliere comunale Giovanni Maiorana e la segretaria di Ascom Brunella Agnelli. Da molte parti si invoca il ricorso alle videocamere di sorveglianza, che dovrebbero, potrebbero, speriamo abbiamo quanto meno colto in flagranza di vandalismo i responsabili di questo atto senza alcuna possibile definizione.
Il problema che anche ad Abbiategrasso come da molte altre parti dilaga è quello dell’emergenza educativa, cui ha fatto esplicito riferimento anche il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo nel commentare quanto accaduto nella sua città. Perché potremo o potremmo mettere telecamere in tutte le piazze o in ogni via, ma senza una riflessione seria sul tema educativo, sul rapporto tra famiglie e giovani, sul tipo di personalità che questi ragazzi e ragazze esprimono non ci sarà nessuna possibile reazione efficace a questo malcostume. Ora, nello specifico, aspettiamo cosa faranno la Polizia Locale di Abbiategrasso e l’Amministrazione comunale per individuare i responsabili. Per adesso ci limitiamo ad una riflessione di Papa Benedetto XVI risalente al 2008, ma tuttora validissima.
“Oggi, in realtà, ogni opera di educazione sembra diventare sempre più ardua e precaria. Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, della crescente difficoltà che s’incontra nel trasmettere alle nuove generazioni i valori-base dell’esistenza e di un retto comportamento, difficoltà che coinvolge sia la scuola sia la famiglia e si può dire ogni altro organismo che si prefigga scopi educativi. Possiamo aggiungere che si tratta di un’emergenza inevitabile». Le parole di papa Benedetto XVI, pronunciate in occasione del discorso alla diocesi di Roma giugno 2007, costituiscono una forte provocazione ad affrontare un tema che spesso si rimanda volentieri per le difficoltà che comporta. Tuttavia, si deve dire che è da millenni che – anche se con parole diverse – si parla della difficoltà di educare e delle sfide che essa comporta.
Oggi è dunque normale che si parli in molte sedi di emergenza educativa, in riferimento alla crisi morale e sociale, alle esigenze della globalizzazione, ad un rincorrersi di dinamismi sempre più veloci a causa del gigantesco sviluppo scientifico e tecnologico, in cui si modifica il rapporto con lo spazio e con il tempo. Gli stessi documenti degli organismi internazionali (UNESCO, OCSE, UE) che si occupano di educazione individuano alcuni punti di attenzione ritenuti ineludibili. Il lavoro degli educatori ed insegnanti non può collocarsi fuori da tale panorama, anche se non è pensabile che ciascuno – da solo – possa portare il peso di tali emergenze. Il problema è che spesso le chiavi di lettura (i paradigmi pedagogici) per inserirsi in quella che viene definita società della conoscenza sono a loro volta di tipo “funzionalistico” … e corrono il rischio di rendere ancora più profonda l’emergenza educativa. Cogliere la sfida educativa ad occhi aperti non significa abbandonarsi alla sterile lamentazione, ma lasciarsi “sfidare” dalle difficoltà per rilanciare con speranza, visto che la speranza è l’anima dell’educazione. Educare è sempre un atto di speranza, perché genera cultura.