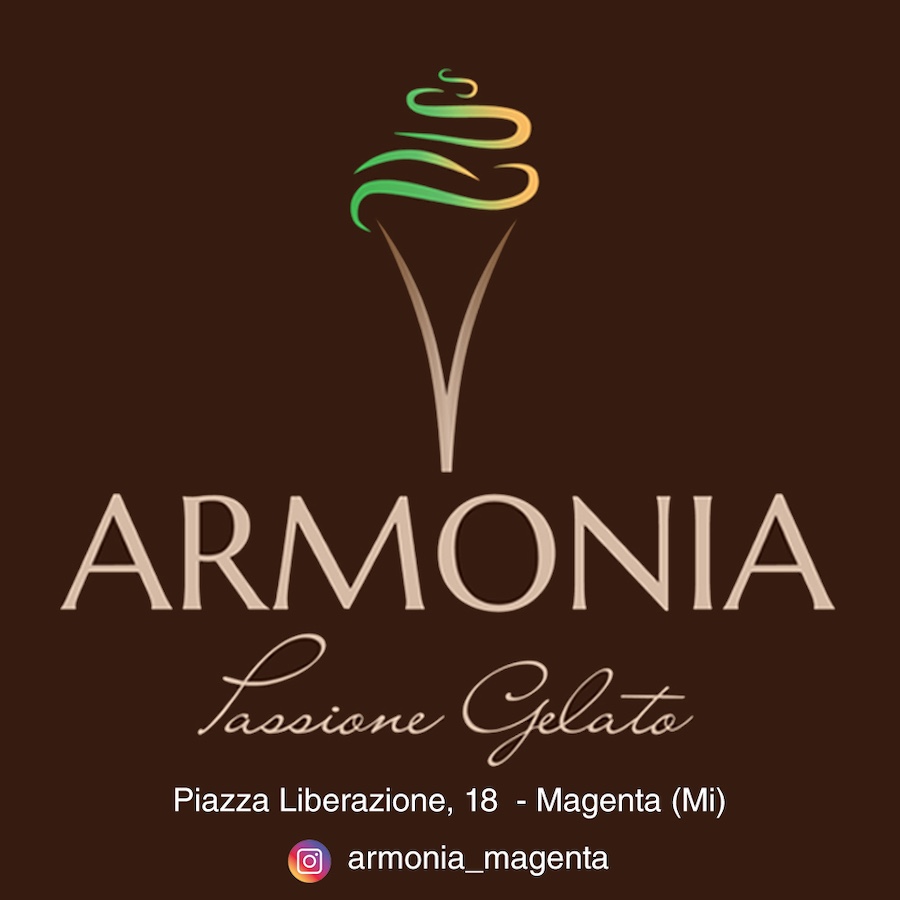Ticino Notizie si schiera a difesa della cultura dei falò nella giornata di Sant’Antonio, SENZA SE E SENZA MA.
Il 17 gennaio è la festa di Sant’Antonio Abate e la notte in cui secondo la tradizione gli animali parlano. Ma non solo, è la notte dei falò che abbraccia il sacro e il profano.
Sant’Antonio Abate è il beato del fuoco, protettore del bestiame e dei campi. Egiziano di nascita e morto nel deserto della Tebaide il 17 gennaio del 357, il Santo viene raffigurato con un bastone, il fuoco ai suoi piedi, un Tau e un maiale accanto a lui.
E’ proprio il fuoco l’elemento che più di tutti, oggi, viene utilizzato per ricordare San’Antonio. In molte zone d’Italia si accendono falò che simboleggiano la volontà di abbandonare tutto ciò che appartiene ai mesi passati e di rinnovarsi a partire dal primo mese del nuovo anno.
I fuochi purificatori possono essere accompagnati da processioni e celebrazioni che spesso richiamano costumi ottocenteschi. Simbolicamente il falò ha lo scopo magico di riscaldare la terra e invogliare il ritorno della primavera, una visione chiaramente leggendaria che viene tramandata in molte città dove proprio il 17 gennaio si benedicono gli animali e si preparano cataste di legna che si accendono poi al tramonto.
Sant’Antonio Abate e la leggenda del fuoco
Ma perché si usa accendere i falò? La tradizione si lega alla leggenda riportata in Fiabe Italiane di Italo Calvino. Eccola:
Antonio si alzò all’alba, con l’intenzione di aiutare gli uomini che quel fine settimana erano venuti ad incontrarlo presso la grotta.
Nel mondo mancava il fuoco e gli uomini, intirizziti dal freddo, si erano rivolti a lui e lo avevano supplicato di procurarne almeno una scintilla per ciascuno o anche una fiammella sola (se proprio non riusciva a fare di meglio!), ché tanto ci avrebbero pensato loro a spartirselo.
Per prima cosa Antonio svegliò l’inseparabile maiale con il quale condivideva una vita di solitudine:
«Maialino, amico mio… lesto alzati, non restare qui a poltrire!
È già ora, il sole sorge. Prepariamoci a partire!»
L’animale, che dormiva come un ghiro nell’angolo meglio riparato della grotta, con un ronfo si girò dall’altra parte, cosicché Antonio fu costretto a scrollarlo.« Maialinooo, non mi senti? Sono già le cinque e venti!» gridò più forte. «Con l’aiuto del buon Dio, dobbiam correre all’Inferno: troveremo lì del fuoco da donare ai miei fratelli.

L’antropologo Paolo Apolito, docente della Università di Salerno e della Università Roma Tre, ha partecipato a vari convegni, conferenze, seminari e tavole rotonde organizzate sul tema dei falò. Da uno di questi, e precisamente dal convegno organizzato dalla Pro Loco il 7 dicembre 2003 nell’aula municipale di San Mango Piemonte, riportiamo la relazione dell’illustre accademico sul tema “Falò, tra leggenda, storia, cultura e folklore”.
«Tutte le volte che parliamo di tradizioni contadine, dobbiamo tener conto che la cultura contadina non è mai esclusivamente una cultura locale cioè non è una cultura che si può considerare chiusa in un territorio di un Comune; la cultura contadina è una cultura globale. Noi parliamo tanto di globalizzazione ma c’è una globalizzazione che è molto indietro nel tempo di alcune migliaia d’anni, il mondo contadino, la civiltà contadina dalle nostre parti nasce 8-9 mila anni fa nell’attuale Medio Oriente, una delle culle della civiltà contadina è l’attuale Russia. Nasce da lì e piano piano si diffonde in tutta l’Europa e arriva fino ai confini della Siberia e i contadini che vivono per migliaia d’anni in questo territorio vastissimo hanno tutti la stessa cultura. Poi località per località ci sono delle piccole differenze ma sono sempre piccole rispetto a quello che è comune e che si trova dovunque. Questo è uno dei motivi per cui il rituale del fuoco che voi vi apprestate questa sera a ripetere è un rituale che troviamo in tutta Europa e non solo. la prima cosa da tener presente tutte le volte che parliamo di tradizioni locali è che la base delle tradizioni locali, cioè la base contadina, non è locale ma è globale, è generalizzata. adesso passiamo al secondo livello e cerchiamo di capire l’origine del rituale del fuoco. Siccome stiamo parlando di qualcosa che è nato parecchie migliaia di anni fa, cioè quando non esisteva ancora la scrittura, allora noi non possiamo essere sicuri di nulla perchè anche quando abbiamo documenti storici scritti molte volte gli storici si dividono nell’interpretazione di questi documenti storici. ma nel nostro caso non abbiamo scritti sappiamo che il rituale del fuoco si diffuse piano piano in Europa, lo sappiamo perchè ne abbiamo trovati, i nostri antenati nel MedioEvo, ne hanno trovati da tutte le parti ed in particolare, tra i nostri antenati quelli che li hanno trovati erano i sacerdoti,gli ecclesiastici, i preti perchè a loro interessava perchè i secoli della cosiddetta era cristiana sono i secoli in cui il cristianesimo da piccola religione che riguardava un pugno di pescatori e contadini della Galilea, diventa la più grande religione del Globo e la religione principale dell’Europa e diventa anche la religione mondiale. e questo avviene attraverso quello che noi conosciamo come la evangelizzazione, cioè partono prima gli apostoli e poi i missionari e vanno dovunque a convertire e quando vanno a convertire trovano già delle vecchie religioni, quelle che in generale chiamano la religione pagana. ci sono tante piccole religioni, l’una diversa dall’altra che avevano però alcuni caratteri comuni. Ora noi sappiamo che nel Medioevo c’erano moltissimi punti legati al fuoco perchè lo scrivono i missionari, i vescovi che vanno evangelizzando l’Europa e mandano lettere alle case dei loro conventi, dei loro ordini religiosi o al Vaticano dicendo di trovare questo tipo di punto e tra i punti più diffusi sono proprio quelli del fuoco che era una cosa che evidentemente stava molto a cuore ai contadini di qualche migliaio di anni fa. cerchiamo di capire il perchè, visto che continua a stare molto a cuore il rituale del fuoco ancora oggi nelle nostre comunità anche se le nostre comunità non sono più contadine. Voi sapete che mentre nei Picentini oggi si stanno per accendere i fuochi, almeno in un’altra zona non lontano nella Provincia di Salerno si sta facendo la stessa cosa però forse non sapete che i fuochi vengono accesi in altri momenti dell’anno, in altre zone del territorio salernitano o campano o meridionale o italiano o europeo ecc.ecc. gli studiosi si dividono in due grandi scuole di pensiero: ci sono quelli che pensano che il rituale del fuoco sia una forma di puruficazione e ci sono quelli che invece pensano che il rituale del fuoco sia una forma di magia. alcuni pensano che i nostri padri antichissimi quando arrivava il momento più buio dell’inverno, in cui sembra che il sole sia andato via, alcuni pensano che i nostri padri erano presi dalla paura che il sole non tornasse più, che il calore non tornasse più, che la luce non tornasse più, allora accendevano i fuochi quasi come magicamente stimolare il sole a tornare. Questa è una scuola di pensiero un po’ superata. L’altra scuola di pensiero ci dice che i fuochi sono soprattutto il rituale di purificazione e per capire questa purificazione dobbiamo fare un giro più ampio, dobbiamo fare un giro che riguardi non solo questa festa ma tutto l’anno. la caratteristica della cultura contadina è che se vuoi capire un pezzettino della sua cultura devi affrontare la conoscenza di tutto;per esempio, perchè la sposa ha il colore bianco? se io dovessi rispondere a questa domanda fermandomi solo al matrimonio, non potrei rispondere. se io mi avvalgo di altri rituali, nascita matrimoni e morte, allora trovo la chiave per rispondere. Perchè la sposa è vestita di bianco? perchè è la vedova è vestita di nero e viceversa; il bianco della sposa si spiega con il nero della vedova e viceversa; qual’è la differenza tra sposa e vedova per cui l’una è vestita di bianco e l’altra è vestita di nero? la sposa è feconda perchè si è appena sposata, la vedova non è più feconda perchè ha perso il marito e dunque in relazione alla fecondità si differenziano i due colori. Allora nel caso del fuoco, se vogliamo capire il fuoco d’inverno, dobbiamo fare un rapidissimo giro in tutto l’arco dell’anno. L’arco dell’anno cioè l’anno religioso dei nostri padri si divideva in due parti: autunno-inverno e primavera-estate; quando dico l’anno religioso bisogna pensare ad una religione che metteva insieme elementi di paganesimo pre-cristiano, con elementi di cristianesimo, in termini tecnici si chiama sincretismo, cioè una religione che mette insieme degli elementi non cristiani anzi in alcuni casi addirittura anti-cristiani con elementi cristiani per cui abbiamo che non si riesce a capire se quella festa è fuori dalla festa religiosa o è religiosa o pagana ecc. Questo riguarda l’anno. Il periodo autunno-inverno è il periodo in cui la natura è come se morisse o come se si fosse addormentata e allora quando comincia questo periodo, il 15 di agosto con la festa della Madonna Assunta, da allora in poi tutte le feste, tutti i rituali si avviano ad essere quasi tutti o tutti notturni. infatti il rituale del fuoco è notturno, non diurno. secondo elemento: molti dei Santi sono o vecchi o bambini, noi celebriamo Santi come San Nicola, per esempio, che è un altro vecchio ed è anche il protettore dei bambini, o Santi bambini, il classico nella cultura contadina è Gesù Bambino; ma poi anche l’anno vecchio viene rappresentato come vecchio, l’anno nuovo è bambino, la befana anch’essa è vecchia, Sant’Antonio, a dicembre, è un vecchio, abbiamo solo Santi vecchi o Santi bambini. perchè? perchè questo è il segno ritualmente della morte. infatti sappiamo che questo periodo ha  un punto centrale che è la festa dei morti primo e due novembre e in questo periodo i nostri antichi contadini celebravano la morte festeggiavano la morte. Mi direte: perchè si festeggia la morte? per noi la morte è qualcosa completamente da rifuggire addirittura da non nominare, da evitare ma per il mo
un punto centrale che è la festa dei morti primo e due novembre e in questo periodo i nostri antichi contadini celebravano la morte festeggiavano la morte. Mi direte: perchè si festeggia la morte? per noi la morte è qualcosa completamente da rifuggire addirittura da non nominare, da evitare ma per il mo
ndo contadino la morte non era vista in questi termini, non era qualcosa da evitare perchè? perchè era dalla morte che veniva la vita, dalla vita nasce la morte e viceversa, seminiamo tutto l’anno, prendiamo una qualsiasi semente, la seppelliamo, la condanniamo alla morte praticamente, il seme del grano muore ma dalla morte del seme del grano viene fuori una vita, la spiga di grano. e tutto il mondo contadino è legato a questo rapporto di scambio tra la vita e la morte, tra i vivi e i morti. questo è il periodo dei morti e della morte perchè in questo momento i vivi festeggiano i morti, proprio oggi, i morti della propria comunità, pochi Santi perchè loro diano un buon raccolto quando sarà il momento. io adesso ti festeggio perchè poi da te attendo un buon anno agrario. ora se ci riflettete, i vecchi sono quelli ahimè più vicini alla morte, i bambini sono quelli più vicini alla non vita perchè sono appena nati, in qualche senso dunque sono più vicini alla morte anche loro. Se pensiamo che per i nostri antenati l’anno, il tempo non era come oggi, una freccia che cammina in avanti, autunno inverno primavera ed estate, un tempo non era una freccia ma un cerchio, una cosa che gira. avete mai notato che ancora oggi ai nipotini si dà il nome del nonno? perchè? perchè nel bambino torna il vecchio, il progenitore, l’antenato dunque nella mentalità contadina c’è una circolarità del tempo e quindi in questo rituale quelli che sono più vicini alla morte sono i vecchi da un lato e i bambini dall’altro. ecco perchè in inverno si festeggiano Santi vecchi o Santi bambini; il Santo Bambino per eccellenza è Gesù Bambino. Gesù Bambino come sapete nasce a mezzanotte del giorno considerato più breve, in quello ritualmente più breve cioè nel pieno della notte e del buio dell’inverno e della celebrazione della morte, per cui tutti i Santi sono molto vicini ai morti, nasce la nuova luce, nasce il Bambino che crescendo restituirà la luce, non solo la luce del sole, ma nel caso dell’intera parte del mondo cristiano, la luce spirituale. ecco allora dove nasce il fuoco vero, al centro del buio, ed ecco qual’è probabilmente il senso del fuoco, rituale del sette dicembre, o del 24 dicembre come in alcune zone della valle dell’Irno, mentre in altre zone il 19 marzo, festa di San Giuseppe o addirittura alla vigilia del primo maggio cioè i fuochi li trovate in un arco di tempo distribuito che va dall’inizio del periodo invernale, autunno, alla fine del periodo invernale. L’ultima data utile per i fuochi è il 24 giugno, la festa di San Giovanni. in alcune comunità i fuochi si accendono il 24 giugno. Ora, indipendentemente dal giorno preciso in cui questi fuochi vengono accesi e il giorno preciso dipende dalle date inviate a immigrazioni, perchè sapete che noi mediterranei, italiani, siamo il frutto di incroci raziali incredibili, non ci sono solo i greci e i romani, ci sono gli etruschi poi arrivano gli arabi, poi i bizantini e poi i normanni e poi i longobardi e gli aragonesi, gli angioini, gli spagnoli i francesi e borboni e noi siamo il frutto di questo gigantesco meticciamento culturale, e allora se i fuochi qui sono il 7 dicembre e ad Aquara sono il 24 dicembre, può essere dovuto anche al fatto che qui si era stabilito un contingente, una etnia che veniva da un certo punto dell’Europa e lì un’altra etnia ma il senso è lo stesso. il senso è quello di segnalare che il momento più buio dell’animo, di parte dell’animo legata ai morti, è il momento in cui comincia la rivincita della vita e la rivincita della vita sul piano rituale la vediamo nella maniera più precisa e più specifica alla fine del periodo invernale cioè in particolare a maggio. Dopo Pasqua le feste cambiano tutte quante di segno: prima erano tutte notturne, dopo diventano tutte diurne. Ci sono luoghi di pellegrinaggio alla Madonna o ad altri Santi e questi pellegrinaggi si svolgono tutti dopo Pasqua e sono pellegrinaggi che hanno una scansione, ritmo diurno, solare, si sale al mattino presto in primavera. poi c’hanno un’altra scansione, un altro ritmo, un’altra festa verso la fine dell’estate dove si sale la sera tardi cioè è come se la comunità agraria, contadina, nel periodo dell’estate si rappresenta come solare, diurna, legata alla vita e nel periodo dell’inverno, notturna, legata alla morte. e i Santi che troviamo nel periodo estivo sono non più vecchi e bambini ma adulti e in particolare adulte, donne, non a caso la festa che si celebra in quel periodo dell’anno è quella della Madonna. Mentre la Madonna che celebriamo oggi è la Madonna Vergine, la Madonna che celebriamo in estate è la Madonna col Bambino. Madonna non ancora feconda d’inverno, Madonna feconda d’estate. ora questo può sembrare anche un pò blasfemo, che c’entra la fecondità con la Madonna? beh, nella mentalità contadina c’entrava perchè i contadini avevano una preoccupazione fondamentale e cioè il rinnovo della fertilità della terra e quindi tutta la mentalità religiosa, spirituale, cerimoniale era legata a quel leggio, per i contadini la vera preoccupazione non era quella del Paradiso, cioè l’aldilà ma era ottenere un buon raccolto dalla madre terra e tutto era legato a questa mentalità. Questo mondo, che è molto lontano nel tempo e che non ci appartiene più, perchè è inutile che ci illudiamo di poter restaurare per intero questo ciclo agrario o questa tradizione agraria, non siamo più contadini, i nostri problemi sono altri, i nostri pensieri sono altri, dunque la mentalità arcaica a metà tra paganesimo e cristianesimo, è scomparsa per sempre, forse i nostri avi, i nostri nonni e bisnonni ancora avevano un comune elemento. E allora ci vogliamo chiedere, perchè è ancora così forte in alcune comunità, come qui a quanto a pare, è forte il ciclo che mantenga la sua forma? qual’è il senso di questa forza? il senso di questa forza non è il raccolto, il ritorno della luce, del sole, nessuno più ha paura il sole non torni più, siamo tutti quanti consapevoli che il sole verrà ma il senso è proprio nelle cose che sono già state dette dalle persone che hanno parlato prima di me quando hanno utilizzato una parola che occi è molto di moda, e la parola è identità cioè il ritorno della tradizione e il tentativo di mantenerne l’identità però permettetemi di dire una battuta finale sul tema dell’identità perchè anche qui dobbiamo fare un pò di chiarezza: l’identità è una bellissima cosa però è anche una cosa un pò litigiosa, con l’identità ci si può far male, noi italiani fino adesso non ci siamo fatti male con l’identità e mi auguro che non ci faremo mai male però, come studioso ma anche come cittadino del mondo, io so che l’identità è un’arma che può far male, è una risorsa che può fare molto male ma può trasformarsi in un’arma pericolosa. se io guardo aldilà del Mare Adriatico, mi trovo con dei fratelli, gli slavi dell’ex Jugoslavia, non lontani da noi come mentalità in cui, con la terra, in cui il tema dell’identità è diventato un tema di guerra in nome del quale sono stati compiuti alcuni dei più efferati genocidi del secondo dopo guerra, sembravamo vaccinati dopo la II guerra mondiale ma non eravamo vaccinati, in nome dell’identità si stanno compiendo in questo momento nel mondo battaglie terrificanti che non salvano nessuna identità in particolare ma quello che sicuramente fanno, distruggono. c’è un rapporto tra il nostro lavoro qui sull’identità e quel tipo di battaglia omicida edita sull’identità? apparentemente nessuna ma in realtà sotto sotto un rapporto c’è ed è per questo che bisogna stare attenti. Che cos’è l’identità? l’identità non è una cosa che sta nel nostro DNA,non è una cosa che sta nel nostro sangue ed è un pò sorprendente che il nostro popolo risenta nel DNA di una qualche identità italiana ecc.in ottomila anni qui son passati tutti, quale DNA vogliamo identificare, ci può credere soltanto un Ministro della nostra Repubblica che ci sia qualcosa di addirittura biologico o come dicono i filosofi ci sia un’esse
nza ma non c’è nessuna essenza, le essenze non sono presenti nella storia umana, nella storia umana sono presenti soltanto mescolamenti, siamo tutti figli di…e questa è la bellezza dell’umanità soltanto l’uomo ha vinto la sua battaglia diventando una cosa ben più potente della scimmia perchè si è mescolato e in particolare noi siamo mescolati moltissimo. Questa è una prima cosa da considerare. La seconda cosa: se l’identità non è nel DNA, se non è nella biologia, dov’è l’identità? l’identità è nel buon esempio e questa è una cosa che bisogna tenere molto a mente, non è nel passato, è nel presente. Qualcuno mi chiederà come è possibile. Nell’identità picentina, puoi per esempio pensare che debba entrare il modello di segregazione femminile, cioè di emarginazione delle donne? i nostri antenati le donne le tenevano in cucina, non mangiavano insieme agli uomini, erano subalterne, erano sostanzialmente, oggi le potremmo definire quasi delle schiave, i comportamenti dei papà erano molto simili a quelli del padre padrone, ci piace questa cosa? fa parte della nostra identità? credo di no, questi sono valori ormai che rifiutiamo. Se andiamo ancora indietro nel tempo troviamo dei comportamenti ancora più efferati, che non ci piacciono, che rifiutiamo. e invece alcune di queste cose le prendiamo, le riportiamo dentro dal passato. Per esempio ci piace il sentimento dell’armonia del passato, ci piace anche il gusto della festa del passato e allora alcune cose ci piacciono, altre cose non ci piacciono; la nostra attuale identità è il frutto di una selezione che facciamo noi oggi nel nostro tempo. Faccio un esempio più grosso: noi siamo tutti europei e occidentali e ci interessa che si mantenga l’identità occidentale.nell’identità occidentale ci mettiamo anche Hitler? lo mettiamo fuori? certo lo mettiamo fuori. allora questo vi fa capire che l’identità non è qualcosa che ci viene consegnato automaticamente dalla storia ma è qualcosa che noi possiamo decidere di conservare o di buttar via e allora cos’è che vogliamo conservaredella nostra identità campana o della vostra identità picentina?e che cos’è che non volete buttar via? ecco allora in questo processo di selezione per costruire l’identità, come viene in primo piano la società civile, come cioè non è possibile esser pigri a compiacersi della propria identità del passato, sentirsi un’identità significa riflettere oggi su quello che vogliamo essere domani. Il sentimento dell’identità non è guardare al passato soltanto, è soprattutto guardare al futuro e allora con questo la battaglia si vince se si riescono a coinvolgere le nuove generazioni, non può essere la battaglia dell’identità un ragionare tra vecchi o un lamentarsi del cambiamento del tempo come molte persone anziane fanno ” ai tempi miei era meglio, adesso è peggio” questo è il modo migliore per cancellare definitivamente ogni discorso sull’identità. Il discorso sull’identità lo si vince quando si agganciano le nuove generazioni e la cosa fondamentale che devono fare le comunità locali, agganciare le nuove generazioni, quelle cioè che anche se fisicamente vivono nel territorio, mentalmente sono lontanissime. il loro immaginario ormai è lontano anni luce dalla televisione, dai media da internet ormai non è più nei paesi in cui vivono e la seconda grande raccomandazione è che l’identità non è una forma di chiusura ma è una aggravio. L’identità forte, vera, è identità che dialoga. Non avrebbe molto senso che io senta la mia identità con chiusura in me stesso; a me serve sentire la mia identità solo per aprirmi agli altri, le identità locali devono essere apertura, anche dalle nostre parti capita di avere a che fare con sentimenti di identità locale eccessivamente di chiusura. e qual’è il segnale della eccessiva chiusura? il pensare che l’altro è peggio di noi, il pensare che io sono sempre superiore; questo è un segnale di identità chiusa, bloccata e quindi identità pericolosa. bisogna imparare ad avere un grado forte di apertura il che non significa annullare il sentimento dell’identità ma significa avere la capacità di dialogare con le altre identità. è un problema che non sentiamo molto, almeno per adesso, ma tra dieci anni, tra quindici anni, o l’identità picentina sarà in grado di dialogare apertamente con le altre identità oppure sarà condannata a scomparire oppure sarà condannata ad armarsi ma mi auguro che nessuno sia così folle. Concludo ricordandovi il modo in cui i nostri padri contadini per secoli hanno aperto la loro identità più forte ad una nuova etnia che è entrata nel nostro mondo da molti secoli, gli zingari. Contrariamente da quello che si può pensare gli zingari non erano emarginati dal mondo contadino, erano cacciati via da gente di potere delle nostre comunità. gli zingari erano bene accolti dai contadini tanto è vero che, per esempio, nelle nostre forme musicali, campane, c’è una dimensione zingaresca che è fortissima. Come vedete non ho proprio mantenuto la mia promessa, ho parlato quasi il doppio.»