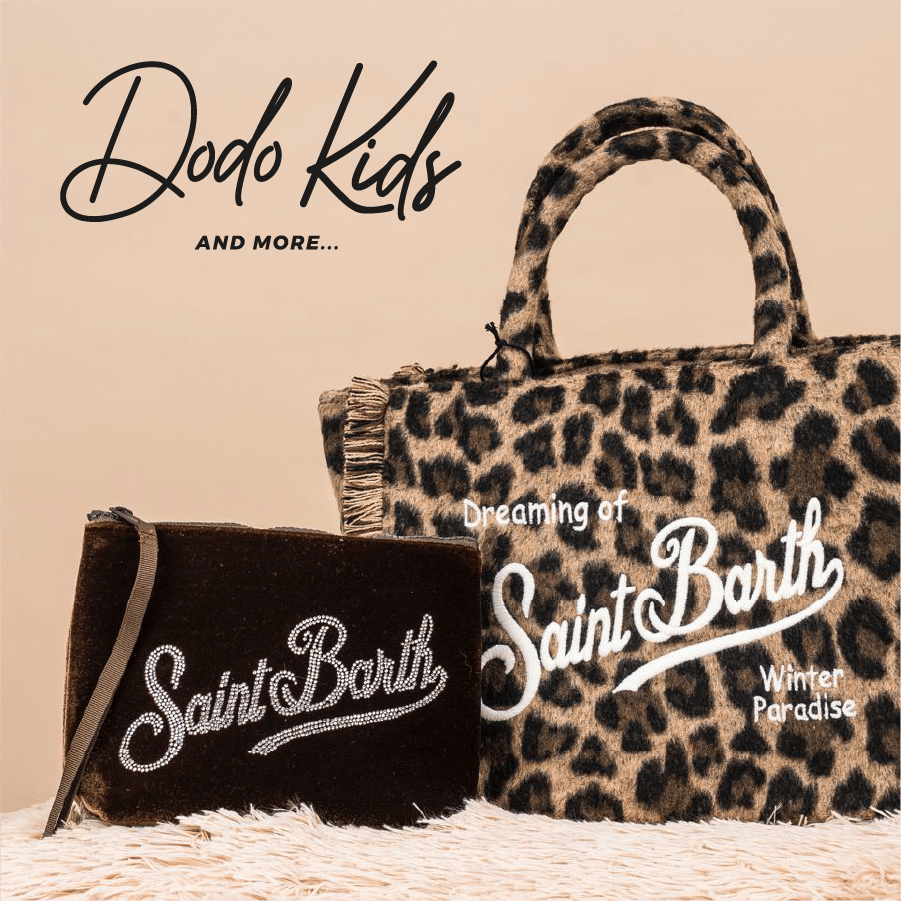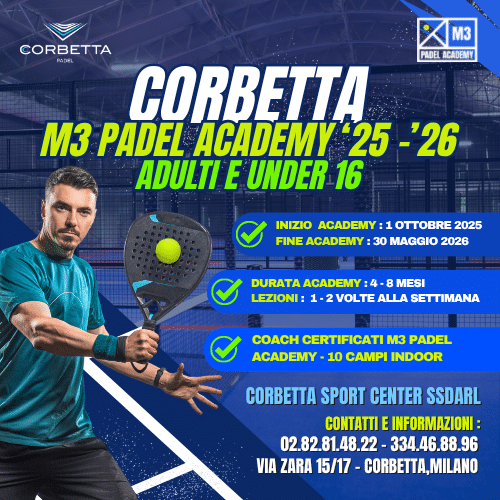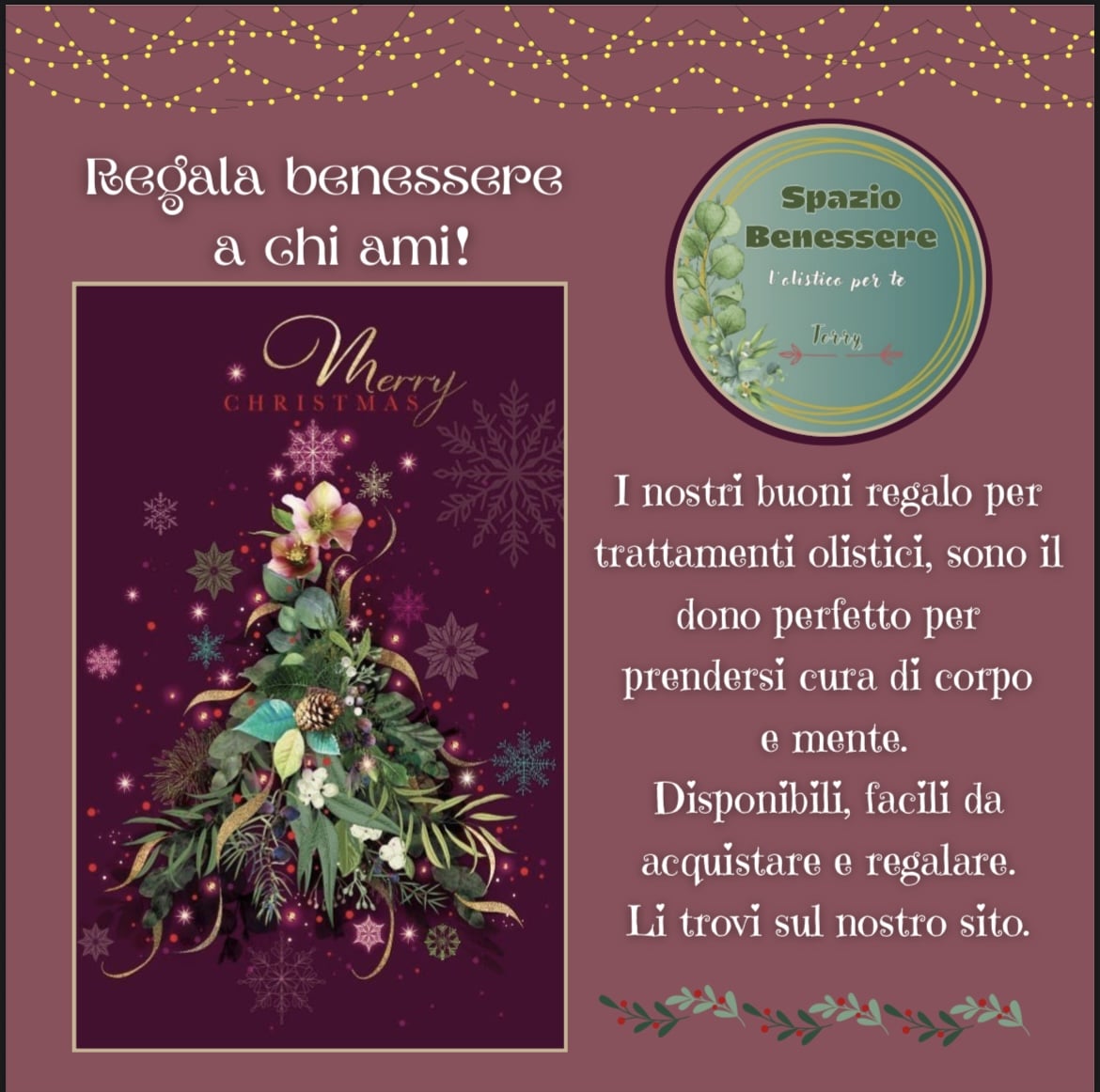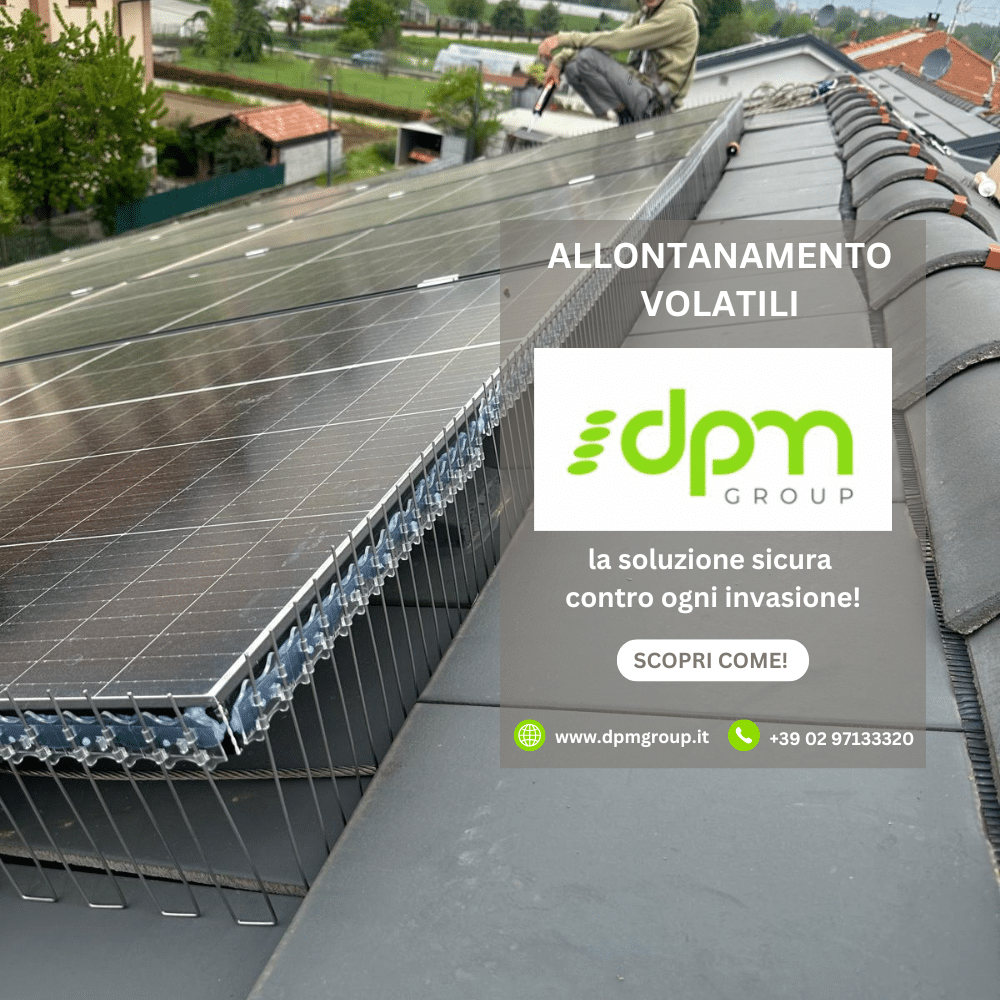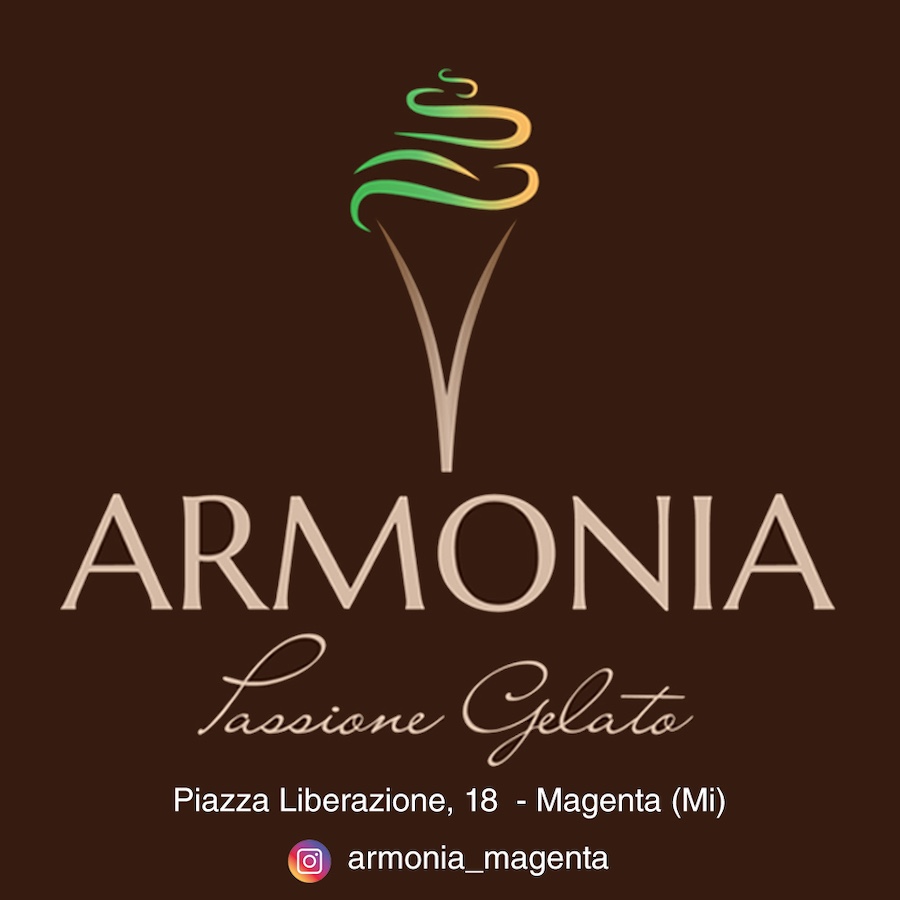“Il sentimento dell’angoscia legata al pericolo e la situazione di reclusione nella quale l’epidemia ci ha costretto certamente possono favorire, nei bambini o nelle persone fragili, ad esempio per età o per disagi personali, il determinarsi di una condizione di stress più marcata. Pensiamo a quelle persone a casa, spesso sole, che vivono attanagliate dall’angoscia. Non dimentichiamole! I diversi operatori e volontari che cercano di trovare soluzioni creative per aiutarle a vivere rappresentano davvero un bell’esempio.

Sono fatti questi che creano un forte impatto emozionale, potenzialmente traumatico. Sta accadendo qualcosa che somiglia, in modo strisciante e morbido, a quello che circonda gli eventi di una catastrofe: quando nei terremoti e nelle calamità viene richiesto l’intervento psicologico è anche per prevenire le conseguenze del trauma vissuto. Perciò c’è grande attenzione a non drammatizzare. La paura infatti, da una parte, è un sentimento vero e profondo, una risposta di ogni soggetto di fronte al pericolo e quindi da non censurare. Anzi da riconoscere. D’altra parte vi è oggi un tipo di preoccupazione altrettanto reale: che si diffonda un’altra pandemia, quella che con un po’ di enfasi possiamo forse chiamare pandemia della paura.

Le questioni che questa emergenza solleva sono tante. Le preoccupazioni per la salute fisica sono messe al primo posto, giustamente. Adesso. Ma nel primo iniziale periodo quasi tutti i vari personaggi pubblici sottovalutavano il problema dei contagi, magari per non scatenare la paura. Poi le drastiche misure di limitazione dei contatti e degli spostamenti si sono rese inevitabili. Ora, che stiamo sperando di uscire dalla costrizione e di riprendere la vita sociale, si è prudentissimi nel timore che il contagio non si fermi. Ed è una responsabilità che dobbiamo tutti condividere.
Credo però che non vada sottovalutata l’esistenza di un altro rischio, quella di alimentare il terrore dell’ammalarsi. L’angoscia legata alla paura dell’incombere di un nemico subdolo e potente, alla paura della morte, si è diffusa. Il virus rallenta, ma l’ansia circola vorticosamente. Evitare i contatti è la difesa promossa socialmente e necessaria. Ma non somiglia forse ai meccanismi patologici dell’evitamento fobico? E il digiuno dalle relazioni non rischia di rinchiuderci nell’individualismo? Come immaginare interventi preventivi che vadano oltre le sole misure restrittive?

Vi è stato un positivo effetto di adattamento che le persone incredibilmente hanno mostrato di saper attuare: lavoratori, insegnanti, bambini, adolescenti, famiglie chiusi in casa e, chi l’avrebbe detto?, ce l’hanno fatta a resistere! Una conferma delle infinite possibilità di resilienza dell’essere umano.
Agevolati in questo certamente dalla tecnologia, con il lavoro e l’insegnamento a distanza, con le riunioni in videoconferenza o i dialoghi su skype e la diffusione di pensieri e scritti sulle chat…: tutte cose impensabili prima, che hanno attenuato gli effetti del lockdown. Ma in noi hanno forse sostituito lo spessore di realtà delle relazioni, la consistenza sensibile dell’incontro personale, o no? Non rischia il virtuale di soppiantare la necessità del reale? Insomma il pericolo di un iperadattamento di noi tutti alla costrizione e alle limitazioni potrebbe esserci. E con esso un cedimento della dignità e della libertà della persona: anche questo è un problema di responsabilità che ci dobbiamo porre.
Infatti l’uomo è costituito da relazioni, relazioni che amano, che educano, che curano, che assistono, che ci fanno vivere: relazioni che non sono virtuali e che necessitano della realtà.
D’altra parte si ha pure l’impressione che questo sentimento della paura sia finalmente uscito alla scoperto, non lo si deve per forza nascondere, se ne può parlare apertamente, se ne discute sui giornali. Ammetterlo socialmente aiuta a non dissimularlo come una vergogna e a condividerlo. Chissà che la condivisione del problema e del limite sia parte della cura e ci possa aiutare a vivere meglio? Un capitale da non disperdere per il futuro – che emerge dalle testimonianze di dedizione di tanti colleghi impegnati nell’emergenza, come anche dalla gara di solidarietà della popolazione magentina a sostegno dell’ospedale – è aver riscoperto il bisogno di cura e di prossimità come dimensione umana essenziale.
Le persone in questo periodo hanno pure avuto un impatto più diretto con il limite umano e con quello supremo della morte. Il pensiero della morte l’abbiamo sperimentato con angoscia, l’abbiamo sentito molto vicino. Una possibilità di fronte alla quale ci siamo visti impotenti. Qualcosa però sta cambiando. Abbiamo imparato che la fiducia dell’uomo nelle capacità umane o della scienza non può essere illimitata.
Le percepiamo un po’ come illusioni, come quelle riposte nell’autosufficienza dell’io individuale, quasi dei miti da ridimensionare. Non però da demolire, perché l’uomo desidera, ha sete di infinito. Ma la risposta non è nei modelli narcisistici che tanto si propagandano. Bensì nell’a(A)ltro. Ciascuno di noi è un “io in relazione”. Siamo definiti da un tu.
Per questo siamo comunità. Della vita di comunità abbiamo bisogno come il pane, con la stessa concretezza. Una comunità reale credo, non virtuale, sia quella che oggi occorre riedificare”.
Contributo a cura del dottor Giorgio Cerati
*Psichiatra e psicoterapeuta magentino con formazione psicoanalitica. Già primario ospedaliero nei Servizi di Salute Mentale e formatore, ha sviluppato nel suo percorso professionale metodiche d’intervento integrate in psichiatria e psicoterapia oggi collabora con il Centro Clinico di Psicoterapia e Psicologia del Poliambulatorio Medico Santa Crescenzia di Magenta