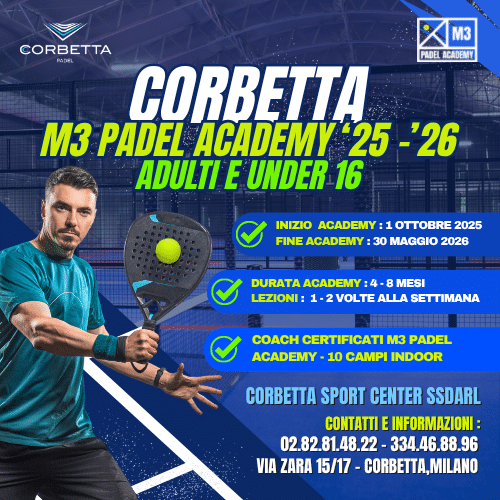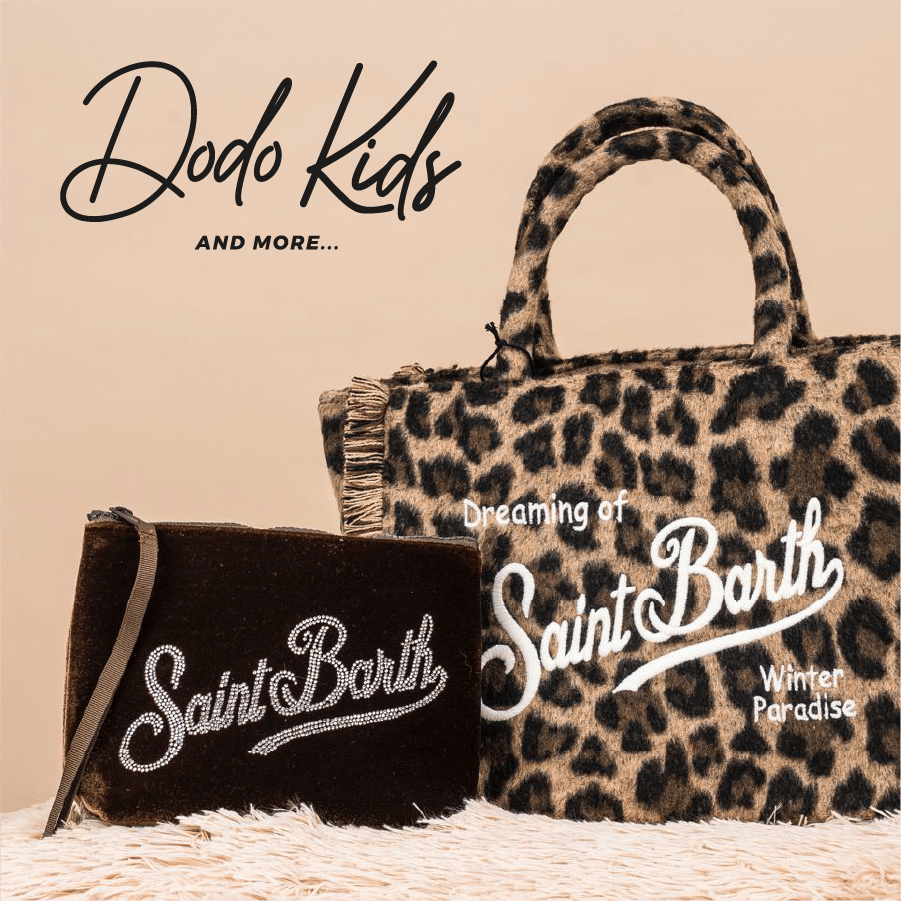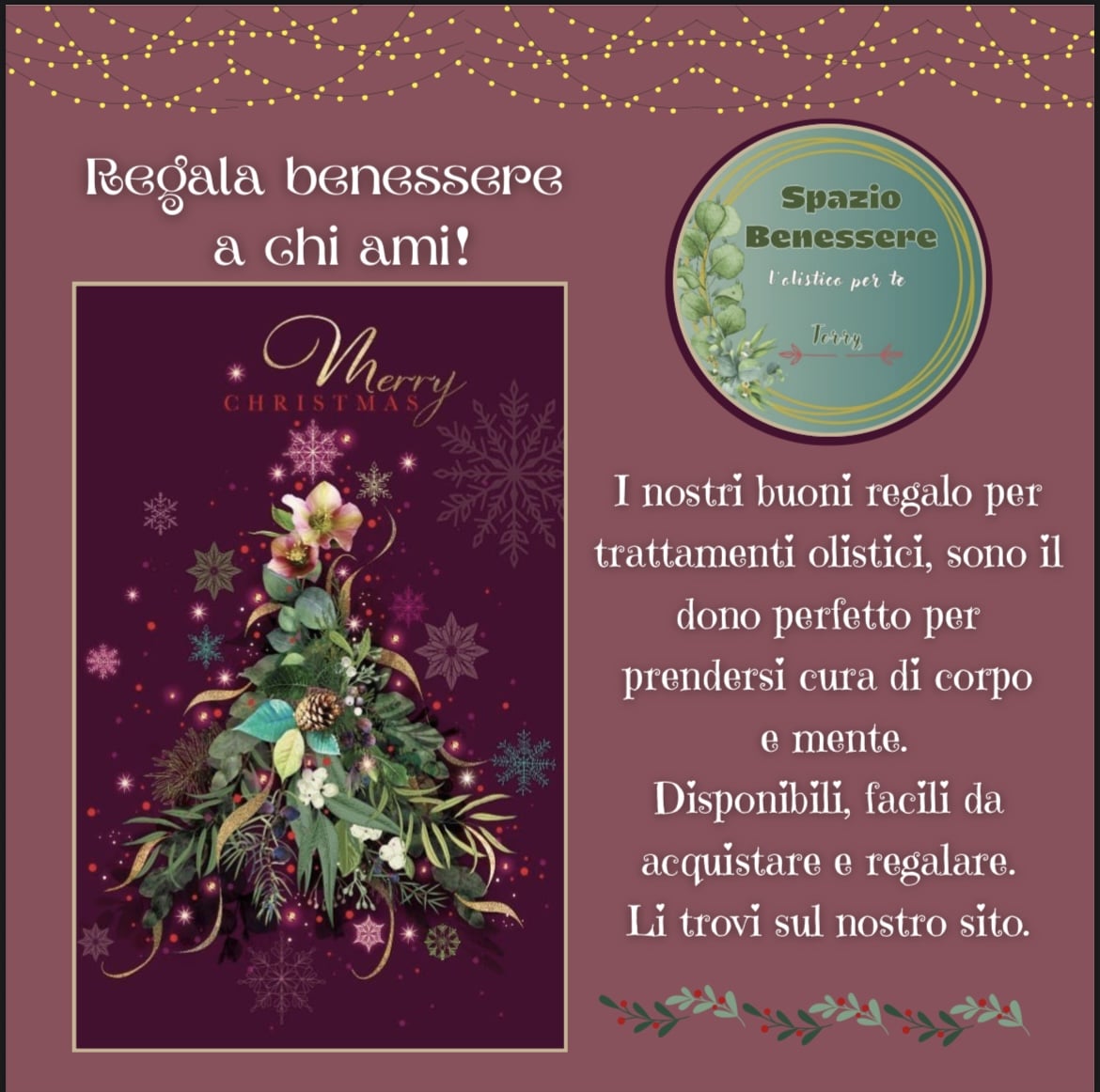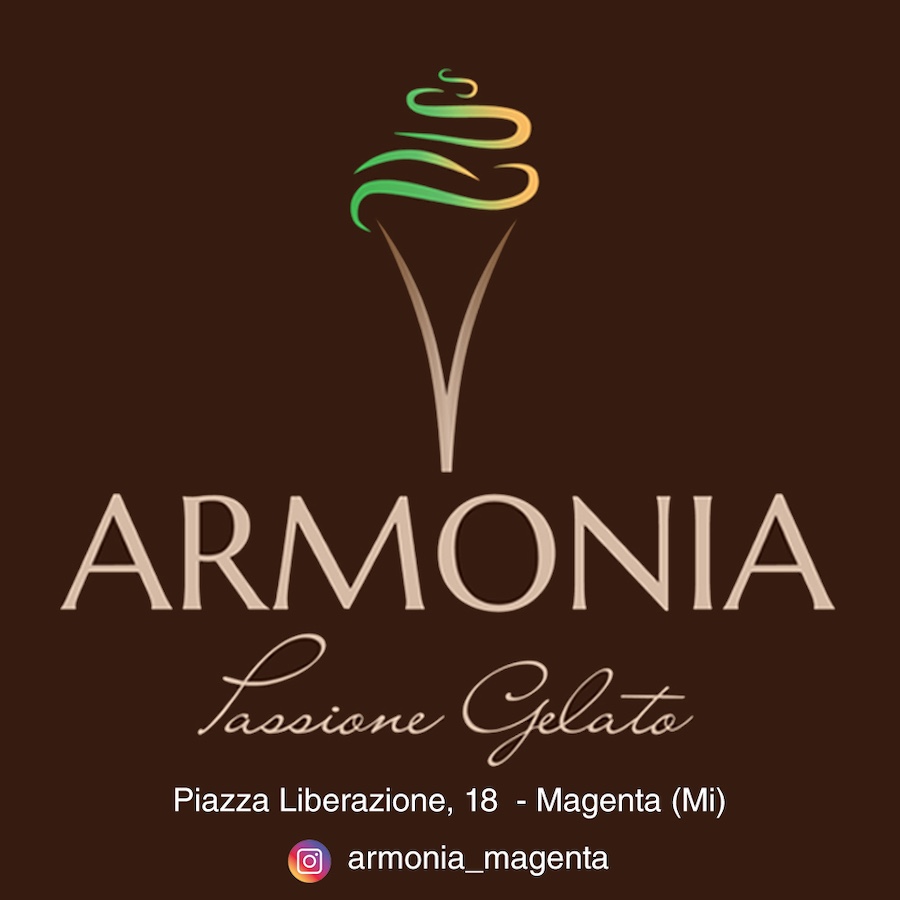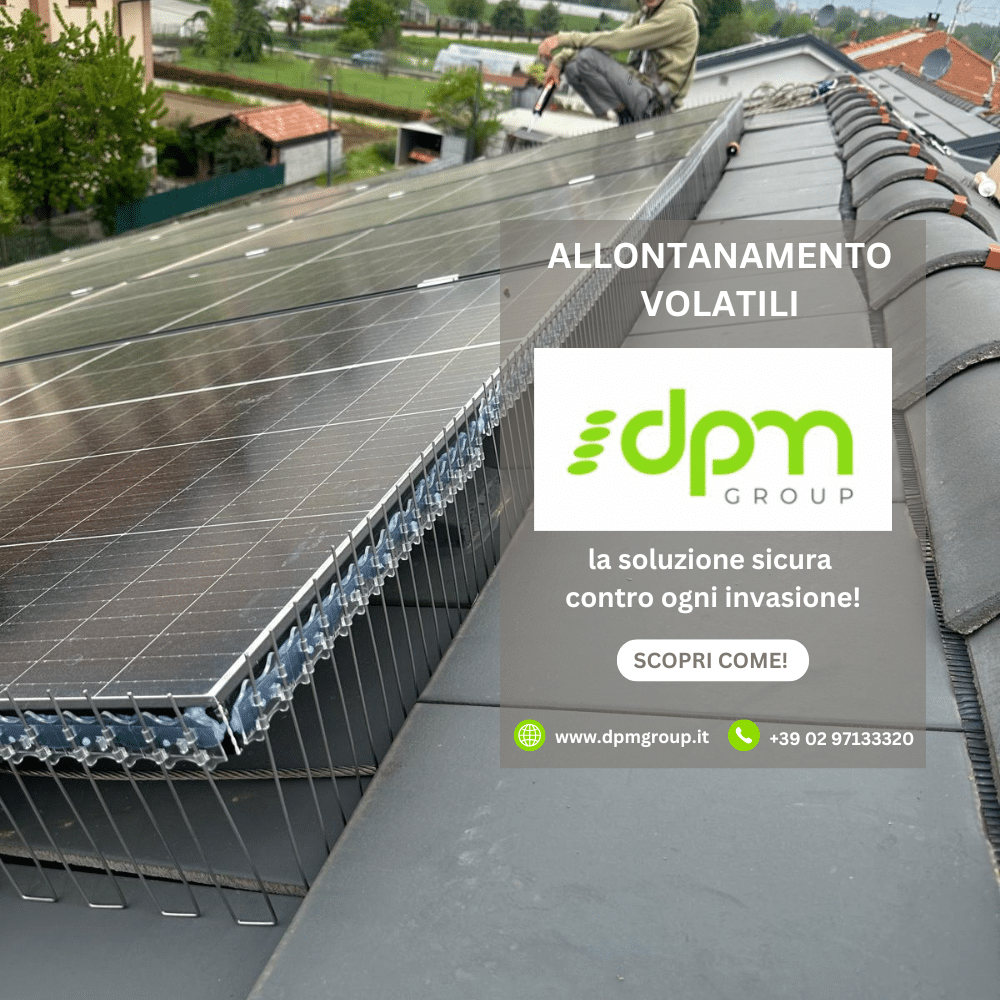“Molti atleti amano il loro sport con tutto il cuore. Io non credo di aver mai provato un sentimento simile”.
In compenso, se l’ultima generazione libera dai social network ha adorato visceralmente lo sport archetipo di eleganza che fu di Bill Tilden è soprattutto perché tale John Patrick McEnroe jr.- in una carriera che non desiderava affatto- vi si è ritrovato dentro finendo per sentirsi a proprio agio, nonostante contraddizioni talvolta titaniche.

Certo, dopo di lui i Big Three: gente che tiranneggia da tempi inesausti, quasi una sessantina di trofei Slam in tre, record polverizzati con irriverente agio e annotazioni imperiture che esondano dagli almanacchi. Ma i quattro anni che si aprirono nell’ormai lontano 1981 – anno che ha non a caso ha dato i natali a Roger Federer, a proposito di ricorsi storici e genie epocali – ovvero il giardino di casa McEnroe e comfort zone dello sport quale manifestazione d’arte suprema e irriproducibile, furono spartiacque, evidenziati in giallo sui libri di scuola. Quarantotto mesi di epica, inenarrabili, Mosè che apre il Mar Rosso: uno spaccato temporale caratterizzato da un prima spesso anonimo e un dopo via via più ingrigito. Durante, con luminescenza abbagliante, solo lui. Si è infilato una fascetta rossa tra i riccioli, ha scalzato dal trono Bjorn Borg, l’uomo di ghiaccio progettato per essere invincibile nonché sua antitesi noiosa, si è issato con la veemenza smargiassa propria di chi se la può sempre permettere al numero uno del ranking mondiale, ha fatto di un gioco aristocratico e financo antipatico, ai confini del manierismo, un esercizio planetario, da esportare sui playground che costellano un mondo in procinto di stravolgersi.

Senza metterci più amore dello stretto necessario, per il solo gusto di guardare tutti dall’alto. Un incremento di entropia mai registrato prima, un sisma sportivo che riscrive la scala Mercalli.
McEnroe, anzi l’essere mitologico SuperMac, nato nel febbraio del 1959 a Wiesbaden a ovest del Check point Charlie dentro la base militare statunitense ove il padre, John Joseph, si adoperava come ufficiale, fu iracondo col genere umano e per onestà intellettuale anche con sé stesso. Gentiluomo, però, in quel suo manovrare un attrezzo, che l’epoca volle essere ligneo avvolto da budello, quale naturale prosecuzione della mano sinistra più educata di sempre. Bene e male, acqua e fuoco, bianco e nero, tutto e niente. Imprevedibilità cromosomica contro ogni basilare logica tennistica al cospetto di uno sport razionale e per genesi redditizio se sparagnino. John fu in tal senso la vanificazione degli ossimori, il concepimento di un dominio irrazionale in un cosmo antigravitazionale dove nulla ha densità paragonabile al talento, che sta al piombo come l’ossigeno al cervello, dunque vitale. La discesa in campo di McEnroe, in ogni match ontologicamente sui generis poiché unicizzato dal triplo avversario, quello canonico al di là della rete che si somma all’arbitro e ai demoni che lo pervadono, è la stessa di un artista del Blackjack.

Un tavolo da gioco con sopra il mazzo di carte, il banco austero e la pigna di gettoni, le fiches, che trasformano polvere in gloria e viceversa. John, puntualmente, arriva in ritardo all’appuntamento con la sorte, si accomoda malvolentieri, cala il ‘ventuno’, manda il tutto gambe all’aria prima di abbandonare la sala ammutolita col suo fare da inguaribile spaccone. Tronfio di gloria, senza nemmeno portarsi via il bottino ma con un’inscalfibile certezza da esibire: “sono io il più grande”. Era vero.
Prendi il Diavolo e mettilo sull’altare oppure invita McEnroe a Wimbledon, il tempio, quindi blasfemia che è orgasmo per l’anima. In Church Road, tra il tè delle cinque, le fragole con la panna e la Duchessa stralunata nel Royal Box, John scrive pagine di un tennis ribelle e orgogliosamente maleducato che non possono ingiallire. Quando perde con Borg la finale dal tie-break (vinto) che è Storia, giurando la vendetta che regolarmente verrà, o quando trionfa. L’anno seguente, per esempio, o quelli successivi ancora, lasciando undici game – nulla – in due finali consecutive. Il knock out della boxe, l’asciugamano lanciato alla prima ripresa, il dominio. Quattro lunghi anni di assolo i quali, se a maramaldeggiare fosse stato qualsiasi altro collega meno delizioso, avremmo bollato come noiosi perché scontati e invece trasudano un’irrisolta forma di nostalgia.

Sette Major su sedici apparizioni, finali buttate alle ortiche come quella in Bois de Boulogne del 1984 contro il mai sopportato Ivan Lendl, tre Masters di fine stagione, decine di altri tornei diversamente importanti. Litigi, sceneggiate, interviste ficcanti, eccessi: l’antidoto alla banalità, una benedizione.
Tecnicamente non catalogabile, McEnroe, con la sensibilità che al solito si riserva nell’accarezzare il viso di una donna come Sophie Marceau (che comincia a turbare i sonni di milioni di adolescenti proprio in quegli anni, quando Il tempo delle Mele irrompe nelle sale), colpì dritto e rovescio con la medesima impugnatura, sempre la stessa, quella a martello che si insegnava da bambini prima che l’avvento degli arrotini stravolgesse pensiero e prassi.

Ironia di un gioco che sa essere meraviglioso, il risultato fu però quello di un fioretto leggero ma tagliente. A sinistra accentuando lo swing, quasi a depositare come un giocatore di bocce la palla a ridosso del centimetro desiderato con il palmo della mano, mentre a destra contraendolo fino all’osso, tipico dell’uomo indolente e svogliato ma con un polso forgiato nell’acciaio. Tuttavia è quando la pallina non tocca il suolo che il McEnroe tennista è fuoriuscito dall’umana previsione per entrare in una dimensione sublime. Nell’epoca in cui l’erba dei campi da gioco è ancora rigogliosa e irregolare, dunque complessa, il cemento, sempre dei campi, un maledetto ladro di attimi e, quel che più conta, la racchetta un attrezzo selettivo e discriminatorio, fu quindi l’esercizio della volée che assunse i connotati dell’imprescindibilità, esercizio balistico in cui McEnroe rappresentò un’altra disciplina alla quale forse un giorno la letteratura sarà in grado di attribuire il nome. Il Rinascimento del tennis, perché la manualità introdotta nella sfera di regole antiche e solo teoricamente inviolabili è della stessa pasta di quella che ha concepito la Gioconda o la volta della Cappella Sistina. Morale, una rinascita.

Per capire cosa possa aver rappresentato McEnroe, The Genius nell’iconografia classica o SuperBrat secondo gli incoscienti detrattori, per l’ultimo tennis prima dell’avvento noioso del politically correct come regola comportamentale non scritta – un circus, quello di allora, intriso di rivalità sfocianti financo nell’odio personale e violenze verbali diffuse che furono il sale di ogni duello sportivo – è sufficiente chiederlo al suo storico scudiero, Peter Fleming, uno dei pochi esseri umani capaci di non far perdere le staffe al bizzoso compagno. Sodalizio che, insieme, è valso una cinquantina di tornei in doppio quando, diversamente da oggi, la disciplina era praticata assiduamente dai tennisti più forti. La migliore coppia del mondo, quindi Fleming-McEnroe e qualcun altro, a caso. Insomma, valeva per due.

Un paio di matrimoni alle spalle, un anno sabbatico strappato al tennis e regalato alla schiena dolente poi un rientro, infine l’ultimo acuto a Wimbledon agli albori degli anni Novanta e un passaggio dal legno, per pochi, alla grafite, per tutti, mai digerito fino in fondo. Un po’ perché snob, molto perché avvezzo al bello destinato ad estinguersi. Poi il congedo.
“You cannot be serious”, disse in un giorno di gloria l’anticonformista John, rivolgendosi all’arbitro Fred Hoyles poiché in disaccordo con una sua decisione, suscitando nei presenti ogni sorta di sentimento e il suo esatto contrario. Se oggi, ancor di più al pensiero dei protagonisti stereotipati che ne hanno fatto seguito, l’esclamazione che a distanza di tempo fa ancora sorridere è soprattutto il titolo di una fortunata autobiografia, per chi ha avuto il privilegio di potersi dedicare al tennis una quarantina di anni fa rappresenta inequivocabilmente l’essenza e il manifesto di colui che il gioco erede della pallacorda non lo ha giocato, lo ha incarnato, spostando l’asticella su livelli non più oltrepassabili.

Perché, segreto di Pulcinella, la prerogativa dei geni è sempre quella di non lasciare le situazioni così come le hanno trovate e dopo McEnroe il risultato è un terribile senso di vuoto. Colmabile solo accettando che il mondo è davvero cambiato e non solo nello sport del diavolo, quello che prende in prestito le parole chiave dalle faccende di tutti i giorni. Del resto, parafrasando il sempre lucido Andre Agassi, un match di tennis è sempre una piccola vita e quando vale il viceversa nascono certi campioni.
Teo Parini
L’HABITUE DEL JET SET CHE TRASPOSE CARL SCHMITT DAI TESTI DELLA SCIENZA POLITICA AI CAMPI DA TENNIS
“L’associazione/dissociazione amico-nemico delineata da Schmitt si appalesa come categoria insieme diversità delle forme esistenziali, ma che nulla ha a che fare con l’uso strumentale della Verità e con l’odio personale”
“McEnroe è uno di quei giocatori che non possono essere trascurati quando si tratta di risolvere un quesito antico, stabilire cioè chi sia stato il più forte tennista di tutti i tempi. Premesso che la trasformazione del gioco e delle racchette rende impossibile una risposta credibile e convincente, credo che si possa indicare in McEnroe il tennista più geniale in tutta la storia di questo gioco. La sua magica mano sinistra sapeva ricavare traiettorie incredibili, rotazioni diaboliche, angoli che buttavano l’avversario fuori dal campo” Rino Tommasi
“Il più creativo dei contemporanei, in grado di prescindere dalla muscolarità dilagante dei nostri tempi. Mancino, capace di scoraggiare
Lendl, di sfruttare al meglio l’erba di Wimbledon (tre titoli) e l’atmosfera di New York (quattro titoli). Mostro di talento, di egocentrismo” Gianni Clerici
Abbiamo sempre pensato a cosa dovesse aver sentito Bjorn Borg, nelle sue vene glaciali quanto il sangue che vi scorreva, il giorno (o la notte) che incontrò lungo la sua strada Loredana Bertè. La figlia dell’austero professore di Bagnara Calabra, la sorella di Mimì, l’amica di Renato Zero, che fece letteralmente impazzire il mondo intero occhieggiando sinuosa dalla copertina di Playboy. Non possiamo rilevare il nome dell’amico artista che, in quei mirabolanti incroci d’inizio Ottanta (nel senso degli anni), ebbe il privilegio simil-divino di coricarsi la notte e risvegliarsi la mattina successiva nello stesso letto di Loredana.
(A beneficio dei vostri occhi vi proponiamo la video testimonianza di quando, una lontana notte degli anni Ottanta, al Cappello sulle Ventitrè, Paolo Mosca-il fratello di Maurizio- e Dalila Di Lazzaro presentano la Bertè e il suo lisergico brano ‘Jazz’)
https://www.youtube.com/watch?v=EcnbWxc1hkw
E non possiamo neppure rivelare, in ossequio all’eleganza, quello che ci raccontò. Ma fu allora che capimmo come mai l’austero svedese, proveniente dalla terra dove la socialdemocrazia aveva realizzato il modello politico più avanzato di assistenza ‘dalla culla alla tomba’, avesse letteralmente perso il senno (lui così glaciale e inumano in apparenza, sui campi di gioco) per quella donna che era l’incarnazione vivente della Femmina, direbbe Massimo Fini.
E perché partire da Borg e dalla Bertè per introdurre la grandezza diremmo ontologica di John McEnroe? Perché la sua grandezza (tra le tante) è aver trasposto la ‘diade’ amico nemico dai sacri testi della scienza politica all’erba di Wimbledon o alla terra del Roland Garros.

Perché Mac è Mac soprattutto in relazione (dialettica, burrascosa) con gli ‘altri’ da Mac: gli arbitri, gli avversari, i guardalinee, i piccioni (….), persino il Peter Fleming celebrato giustamente da Teo Parini come facente parte della miglior coppia di doppisti di sempre (McEnroe Fleming, of course, cui il nostro sempre lodato Rino Tommasi farebbe seguire probabilmente la mistica Flach-Seguso, o qualsiasi coppia dove ci fosse il giocoliere Mansour Bahrami, sotto in foto), che nella pellicola di Metz Pedersen (sofferta, e molto efficace quanto alla descrizione umana dei due competitor) litiga violentemente col compagno di doppio dopo essere stato triturato senza troppe cortesie (anzi, senza alcuna cortesia) dal suo ‘amico’ nei quarti di finale a Wimbledon 1980.

E invece, come ideale contraltare, mentre Borg si attorciglia e si consuma tra eccessi e follie per la Bertè, le sue ubertose e sterminate gambe e quella carnagione mediterranea che altera tutti i contatori emotivi ed umani dell’algido svedese, sconfinando dalle pagine sportive a quelle della cronaca rosa, il figlio di John McEnroe senior (l’avvocato d’affari di New York negli anni che Oliver Stone consacra e dissacra con Wall Street nel 1988: l’acme non dell’edonismo reaganiano, ma dell’unico vero decennio in cui il liberismo economico divenne e rimase dominante nell’immaginario collettivo) porta sull’altare Tatum O Neal.
La ricorderanno i cinefili più sofisticati, che l’hanno adorata quando da bambina- assieme a papà Ryan- commuove il mondo nella pellicola in bianco e nero che la consacra diva di Hollywood e ovviamente viene premiata all’Academy Awards: Paper Moon, Luca di carta.
Sono anni nei quali non è il jet set a entrare nella vita di Mac, ma è Mac a scombinare e dettare legge nel jet set, asservendolo alle sue regole e stregandolo con una delle sue volèe di rovescio, che facevano cessare d’incanto tutte le leggi della fisica.
Mac è Mac soprattutto per quello che trasmise al di fuori del rettangolo dove, consapevole che le gioie sono di gran lunga inferiori alle sofferenze, McEnroe non dedicherà poi così tanti anni.
Nel nostro pertugio memoriale ricordiamo di aver appena sfiorato il Genio nato nella Germania Occidentale al Palatrussardi nel 1990, quando Mac venne a giocare l’Indoor di Milano. Tuta bianca Sergio Tacchini e racchette a tracolla, ci sfiorò a testa bassa attraversando il campo. Ma era la versione cadente (in termini agonistici) di un Mac che aveva smesso la folta chioma riccia. Il Mac che tutto il Roland Garros di Parigi osanna, novella reincarnazione delle divinità greche nella terra dei Lumi, quando nel 1989- l’anno di Michael Chang e delle sue banane ai cambi campo- Ivan Lendl lo batte in 4 set agli ottavi, durante un incontro dalla caratura epica in cui Mac attacca la rete (sulla terra!) persino sulla seconda di servizio.
Finiamola qui, o quasi. Siamo abbastanza certi che l’estroso ancorché autoctono germanico Boris Becker, che neppure 18enne trionfa a Wimbledon nel 1985, abbia sinceramente ammirato la poetica di Mac, specie fuori dal campo.
Come tutte le persone che assieme all’irrequietezza capace di bruciare l’anima, al modo di Johnny Cash, riceve in dono una sconfinata (o comunque ridondante) intelligenza, Mac ha evitato di farsi consumare dal gioco.
Ben conscio della summa dialettica che un altro visionario sportivo come Andrea Trinchieri, allenatore di basket, disse al sottoscritto in un’intervista di alcuni anni addietro (‘chi fa sport a livello professionistico, come me, deve ricordare che noi non salviamo vite umane. E che nella scala sociale veniamo dopo, molto dopo, diverse altre categorie di uomini’), Mac si è protratto sino ai giorni nostri portando a spasso il suo sorriso, e la zazzera incanutita e imbiancata, da commentatore. Rivedendo di recente la finale Federer-Roddick del 2009 a Wimbledon, siamo rimasti colpiti dal frame in cui la regia inquadra in pochi attimi il parterre de roi di quel giorno (Borg, Edberg, Nastase in compagnia di una svenente 25enne, Pete Sampras, Andre Agassi, Mac con le cuffie alle orecchie), dando l’immagine plastica della più sconfinata grandezza tennistica mai riunita in pochi metri.
Ma è l’aver tenuto a freno l’irrequietezza estrema, cadenzandola passo dopo passo sino a tramutarla in un’esistenza felice tra mogli e figli (per quanto possa essere pacifica la convivenza tra la vita quotidiana e l’anima di uno come lui), la più grande vittoria di John McEnroe, capace di preservare la sua inusitata e irripetibile grandezza. Relegandola ai ‘few happy years’ della giovinezza guascona, senza farsi travolgere.
Del resto- al figlio dell’avvocato d’affari della Grande Mela, allo sposo di Tatum O Neal, all’ospite dei più seguiti show americani sin dalla tenera età di 21 anni- risultò più facile che ad altri ‘catapultati’ dall’anonimato (o alle tetre patrie dell’Est Europa pre 1989) alla celebrità agonistica e sportiva.
Colta la sua grandezza nella dimensione dell’ostilità e della diade ‘amico nemico’, a Mac non rimase che cogliere i frutti della sua mirabolante campagna da guerriero della racchetta.
Conscio che anche per i grandi condottieri viene il tempo di ricercare quel barlume di equilibrio davanti al fuoco acceso dell’accampamento, e della Legione. Il momento in cui dire ‘basta’, anzi ‘è bastato così’.
Perché a John Patrick McEnroe s’addicono alla perfezione le parole che un altro gigante (Billy Wilder) mette in bocca a Gloria Swanson in Viale del Tramonto, distillando l’immensità della vita in poche parole e piani sequenza, come solo il cinema sa fare:
” Ma voi siete Norma Desmond, la famosa attrice del muto.
Eravate grande”
“Io sono sempre grande. È il cinema che è diventato piccolo”
Trasposti tempo, luogo, azione e contesto, di John Patrick McEnroe junior si potrebbe dire (quasi) lo stesso: se anche il tennis dovesse diventare più piccolo, lui rimarrà per sempre grande. D’una grandezza tutta sua, propria della stella che gli Dei del Tennis catapultarono dall’Olimpo alla terra (rossa, verde e cementata), nonostante l’umanissima bizzosità.
Fabrizio Provera